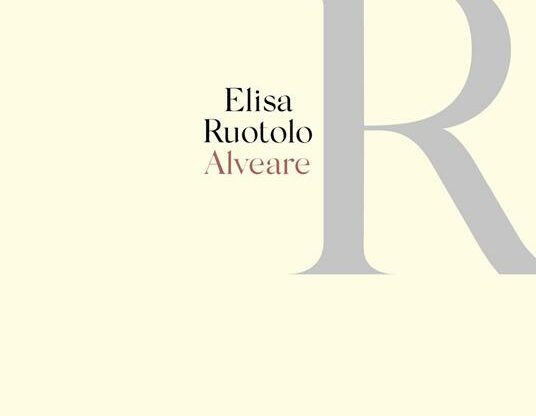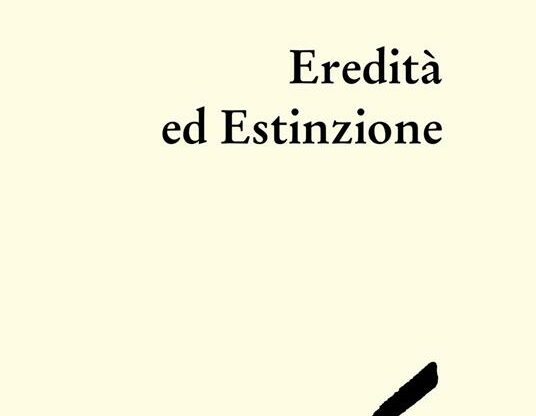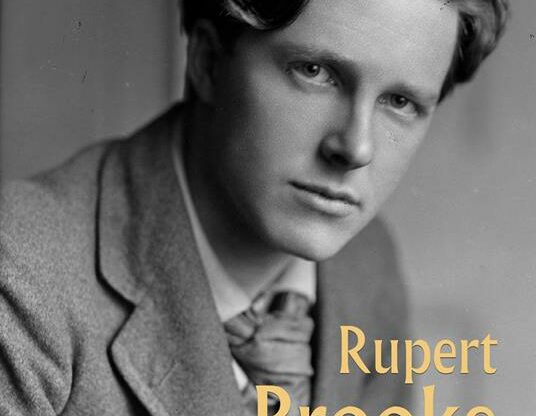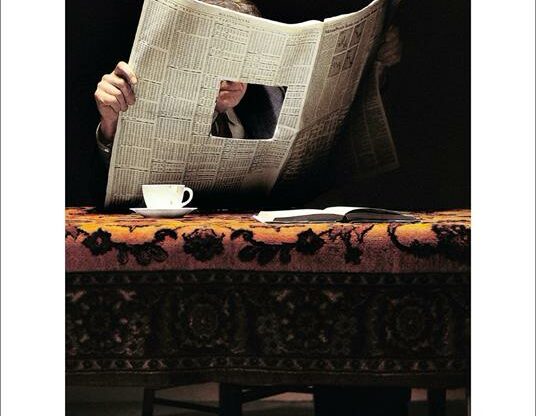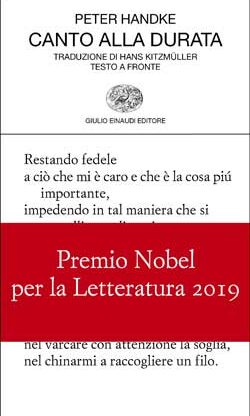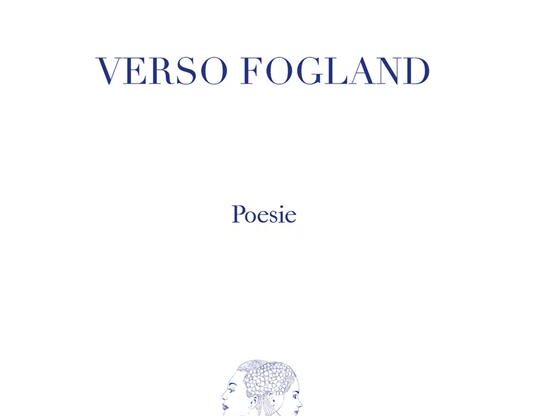L’alveare di Elisa Ruotolo (il nostro)
Di Rossella Pretto
Forse è solo la dolcezza che lega questa tua frequentazione milanese di Alveare di Elisa Ruotolo (Crocetti, 2023, pp. 96, euro 12). Due incontri al caffè Scaringi con la cioccolata davanti (non il miele), in due diverse forme, nella classica e invernale, densa cioccolata calda in tazza e in quella più densa ancora che si solidifica in muffin, comunque sia cioccolata, cibo degli dei, dice il tuo amico Francesco con cui discuti leggendo alcune poesie della raccolta, discuti di quei suoi versi costruiti per accumulazione, nota lui, e tu pensi intanto che siano strappi accuratamente inflitti. Una crudeltà scientemente perseguita e con esattezza chirurgica che riesce a penetrare il glomere delle api strette tutte in un grumo indistinguibile «ventre nero, dubbio di vita» in cui «la resurrezione è remota»: «La morchia della terra mescolata all’umore / l’innesto del sonno sul moto mercuriale dei corpi / la breve paga del riposo, ci annodano in un torpore / ingordo, che distanzia ogni amore di veglia». Crudeltà, dicevi, e con un senso preciso, quello della rivelazione della peste artaudiana che serve a «rimettere organicamente in discussione l’uomo, le sue idee sulla realtà, la sua posizione poetica nella realtà».
In più, come la peste, il teatro artaudiano è un formidabile appello a forze che riportano lo spirito alla fonte dei suoi conflitti attraverso l’esempio, e se le possibilità che mostra sono nere, la colpa non è della peste o del teatro, ma della vita, insegna ancora Artaud. E ti serve per addentrarti in questa lettura tanto complessa perché magmatica e incerta ma aderente alla necessità dell’interrogazione e alla restituzione di quell’atto coraggioso. «Vivere è disfare l’eterno / è scoprirne la menzogna» scrive Ruotolo. E questo significa ipotizzare che il dio della Città è solo o inguaribilmente piccolo: «Sarà solo anche lui, il padre / nostro se condanna la Città a essere folla. / O inguaribilmente piccolo, se per rivalsa / la castiga alla moltitudine che gli è negata. / Ma un padre eremita o bambino aggiunge solo tormento, / ombra / e un silenzio / che a noi che siamo gregge / non arriva». Un affondo terribile! Mentre noi sappiamo che quel dio-apicoltore si definisce «imperfetto e fragile» perché legato alle sue creature tramite il bisogno che genera identità, sopravvivenza e identità. È necessario quindi, riprendi, passare alla crudeltà come assoluto atto di rigore, di necessità implacabile: un atto generativo, in definitiva, connesso alla possibilità di continuarsi e di farlo attraverso un’espressione totale in cui si riconsegni al linguaggio la pienezza e la complessità del suo consistere trasformando le singole parole in sortilegi. Fin qui ci siamo. E credi che tutto questo abbia decisamente a che fare con Alveare e la sua poesia. Ti ricordi, inoltre, di quel silenzio dove coagula l’unica forma pensabile di rivelazione, perseguito ed esplorato da Stefano Dal Bianco. Ciò che trascende avviene nel silenzio e lì, forse solo lì, possiamo sperimentarlo vedendolo dileguare. Il silenzio inoltre si accasa nell’immobilità, in ciò che contrasta con la vita, vi collide e si scorna. Il mondo dell’alveare non ha di queste possibilità, se non nella vita potenziale dell’inverno dove tutto si azzera: «Ogni voce è persa e dagli occhi non arriva / grazia». Ma poi, poi si slabbra la luce che rompe il buio-madre. Ed è appunto la peste della moltitudine, il movimento inesausto, lo stridore del lavoro che specializza ma non accomuna, e quindi degrada. Degrado e difetto dell’esistenza. Qualità e sua natura. «Dalla culla al dovere esiste un passo appena / e lo colmi nascendo / imparando che niente di ciò che vive / è facile». Così questo apprendistato alla vita sarà anche apprendistato alla lingua, «un educare la voce a fare / da lingua madre» perché qualcosa, in quei corpi che pesano nulla, valga ancora all’interno del «roveto che scotta d’ira», la collera scatenata per una nascita imposta e non cercata, ma sofferta. Il rifiuto della nascita, dunque, dice Francesco, fantasia regressiva che riconduce al buio-madre intrauterino e a quella pace spezzata. «Generare è imporre un destino / di albe calcolate – chiedere non si può perdono / né ubbidienza». Poi il taglio e la collera contro dio. Per l’affronto dell’esistere. Corpo corruzione d’immondezza. Ma anche rabbia per un destino inattingibile che sconfina con il caso e che assegna all’ape regina la sua verticalità («perché io?») e alle altre concede la di-sperazione di non avere scelta, essere moltitudine: «non esiste un potere singolare / contro il morso selvaggio della pluralità», con un bisogno scoperto quasi impossibile da ascoltare nella sua nudità agra: «volevo essere amata». Entrambe lo volevano e lo vogliono ancora. Condannate a non esserlo: per difformità, la prima, per troppa conformità, la seconda. Respiri, in questa agnizione che sai. Il teatro funziona, quello pestifero di Ruotolo fatto di umori rimestati, di bile che spurga nel corpo solo per dire che tocca starci. Medica catarsi. E allora il punto diventa: «Durare in questo tempo indifeso / è un desiderio che mi vanga / ogni pienezza».
Il giorno dopo invece, torni con il cane Teo a sederti al bar milanese (milanese-pugliese), il caffè Scaringi, mentre due ragazzi o studenti universitari parlano di Mnemosyne e del Tempo nell’antica Grecia. Al tavolo affianco, un ragazzo e una ragazza si confrontano, forse come atto d’amore, d’amore per la conoscenza e amore erotico. Il miele delle parole che impiastra i loro sguardi e dimostra pieno il legante tra spinta intellettuale e spinta del cuore. Una tua proiezione? Può essere. Comunque sia, spinta che costituirebbe l’uscita dall’alveare, perché lì dentro tutto è scippo e arsura. Non vi è passione ma un fare frenetico che partorisce il mondo, cosmogonia. E un principio madre partoriente il tutto, l’ape regina, unico esemplare fertile della colonia e dunque tutelato e prigioniero, ventre difeso e abusato, come nel Racconto dell’ancella di Margaret Atwood. Mancano le Muse esiodee che guarda caso sono figlie di Zeus e Mnemosyne, che sanno raccontare molte menzogne simili al vero, ma anche cantare la verità. I ragazzi parlano del cambiamento del paradigma temporale al mutare degli strumenti percettivi dell’uomo, in relazione a una società che si impernia su valori di tipo eroico, dapprincipio, e poi trascolora in altri più adeguati all’uomo comune. Due modelli incarnati nelle figure dell’ape regina e dell’operaia, con le loro solitudini, pensi. Un tempo umano che, all’interno della Casa del Miele, è fatica e spreco e innerva le varie figure corrusche (la bottinatrice, l’architetto, la magazziniera ecc. con le loro ‘opere’) e un tempo che si nutre di crolli, che si pencola sulla polvere e anela al ritorno, eterno. «Creazione è un precipitarsi alla rovina / è turbamento, ma perché la materia ci confonda / in profondità deve averla affollata / lo spirito». Ed ecco qui che si affaccia un Dio in maiuscolo, perché «credere in una casa significa / ipotizzare Dio». Poco importa che sia uno di quelli scombinati da Dio esiste e vive a Bruxelles, il film. Conta l’ipotesi. Una fede, pur fiacca, nella possibilità che la peste si ammali di vita e che la forma di durata sia impressa nel ciclo, tutta l’eternità possibile. «Non c’è fine che contenga tregua / solo un inquieto rinascere e risorgere / si leva alto dalla terra in secca / sale dalle frasche prosciugate e dai rivoli in ristagno / dalle bestie agguantate nella corsa / o nelle ore nuziali». Così è quel simbolo di risurrezione – intanto i ragazzi parlano di Empedocle e Pitagora – che ricordi anche nel rimescolio omerico di Alice Oswald, con le api che risalgono dalle crepe rocciose della terra, «Miriadi d’operaie in volo a suggere fiori / Che nascono e rinascono luccicando sui campi». Per amore. Vita. Le ultime parole della raccolta di Elisa Ruotolo. Ed è qui, allora, che comprendi quale sia l’attrito da conservare con devozione, lo stridore che penetra dai lembi di carne mai cicatrizzati: è questo che ti commuove e consideri nobile, non il piagnisteo ma il lamento dignitoso alla greca. Quel suo fare della parola rito, accedendo all’originario.
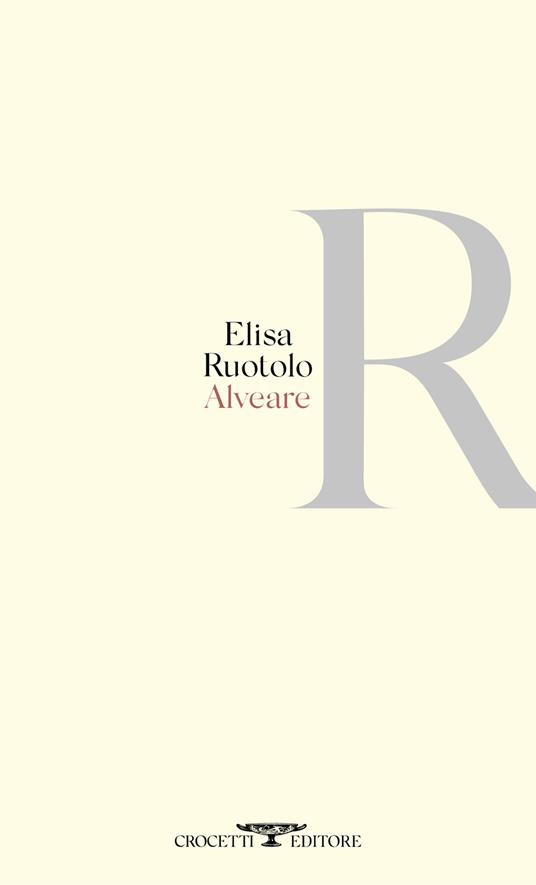 Alveare
Alveare
Poesia
poesia
Crocetti
2023
96 p., brossura