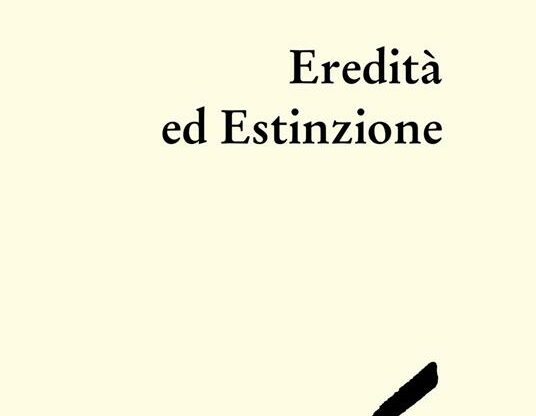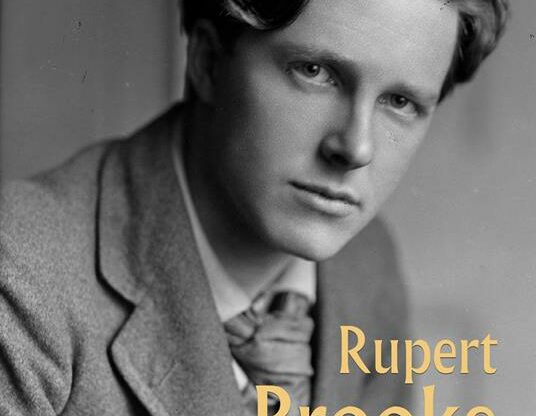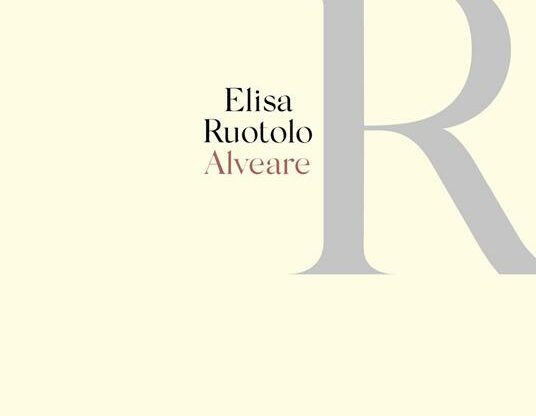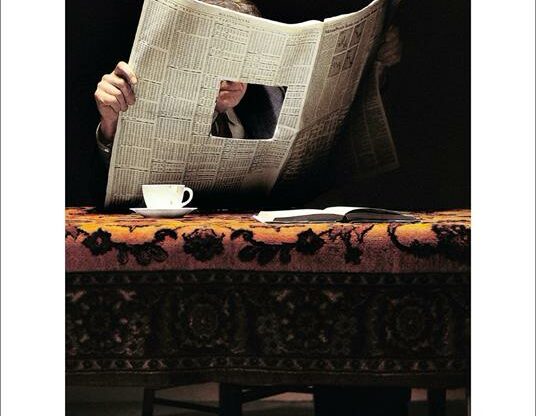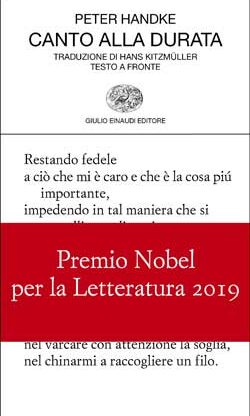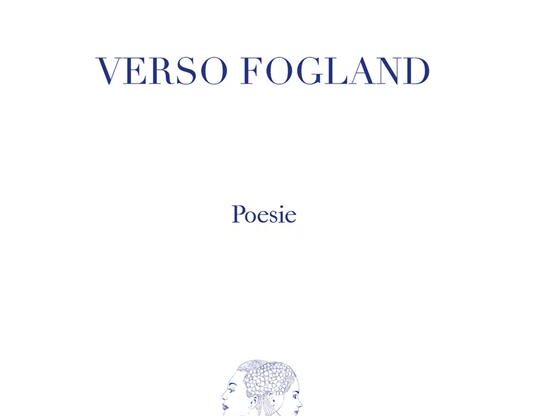Come Wonder Woman tra Villalta e Rondoni
Di Rossella Pretto
Si deve dire l’origine, non per forza l’appartenenza –una cosa come favorire la carta d’identità e un vissuto. E l’origine presuppone una durata: da quel gorgo a questo grumo di presente.
Giammario Villalta sceglie la spirale per rappresentare la distanza dalla condanna alla resurrezione. Dici così solo perché sono 15 i movimenti che allestisce nella prima parte del suo Dove sono gli anni, uscito quest’anno per Garzanti e accolto, giustamente, come il suo capolavoro, esattamente come le stazioni della via crucis, se si accetta come proposta per la quindicesima quella appunto della resurrezione. Ma non sai se qui ci sia resurrezione. Anche perché la seconda parte si apre e si snoda intorno a ‘La solitudine della specie dominante’ con le tre belle sezioni dedicate a Ibisco, all’Orso maritimus che vaga alla deriva e infine a quella quarantena perenne ed esposta della natura umana/disumana che considera l’uomo in quanto specie (specie non singoli, inestricabili sussurri, dicevi tu) e paradossalmente lo isola. Una natura che si nasconde in una voce che tace. Eppure le voci, qui, la voce (limite, estrema) è così presente, come un graffio che interrompa il cielo, uno sbrego nel tessuto metafisico. C’è morte, sì, quella ferita sanguina, ma resurrezione? No, propenderesti per il no. Anche se vorresti tanto, ti piacerebbe sperare, anche solo sperare, che il poeta sia un salvatore. E in fondo lo è perché ti affratella. Nient’altro? Nient’altro. E magari basta, almeno per un po’. Perché fa risuonare la voce («mia/non mia») che si nutre della lingua («che non è mia / e mi fa appartenere»). Spossessante ma religiosa, nel senso di un legame che apparenta, di una cura da prestare e prestata.
Sembra un film in bianco e nero per quel velo di disperante finitudine delle cose unita al loro lato residuale che addolora. Un battito di ciglia e il tempo crolla, si tuffa nell’imbuto e in meno di un secondo riaffiora – diverso – a ritmo con le ciglia che hanno battuto ancora. Plink- ecco il bambino con la maglia a righe – plink – ecco l’uomo, e la maglia a righe c’è ancora – un oggetto testimone di un accadimento che sturba – sei tu? Chi è quel tu che riconosci e no? Nel paradosso di sentirsi aderire all’alieno – percezione impazzita che deraglia – chi è chi? Dov’è, qual è il trait d’union? Dove sono finiti gli anni. Sono andati come i salci. «Sulla costa dell’acqua stagna i salci se ne sono andati / dov’è andata la tua maglia a righe e la roggia di casa». E che succede se il residuo salta? Dov’è la traccia, dov’è, chi è, chi sei…
Tu non sai se ti chiedi chi sei, credi che la risposta sia già assodata e consapevole della frantumazione, della fessura da cui passano i laser dei tempi e dei desideri, soprattutto quelli degli altri, e i falliti, e una cassa di risonanza di voci, questo sì. Ma capisci, molto bene, sai cos’è una terra intrisa d’acqua e brividi umidi appesi sopra i fossi, scoli di terre che hanno righi di pianto come canali di versi, quello stupore che esplode in malinconia impastata alle ossa, marcia radice di un sorriso che buca la nebbia e cola, sgoccia a stamparsi sull’asfalto tra periferie di miraggi. Niente di che, solo solitudine di bocche aperte nell’aria che stagna tra città e campo. Tra il distributore di benzina col suo alito alcolico e l’ombra di vino nel tozzo bicchiere che mani grosse afferrano e scolano. Dai che non senti più niente, dai che la vita ti passa. Sopra. Come un autotreno all’una d’estate o come un pantano che inghiotte gli anni perduti e perennemente in perdita, goccianti. Inghippo, inghippo della testa, groppo del respiro intasato da lana infeltrita che punge. Sì, punge la pelle, punge le gambe e tu non vuoi metterla, mettere le calze per essere vestita da Wonder Woman, mettere la maglia di lana, sei piccola ma il petto lo vuoi incidere di lettere, come un’eroina – che non è una droga, ma legittima appartenenza. Forse non origine, forse, ma appartenenza, questa volta. Eroina. Wonder Woman.

E sfilare accanto ai carri di carnevale, in quegli anni finiti dove, non sai, ancora intima con una casa, quella della nonna Caterina che aveva davanti una strada che sembrava pista di decollo, non di certo un’autostrada, ma quel rumore giorno e notte e i doppi vetri, doppi non nel senso di oggi, ma proprio doppi, due infissi per tentare di arginare quel via vai inesausto. Dove andavano sempre quelle macchine, chi c’era dentro? Dentro la casa, ad esempio, c’era la nonna, cento anni ha compiuto piangendo, commossa da una vita che poi è troppo grande per tenerla tutta, prima di andarsene. Ma non in quella casa, ha dovuto lasciarla andare in malora e starsene sui colli. Oh che bello e che bellino, eppure gli anni così sono volati, se ne sono andati, scivolati lungo la roggia che aveva di fianco a casa e non poteva più vedere. Quella casa dove c’era l’orto e un tempo le galline e, dietro, il fico che si arrampicava fino al terrazzo. Hai ambientato lì il primo racconto che tu abbia mai scritto ibridando casa tua (alle pendici dei colli) con quella. Quella, dove potevi sbucciarti le ginocchia a correre nel cortile di cemento bucato dalle aiuole che gridavano sgargianti con le loro bocche di leone, che se ci premevi al centro si spalancavano a ruggire di colore. E tu sorridevi, piratesca e ignara, gridando terrorista per le strade, issata sulle spalle del padre che tentava di farti star zitta perché del terrorismo erano appunto gli anni ed era meglio non gridarlo in giro. Sei tu quella, sei ancora tu? Forse non eri questa nevrosi, o solo in potenza. «Prova e riprova, scava la mente, / finisce che impari, lo diventi quell’altro, che non volevi, / ma non del tutto, non completamente. / Più tardi / sei fatto gente tra tanta gente, il sosia / riuscito, finalmente, il tu assoluto, assolto, e all’altro / la voce, le mani, la voce soltanto», dice Villalta. Ecco cos’è quella voce, a tratti dialettale, un “sigo”, un grido che sgraffia come «la foschia impegolata sui rami». Quella voce che pare una bocca aperta da cui non esce fiato, come quella di Munch, un contorcimento, più che altro perché «non bastano i desideri / a colmare il vuoto del nascere». E in tutta la durata del vivere una domanda. E in quella domanda una durata. E cos’è? Un dolore che è eterno? «che eterno / è il dolore degli uomini – volevi scrivere – / e fatto proprio di quello (speranza, orrore, felicità) / che ci confonde e attraversa». Senti tirare le corde vocali, quei nervi, bruciano gli occhi e deglutisci. «Che cosa ci stiamo a fare ti chiedi / noi qui, portati via da noi stessi – chi c’è / oltre la soglia – chi inventa la voce che fa male, da dove?». È un po’ come la storia di Alice Oswald e del suo Nobody, non si sa da dove venga la voce. Oswald riprende il dettaglio omerico riguardante il poeta assoldato da Agamennone per spiare la moglie Clitennestra durante la sua assenza. E che Egisto fa trasportare su un’isola deserta per sedurre la ‘cagna degli Achei’, come la chiama Omero. Mentre Penelope rimane fedele a Odisseo. E Oswald scrive: «Questo poema vive nel gorgo tra queste storie. La sua voce è spinta dal vento, erosa dall’acqua, come se qualcuno, prefiggendosi di cantare l’Odissea, fosse però confinato su un’isola petrosa e non scoprisse mai la fine del poema». Da dove vengono i frammenti che si sentono? Sussurri, ondate di crimini, sbocchi di sangue. O solo durata interrotta, immagine sbilenca, tagliata. Come l’assonanza dialettale tra vero e vetro logorato dall’acqua, nel libro di Villalta, i frantumi: la conoscenza e il vero transitano per quei cocci. L’autenticità. D’altronde è ciò che ci ha insegnato T.S. Eliot: «Quali radici s’aggrappano, quali rami crescono / Da queste macerie? Figlio dell’uomo, / Tu non lo puoi dire, né indovinare, poiché conosci solo / un mucchio d’immagini infrante…». O ancora, per dirla con Villalta: «Il cielo rimena / macerie. L’erba è stremata. Tu non capisci tutto / ma sei sicuro che capiscono te / le parole che un uomo ha scritto e ti immagini / la sua vita…». La vita di Zanzotto, quel maestro. «Sei diverso senza essere diventato mai altro», dice poi Giammario Villalta riprendendo il filo della radice che continua a interrogare.
E lo sa anche Davide Rondoni, che però sceglie una strada differente per raccontarlo. Usa la prosa, prima di tutto, nel suo Il concerto del viale dei lecci, uscito da poco per Aboca. E i suoi di anni dove sono? Sono finiti tra i rami dei lecci, quelli che costeggiano il viale che dalla stazione di Forlì porta fino a Piazza Vittoria, il viale Mussolini, oggi viale della Libertà. Quei lecci neri e fragorosi che risuonano di voli, anni e strepiti dove il nonno Enea ha sognato e poi costruito il suo palazzo, la casa. A un certo punto si deve dire l’origine, non per forza l’appartenenza – una cosa come favorire la carta d’identità e un vissuto. E l’origine presuppone una durata: da quel gorgo a questo grumo di presente.
E Davide Rondoni la casa l’ha trovata e la sente nell’accento e nella libertà. La sente anche in quegli anni che rincorre e in cui si tuffa. Senza paura. «Io ora sono un ragazzo alla finestra. Quel giorno da cui parlo, e che va avanti e indietro nel tempo come fanno in cielo gli stormi sui lecci, ho circa diciotto anni. Mio padre se n’è andato di casa, ma non l’ho mai odiato per questo. Mia madre è una donna bella e piena di energia. Mio fratello ha un temperamento molto più saggio di me. Mia sorella custodisce luce e sofferenze. Io invece scrivo poesie». C’è grande respiro. E un sorriso che slabbra qualsiasi sofferenza, qualsiasi lagna. Perché Rondoni sa distinguere le ferite e il rancore. «Non sono necessariamente legate. A volte dalle ferite non nasce il rancore. E pure il rancore non è vero che nasce sempre dalle ferite. A volte viene da prima, da altrove, e le usa, le allarga e inasprisce. Se ne nutre». Tanto che viene voglia di abitarci, laggiù, tra gli accenti – che poi sono un po’ come da piccoli si disegnavano gli uccelli, sì, una sorta di accento volante. E non è vero che il dolore non c’è. Eccome se c’è. Ma ha una stoffa diversa, come più viva e tenace che quasi quasi vien voglia di crederci di esserne capaci, capaci di arricciare il naso e andare avanti diradando le nebbie. Perché casa può essere anche questo. Non che tutti non lo vorrebbero. Ovvio, no? È che alcuni sono cresciuti con un senso di inquietudine che fa ormai parte di loro. Però l’orgoglio per chi ha uno sguardo limpido non viene mai meno, soprattutto perché in quella casa che il poeta restituisce a tutti c’è un senso di storia, la durata perdura. Dal viale dei lecci passa Mussolini, passano le BR, transita Marta, la figlia morta di Enea, e ci cammina una figura losca che vuole uccidere il nonno, una sorta di vecchio pugile sfatto con cui lui stringe un accordo di cui nulla si sa. Ma per capire qualcosa di più bisogna leggere il libro. Tu l’hai letto e ti ha accompagnato in alcune notti insonni di mugugni. E ti ha fatto bene. «Passano torme di ombre e fantasmi sotto il viale dei lecci che grida e risuona». È un tutt’uno. Ecco, qui forse la quindicesima stazione è presente, ve n’è la certezza fin da subito perché quelle onde calde e morbide sollevate dai lecci, pur se neri contro la notte, sono sciabordio di un’acqua che consola. «Ecco, la solitudine dei lecci che restano allineati, feriali, neroverdi, pieni di durezza e di linfa mi conforta». E ancora lo pensi e lo dici: viene da sorridere perché si riesce a empatizzare con il dolore più grande che ci sia, quello del nonno Enea che ha perso una figlia di 22 anni per un incidente di macchina, ma come fosse qualcosa che si può gestire, che non annichilisce, perché poi magari si ha accanto uno strambo nipote che fa risplendere le giornate. «Nella stessa auto siamo un punto di giovinezza sfrenata e il dolore più grande del mondo che va su per le colline romagnole». Il dolore enorme e la giovinezza senza sponde si compensano, dolcemente si pareggiano. «La poesia per me arriva ancora così. Una strana creatura sotto lecci strepitosi. Un Icaro inchiodato al proprio corpo. Un altro genere di ‘scultura’», racconta Rondoni, con la convinzione che la storia sia l’anelito alla gioia, non alla libertà, perché dove c’è gioia c’è vera libertà, di decidere, farlo sempre e portare la propria parola nel mondo, attraverso l’azione. «I lecci saranno color sangue. Il grido degli uccelli sarà color sangue. I lecci rifaranno il nero. Lo rifaranno con le grida primarie delle vite dei nidi. Lo rifaranno nuovo, meraviglioso colore di tutti i colori e non solo tenebra. Nero da spaccare sempre con gli occhi. Coi baci, con le preghiere, con le bestemmie, con la gioia. Con tutto quello che non finisce qui. Saranno muti e fragorosi. Saranno il corridoio delle storie, il corrimano delle tempeste, il pettine dei cambi di potere, le costole del fiato della corsa degli anni».
Non c’è molto altro da dire se non un’ultima questione da considerare, quella dei nomi. Così importanti. Nel libro di Rondoni, il nonno Enea fa una strana consegna, gli consegna cioè i nomi. «Li portava via alla morte. I nomi e il suo amore attaccato a quei nomi». È esattamente quello che fa lui. Ci affida i nomi delle persone amate, dei luoghi cari, la loro storia. Li rimette a noi. Nel libro di Villalta, invece, il tempo transita attraverso il corpo, lo buca e ne fa varco: «Che abbia bisogno di un corpo ossa budella un sesso / e le vene la merda è inaudito che tutto il tempo / abbia bisogno delle tue povere mani per essere qui». E questo però segna una pietra di guado differente. «Sei uscito per strada con la tua vita in gola / per gridare e nasconderti dentro la furia immobile / che da là sopra chiamava, chiamava, tutto era tuo nome». Qui non è il nome, ma la lingua, a restituire lo stigma dell’origine. In “The Real Names”, Seamus Heaney parte dal ricordo delle rappresentazioni shakespeariane messe in scena al St. Columb’s College per far spaziare l’occhio della mente tra palcoscenico e vita: quell’esistenza che, nello scintillio incerto della giovinezza ormai lontana, si fa tanto intensa da portare il poeta sul tetto della stalla «che guarda il per sempre», senza però sapere se nome e ruolo coincidono o si confondono nel lenimento della memoria che riprende fiato, come in un atto performativo, all’alzarsi del sipario, facendo balzare fuori tutta una serie di figure indimenticate. Le parole sono «capocchie di spillo / Nella densa oscurità dell’universo. / Verso unico da cantare lungo la linea della vita»: da riproporre ancora e secondo un loro ritmo. Intonare l’orecchio permette di conservare la memoria e ripeterla per non soccombere alla progressione rovinosa del tempo, come ricorda Ulisse ad Achille nel Troilo e Cressida shakespeariano. I nomi di persona, i nomi delle cose, i nomi dei luoghi: bisogna ripeterli tutti per conservarne memoria. Lo fece sempre, Heaney, per tornare a casa o «nel porto natale» di un abbraccio. Nominò le località: Anahorish, Toome, Boagh, credendo che l’idioma renda singolari e «centrali», perché: «The poet always raises the energies of a subculture to cultural power». Si fidò della loro intrinseca solidità: «Nomi portatili come pietre d’altare, elementi non lievitati». Poetò il catalogo delle strade, dei pescherecci, laddove un porto ispessisce la parola e la rende chiara come il cielo, perché «noi crediamo ancora a ciò che sentiamo». La memoria da consistenza e la dimenticanza spaventa. La memoria scatena il ricordo, ancora, grazie alle sue trame e agli appigli, alle associazioni fisse che insegnano «a leggere il proprio contenuto / in un ordine significativo»; la dimenticanza, pero, essendo una porta sul buio, permette l’arrivo della poesia, che sgancia il vissuto personale, lo depura e ne fa canto, musica di ciò che accade. All I know is a door into the dark. Dimenticare fa dunque parte di quel compito cui il poeta e chiamato: dimenticare per suonare la propria nota. Ma dimenticare e anche fondersi in amore – del compito e del creato – dono spirituale e santo. Come in “San Kevin e la merla”, quando Kevin, solo nella sua cella troppo stretta, allarga le braccia che escono dalla finestrella: lì una merla depone le sue uova. E allora quel santo si sente «maglia della rete della vita eterna», si dimentica di tutto e ancora prega: «Una preghiera tutta corporale / perché lui ha dimenticato sé stesso, dimenticato l’uccello / e in riva al fiume ha dimenticato il nome del fiume».