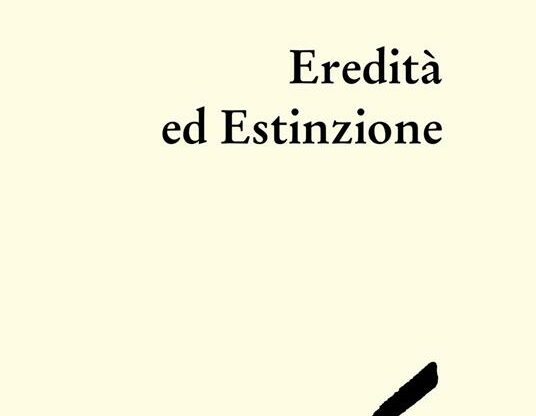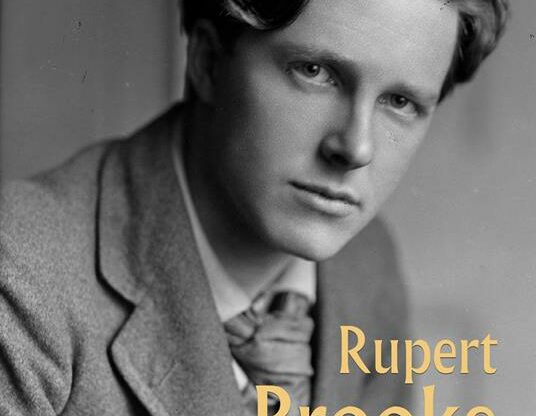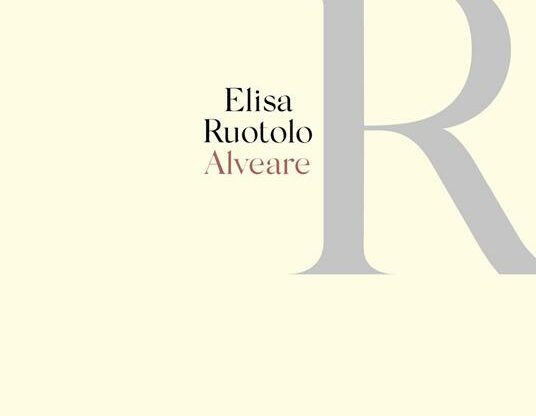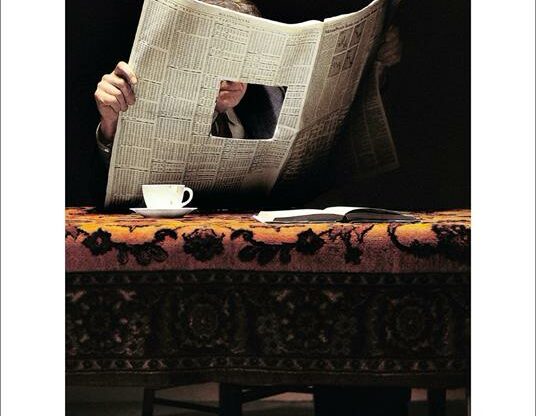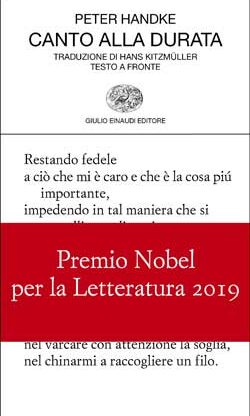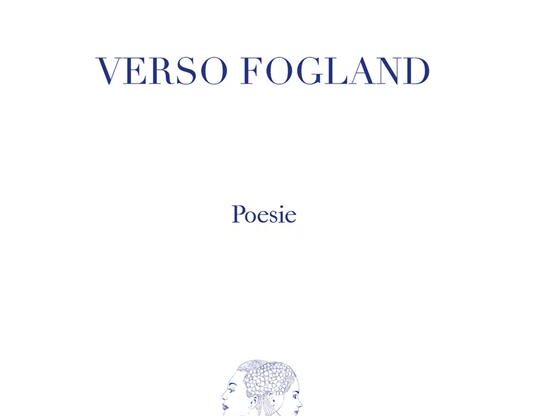Il corpo di pane di Elisa Ruotolo
Di Rossella Pretto
È un corpo ferito che non si sottrae, in luce e piagato, un corpo di pane approntato perché tutti ne mangino. Mostrandolo, Elisa Ruotolo vi aderisce, presta la carne, quel tanto che ha e sottile, venata di un respiro che trema ma fiero, perché testimoni. Che cosa? Un passaggio, un disagio, una cresta di pelle precipitante, picco e taglio. Una leggerezza soltanto. Di spirito artigliato dal mondo. Incomprensioni, si dirà. Accidenti che accadono incarnandosi. Ma di più accadono a chi dispone quel corpo a farsi banchetto. Perché mangiato sia rimesso in circolo, e sia ancor più spogliato, ma dei personalismi che l’hanno inciso. Perché più cade e si inquina e si macchia, più si trascende e apparenta. Si fa impersonale, alla Weil. «Il passaggio nell’impersonale si opera solo mediante un’attenzione di qualità rara, che non è possibile se non nella solitudine. Non solo solitudine di fatto, ma anche solitudine morale», scrive la filosofa. E allora, quel dolore che spazia tra le cellule è meglio tenerlo per sé e non farne commercio. «Il giorno in cui guarirà / gioitene moderatamente / come si fa coi miracoli / che non concedono per sempre / non risolvono / perché lo sanno anche i santi veri / quelli senz’altare / che la carità- quaggiù / non esiste».

Si parte così. Per dire di ciò che è nascosto appena al di là della superficie. «Avete scelto il difficile / di non vedere le mie incrinature / per potermi amare come fossi sana / mai malata appestata mai spezzata / come invece sono / in febbre in peste in pezzi».
E allora è necessario disporsi al sacrificio, alla testimonianza. «Ho un cuore da fornaio – tutto infarinato d’un bianco / che sporca ma non dà purezza / solo pane». Un cuore di pane che deve trovare un senso e disfarsi. «Non resterà nulla di mio al mondo / e questo è pace». Un cuore d’agnello, insomma, che si dia non solo nel bel gesto ma che aspiri a essere di tutti, o meglio, come tutti. In quella tenerezza, non solo nella rivendicazione, ma nella fragilità.
Dentro ho una scatola nera
da aprire dopo il disastro
– quando mi sarò poggiata di schianto
sulle rocce o nei fianchi di un monte
mai guardato
per troppa luce
per troppa paura
per poca vita che imploro
e per il silenzio voluto
adesso che sono rumore
da cui proteggere gli orecchi.
D’altronde, c’è un errore anagrafico: «Non è vero che sono nata. Io sono ancora raccolta in me / come un gambero mai mangiato, un gomitolo dal refe nodoso». Perché «Io sono quella mai nata / e che ancora può scegliersi un cuore / le mani giuste / un ventre senza ombre / un destino ingiudicabile – alla cordata finale / un’eternità trattabile». Non so se ci sia questa scelta, si può solo scegliere l’obbedienza, probabilmente, disporre il ventre in maniera differente. In ascolto. Ecco allora quanto dovuto in Corpo di pane (Nottetempo, 2019)…
Prendo queste parole dal loro nadir
dal ventre cavo in cui le tengo segrete
– le prendo e le stendo alla luce.
Sanno di chiuso e antico
di cantina e baule nel solaio
dovrei nettarle prime di offrire, ma io
domando fede in cambio d’imperfezione.
E che le amiate a vuoto come per errore
anche se v’indolorano le giornate.
Non offro capriole o salti di bambini
ma polveri e fiati rugginosi.
Intorno è movimento e nuovo
le parole altre sono liquide e morbide e ancelle
– Sassi di fiume non rocce da scortico.
Il tempo mi è cresciuto intorno contro ogni riparo
mentre andavo alla morte senza acrobazie
o diventavo trucioli di legno
avanzo e limatura che la saggina raccoglie in mucchio
e spazza via dalla soglia.
Scrivere è scomparire
perché lo avete dimenticato?
Dice ancora Simone Weil che «ascoltare qualcuno significa mettersi al suo posto mentre parla. Mettersi al posto di un essere la cui anima è mutilata dalla sventura, o in pericolo imminente di esserlo, significa annientare la propria anima». È vero, ma lo è ancor di più nell’assoluta aderenza al proprio destino, alla propria storia che si fa stile e che, appunto concedendosi, dilegua e permette l’ascolto depurato e la sorellanza.
È così che intendo prestare le righe che seguono, scritte da me per me, appena due giorni prima di ascoltare Elisa Ruotolo al teatrino di Villa Floridiana, a Napoli, per mettere in comune un sentire che è
Aderenza
a una verità (sempre presunta) che tenti di rendere testimonianza di un cammino di conoscenza che va perfezionandosi (forse). La scrittura, se consapevole e ardita, cerca di illuminare il cono d’ombra di ciò che sfugge. Non riuscendoci aggredisce il buio lanciando un SOS con il corpo-kamikaze. Un bengala nello scrigno desiderante della mancanza delle stelle.
Aderenza
al progetto e allo strumento che lo esperisce – questa persona di carne, e amara, che porge l’atto di fede necessario all’apparizione dell’istante-di-sé permettendo al contempo il manifestarsi di un invisibile che si dà per strappi. E dunque cocciutaggine e fedeltà alla parola che mima la morte, fondativa del mistero. Un atto di scasso, un latrocinio tentato, anche se quel mistero che trama l’essere umano rimane salvo e inattingibile nella sua pienezza, adagiato su un trono ricamato di respiri e concrezioni: sindoni plurime e sovrimpresse del passaggio di vite perdute e quasi combacianti, se non fosse per uno scarto…
….
Seduta a un bar di piazza dei Martiri, a Napoli, nel caldo ventilato della giornata di luglio, scrivevo concentrata nello sforzo di restituire la tragedia della scrittura che voglia scardinare il mondo del possibile per rivelarlo – quel suo sguardo rettiliano e storto o l’exploit pirotecnico che più mostra più nasconde, custodendo ben salda la sua qualità erotica e al contempo esiziale – quando sono stata interrotta da una zingara che voleva il suo obolo in cambio di un qualche pendente scaccia-sfortuna. Ho sorriso ricordando Coleridge e il visitatore di Porlock che interruppe la scrittura del suo Kubla Khan. Racconta infatti Pessoa che Coleridge aveva composto il poema in sogno e lo stava trascrivendo quando appunto fu disturbato da un uomo. Al termine della visita, il poeta aveva dimenticato tutta la parte centrale del poema. Di Kubla Khan rimase l’inizio e la fine, con l’abisso muto che sprofondava tra i due punti. “E così, di quello che sarebbe potuto essere, resta solo ciò che è; della poesia, o della opera omnia, solo il principio e la fine di qualcosa andato perduto – disiecta membra che come disse Carlyle, sono ciò che resta di ogni poeta, o di ogni uomo” ha scritto Pessoa. Ecco la qualità del mistero, riflettevo lasciando da parte ciò che stavo scrivendo per seguire la pista di questa storia che torna a più riprese nel mio vissuto. Una molestia che però apre le porte a una comunicazione che viene a ricordare la parola dell’estraneo, ricorda il gran teatro delle ombre da cui siamo attraversati, un fiume sotterraneo che sgretola, la scena terribile che scava la possibilità di ognuno. E però, nel poema di Coleridge, arriva qualcuno che canta, la giovane abissina con il suo dulcimer, la Poesia/Memoria che dell’abisso tesse l’arazzo. Una visione a cui abbandonarsi, a cui aderire, dimenticando l’incredulità dai denti gialli per assistere alla magia di Hermes, direbbe Paolo Lagazzi – anzi, l’ha detto quella sera stessa al Teatrino della Verzura di Villa Floridiana – dio che sovrintende all’esperienza della soglia. Ecco allora che il fiume carsico e insidioso che mina il granito dell’illusione cammina raschiando le pietre e raccogliendo i detriti che vanno a formare il messaggio. Fatto di frammenti, “un mucchio d’immagini infrante, dove batte il sole” nella Waste Land eliotiana. E veniamo all’ennesimo scarto…
….
Tutta compresa nel mio ragionamento, abbandonate ormai la brioche e la crema di caffè, delizie oltre ogni dire, ci stavo dando dentro con la scrittura, il quadernetto appoggiato al tavolino del bar e la lieve brezza che veniva dal lungomare, a pochi passi. Ho alzato gli occhi guardando il nulla di ciò che andavo scoprendo e le sue volute. Ma non ho potuto fare a meno di eludere lo sguardo fisso su di me di una donna più che appariscente, il trucco verde sulle palpebre, il suo rossetto rosso un allarme inaggirabile. Ho cominciato a rifocalizzare gli occhi su quella figura. Riccioli biondi e minigonna. Altra visitatrice, altra sconosciuta del teatrino felliniano che del mio mondo fa giungla. Epperò no. No, no, sconosciuta non lo è! È lei, cioè lui e insomma lei, ora, figura del mio passato che torna per dire del riconoscimento, per dire della diversità nel riconoscimento, la metafora di quell’uomo in un corpo altro che è l’espressione di un traslato o di un trans, la sua aderenza alla ferita originaria, il travestimento che testimonia quella aderenza e quella esperienza erotica di morte. Se le stelle mancano, pur vedendole, a non guardarle saremmo più sapienti o forse soltanto ciechi allo splendore di ciò che non è o non è più? E dunque…
….
Aderenza
allo scarto, allo sgambetto che disarticola corpo e linguaggio e veicola l’imprevisto come atto necessario alla scoperta, e pure al fallimento, ma glorioso e turgido come quelle labbra che si schiudono su un sorriso rotondo e pieno, anche se dai denti sbilenchi!