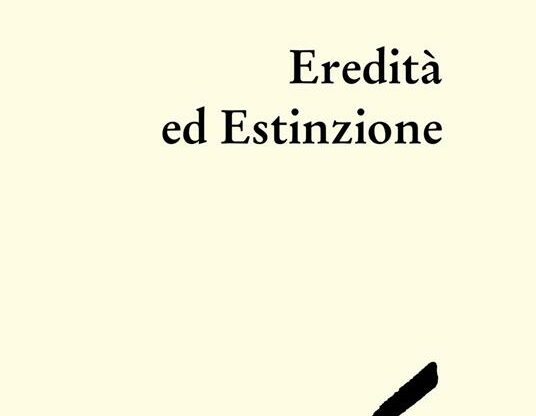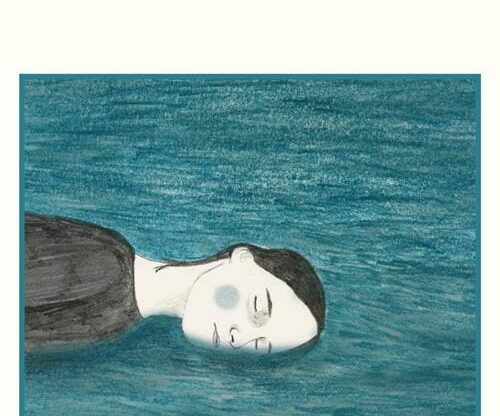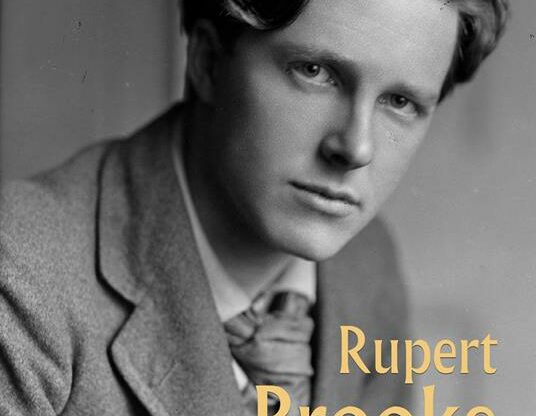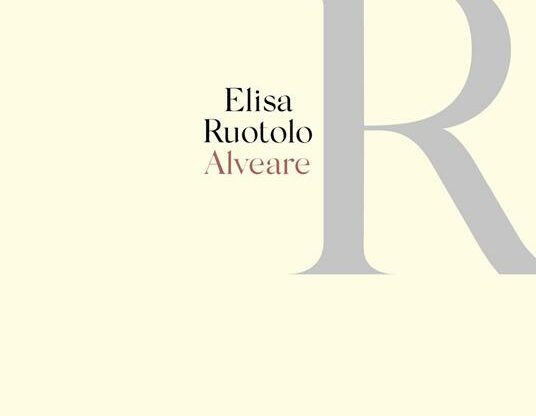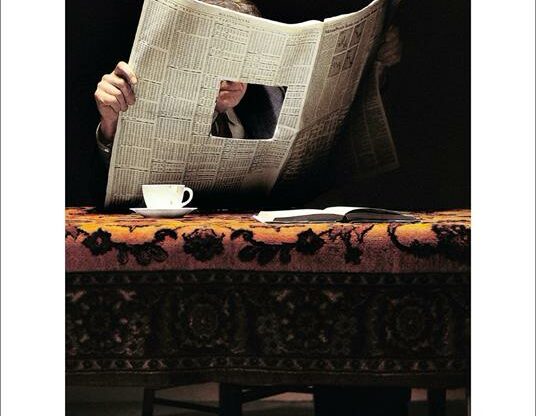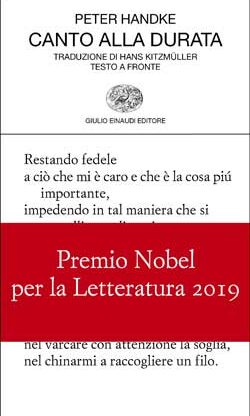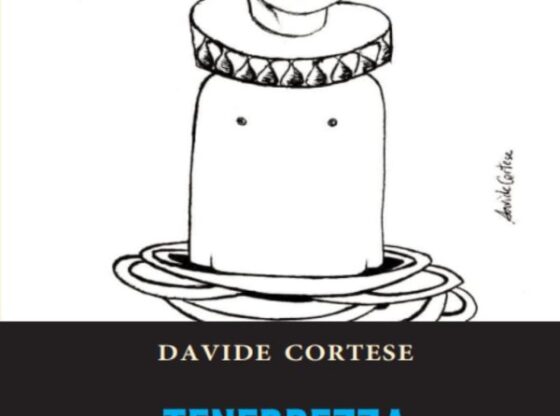Corpo striato e antiche tombe
Di Rossella Pretto
Scrivo da qui, da quella che è diventata casa e che era invece casa dei bisnonni.
Al tempo.
Lo faccio per rinsaldare l’anello che unisce le generazioni. Così da poter acquietare i cani dei rimorsi familiari. Brutto da dirsi, ma talvolta è così che accade: ti giri e quelli sono lì, i denti in vista, a un passo, vicinissimi. E tu devi fare qualcosa. Per te, ma non solo. Sperando che basti anche per chi non può e non vuole.
E dunque scrivo da qui avendo attraversato i bui delle scale. Come in quel racconto in cui da una bocca avvelenata rotolavano mobili, sbrecciando i gradini. Allora, su quelle scale mi fermavo a far convenevoli ai fantasmi. Ne cercavo le tracce. Le intime rassomiglianze. Mi appuntavo sul bavero il distintivo dell’onore e del decoro.
Alberto, l’amore di Ottavia. La bisnonna dalle origini di zingara.
E di Alberto leggevo spesso le parole in memoria pronunciate nel saluto che l’ordine degli avvocati gli ha voluto tributare. Perché io l’ho conosciuto solo su queste scale. Ma in vita: mai! Visto che ha abbandonato questa casa qualche mese prima che io nascessi.
In quella plaquette si diceva come fosse talvolta visto come un conservatore e un aristocratico. Cosa non completamente vera dal momento che era aperto a tutte le novità, ideologiche e tecnologiche. E se per aristocratico si intende amante delle cose migliori e dello stile, allora sì, lo era. Ma non lontano dal senso umano del popolo. Così lo declinavano e io imparavo a conoscerlo. E imparavo che in famiglia lui viveva le ore migliori, «le ore nelle quali poteva anche recitare i suoi amici, i suoi poeti; fino all’ultimo, benché tormentato e macerato, sapeva, aveva la fortuna di trovare la ricchezza della vita anche nella voce della poesia».
Ecco, allora, come queste mie passeggiate cittadine potranno radicare la famiglia, medicandone le ferite e agendo sul telaio del senso. Quello che affonda. Quello che regge le sorti manifeste intrecciando nodi in profondità.
… «La voce della poesia»…
… «Amante delle cose migliori»…
È così che ho cominciato: sperando in un pasto d’aria che sogni il bello. Come ha fatto Riccardo Frolloni, che ha iniziato con le polaroid. E le loro declinazioni: bruciate, mosse, sfocate, nitide, sottoesposte e sovraesposte. Dove già accettava la Storia «per intero». E dove qualcosa stava morendo. «Qualcosa / che non trovo il nome». Questo per dire che la prima plaquette s’intitolava Languide istantanee polaroid (Affinità elettive 2014). Ora invece le fotografie ci entrano a forza, entrano davvero nel corpo striato, titolo del nuovo libro di Frolloni (Industria&Letteratura 2021) e zona del cranio che presiede al movimento, o partecipa al controllo, tenta una forma e si apre un varco nel muro dell’inerzia, dell’inesistenza, del non essere perché non agente.
Lo pensa e lo proietta, quel moto che decide tra essere e non essere. «Morire, dormire. Dormire, forse sognare…» Eppure Amleto non c’entra niente. C’entra decisamente di più il sogno. Ma altri sono i riferimenti di Frolloni che affiorano dal lago onirico della mente avanzando con le loro bocche nell’ansima della parola già detta e affidata al rullo della memoria che tramuta in eredità. Che vien su, magari, dal luziano «fondo delle campagne». Le pepite dei poeti, amici, i primi a soccorrerlo nonostante il pensiero di non riuscire a trovare le parole, una sola, perché il padre se ne va «docile in quella buonanotte» quando dovrebbe infuriare «contro il morire della luce», scrive Dylan Thomas, ma non lo fa e questo spezza il collo tanto che «a parlare con un morto» si perde «il pieno delle mani», continua Frolloni, queste «mani di marmo inzuppate di nuvole» scrive ancora Thomas dopo il funerale di Ann Jones, con parole ricomposte dalla traduzione di Roberto Sanesi, quello stesso richiamato da Stefano Colangelo nell’introduzione al libro a giustificare il verso lungo, lunghissimo di Frolloni, che getta la parola oltre l’ostacolo e si spezza per poter saltare e continuarsi allungando le mani in un abbraccio che abbranca l’aria, una mano che afferra i ricordi strattonati dal vento che mai tace tra questi versi.
Quello che volevo dire di questo libro, dedicato «a mio padre morto», quello che posso dire sono sezioni – sogni, movimenti e materiali; a cui si aggiunge laica la preghiera a scacciare le ombre; e dunque fasi e memoria, con un piccolo apparato finale: un dono di Andrea Donaera, insieme alle foto «tutte analogiche su pellicola b/n poi digitalizzate», i luoghi di Frolloni, gli amici.
Quello che posso dire, poi, è una dichiarazione di poetica. Guardare, rapportarsi alla morte pressappoco come al luogo della sparizione dell’autore dove nella solitudine della scrittura egli recede, perché solo, e dunque non più in rapporto con l’altro, con un tu, il tu che ne garantisce l’esistenza singolare e impastata con lo spazio che separa i vivi e i morti. Il poeta però capta «lo sguardo dell’incessante». Ingaggia una lotta con la morte, quella stessa che ha la qualità del «non più superabile» poiché scavalla i tempi, li annulla. Affossa lo spazio, quello del corpo che manca, del tu che si consuma e scompare. Un continuo mancare che si fa segno e tradizione e che già si era fatto necessario termine di paragone divino, di un dio che è io, un nodo nella pancia, un dio-solitudine che, se stanco, richiama puntualmente la figura paterna. Ciò che non manca, tuttavia, è una voce che precede. Mescolata con la farina del presente. Con quella che è una vita e una via poetica assolutamente definita pur nella dissoluzione apparente a cui chiama. «Nella confusione delle direzioni o nel magma / nello scioglimento dei soggetti, dimentico e perciò narro, costruisco, mi metto controvento, con gli occhi / rossi per gli schiaffi, continuo».
Continua, sì, Frolloni, ben sapendo, però, che c’è bisogno del dettaglio preciso per congiungere il tempo arbitrariamente e così disporsi all’ascolto e ritrovare antiche tombe aperte. Come quella che io sono convinta si trovi sotto le mie scale di casa: una grata, il segno dei muretti che possono contenere un corpo che già non c’è più, perché sta conversando con una donna qualche gradino più in alto.
 Corpo striato
Corpo striato
Collana poetica
poesia
industria & letteratura
2021
96 p.,