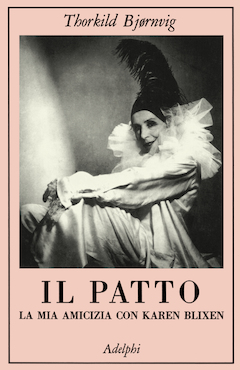La potenza dell’estraneità
Di Rossella pretto
Se vi fu evento tragico nella vita di Karen Blixen quello fu senza dubbio la morte del padre, che la lasciò tremante e disorientata. Sola, in definitiva, con la consapevolezza di un’origine perduta, estranea alla famiglia della madre, incompresa, e scissa da quel dissidio fra mondi diversi: l’aristocratico del padre, ormai precluso, nutrito di ideali di cui sentiva l’influsso in una «gioia sfrenata per la sola ragione di essere viva» (in Ultimi racconti); e quello dei Westenholz, borghesi e moralmente asfissianti, venuti al mondo per riscattare le loro anime. Un giorno la piccola Tanne entrò nello studio chiedendo come stesse il padre. Le rispose la zia dicendole che era morto. Wilhelm si impiccò a una trave, forse perché aveva scoperto di aver contratto una malattia mortale, la sifilide: come successe alla figlia. In una lettera alla moglie si legge: «Ea ed Elle sapranno badare a sé stesse, ma il mio cuore soffre per la piccola Tanne». A ragione. Perché era lei a doverne incarnare i valori, senza che nessuno ne capisse davvero gli slanci, quello spreco che risponde di sé stesso, l’aspirazione a un destino che scorre nelle vene e che tumultua nel sangue, senza requie. Sola, dunque, e senza maestri, o con quelli che scoprì poi nei libri, nella voracità che spinge a travalicare i limiti, a farne vitalissimi segni di inquietudine, tracce da inseguire nella caccia grossa che è l’esistenza di uno spirito grande e sconfinato, che soffre il confino ma cerca di evaderne per riacquistare sostanza, ali che spingano in alto dove è ancora possibile respirare coincidendo con sé stessi.
Il padre era un uomo schivo, appassionato e profondamente turbato, sempre in cerca “di una più intensa esperienza dell’essere”, scrive di lui Georg Brandes: intellettualmente un ribelle, ma un esteta e un epicureo per temperamento, diviso tra la guerra, la caccia e l’amore. Partì per il nord America e visse a stretto contatto con gli indiani, ammirandone il codice d’onore, l’eleganza e il coraggio. Tanne ereditò da lui l’amore per la natura e gli spazi aperti, quella wilderness che Wilhelm aveva attraversato e di cui lasciava testimonianza nei suoi scritti. Ad un certo punto il padre la elesse a sua confidente, avvertendone lo spirito affine. Tanne si sentì capita nel profondo; per questo, con la sua morte, le venne a mancare la possibilità più vera di stare al mondo, l’alternativa all’universo femminile fatto di problemi etici e abnegazione. In cambio, Wilhelm le aveva instillato l’aspirazione al gesto che sprezza ogni pericolo per compiersi in alto contenuto simbolico, un gesto che gioca con la morte e riesce a riderne, data l’importanza che a quel prezzo attribuisce. Di questo parla ‘Alkmene’, il racconto in cui la Blixen scrive più apertamente di sé e della smania di riacquistare ciò che le era stato tolto.
Alkmene è una bambina adottata da un curato di campagna che, ritiratosi dalla città per lo spavento dell’ambizione e della megalomania insiti negli studi che aveva condotto a Copenaghen, si dedica alla parrocchia e all’educazione del figlio di un signorotto locale, un ragazzo dalla più ampia visione. Dal momento che il precettore e la giovane moglie non possono avere figli accettano l’invito e la preghiera di accogliere la piccola orfana, o presunta tale, niente sapendo delle sue origini. Si scoprirà dopo la cospicua eredità di Alkmene, o Perdita. La bimba è un vero prodigio, profonda, piena di grazia e perennemente turbata, ma non viene capita nelle sue stranezze, soffocata dal troppo amore, malaccorto e timoroso. Solo in Vilhelm trova comprensione e amicizia, nonostante la differenza d’età. «Stringemmo così un’amicizia insolita, credo, per un ragazzo e una bambina… sembravamo entrambi, consci d’essere, tra la gente che ci circondava, le uniche due persone di sangue nobile…». Ma anche lui riesce a deluderla, portandola sulla retta via che non sempre è ideale per chi ha bisogno di accedere al cielo per tragitti tortuosi. Perché il dubbio e la caduta sono già stati inoculati in quel luogo di patimento che è la canonica, quando ha ristretti orizzonti: «un posto in cui non si perdeva mai d’occhio la morte e se ne parlava costantemente… la vita d’ogni giorno era vissuta in prospettiva dell’aldilà… l’idea della mortalità riempiva le stanze. Vivere in quella casa era per i giovani un problema e una battaglia, come se influssi fatali li trascinassero dall’altra parte, giù nella terra, esortandoli ad abbandonare l’inutile e pericolosa impresa del vivere», scrive Blixen in ‘Peter e Rosa’, più avanti nei Racconti d’inverno, prendendo a modello la sua casa di Rungstendlund e i suoi assilli. Altra figura femminile, quella di Rosa, incompresa e imbronciata, che si chiude in un mondo tutto suo: «gli altri non l’avrebbero capita, se lei avesse detto che il suo mondo era infinito e appartato, giocondo e molto serio, sicuro e pericoloso. E non avrebbero potuto nemmeno spiegare come mai lei fosse una cosa sola con quel suo mondo di sogno, tanto che grazie alla sua potenza e alla sua bellezza lei era adesso, nonostante il vestito vecchio e le scarpe rattoppate, molto simile alla più bella, più potente e più pericolosa creatura della terra». Il dissidio non si ricompone, per Alkmene, la vita è ormai segnata e lei si sottomette e accetta la via della colpa e del pentimento cristiani: conflitti molto presenti nell’infanzia della Blixen, ma a cui lei sfuggi in ogni modo reclamando l’eredità spirituale paterna che la spinse a scappare sugli altipiani africani e a condurre una vita interiormente dispendiosa ma libera e aderente con la sua natura, rispondendo per sé stessa e assumendosene la responsabilità: Je responderay, era il motto dei Finch Hatton. Di uno di loro, Denys, la Blixen si innamorò perdutamente e tragicamente, forse perché tanto assomigliava, per indipendenza e spregiudicatezza, al padre Wilhelm.