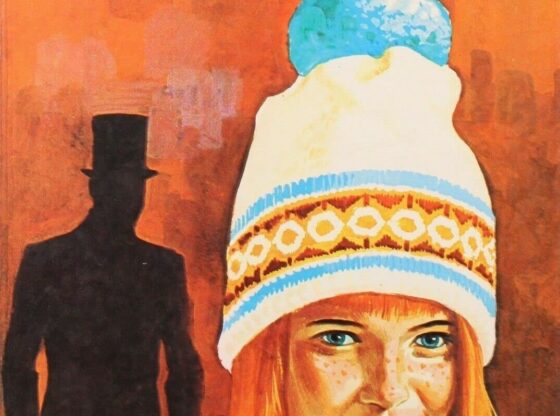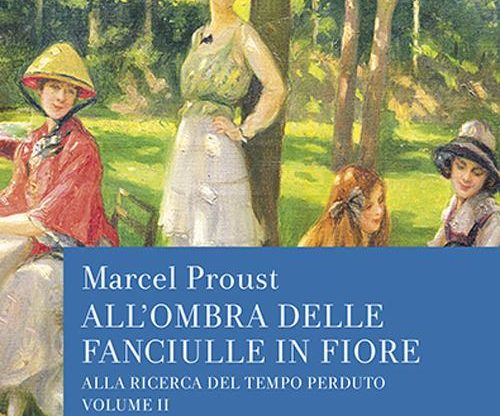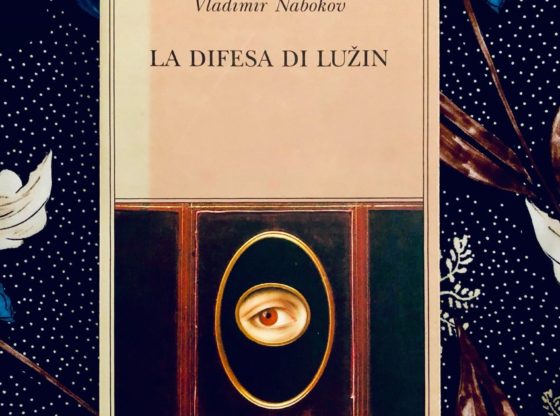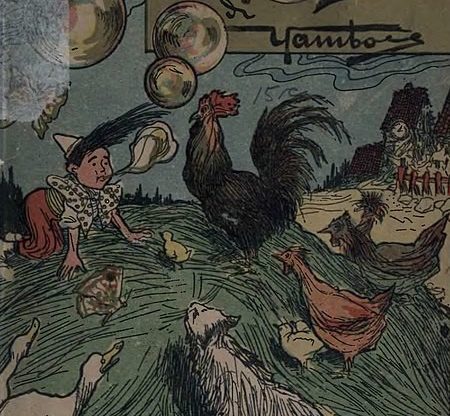La superbia nella Divina Commedia
Di Graziella Enna
Quando Dante nel XVII canto del Purgatorio spiega l’ordinamento morale del regno considera la superbia come un peccato che ha origine dalla devianza dell’amore ed è frutto di una scelta volontaria. L’amore insito nell’animo umano e si torce in “malo obietto” per desiderare il male del prossimo. Il superbo desidera eccellere grazie all’eliminazione dei propri avversari e per questo desidera che essi cadano dalla loro condizione di superiorità, come è spiegato in queste terzine[1]:
E’ chi, per esser suo vicin soppresso,
spera eccellenza, e sol per questo brama
ch’el sia di sua grandezza in basso messo;
Molti critici danteschi si sono chiesti come mai Dante non abbia collocato questo peccato e la sua punizione anche tra quelli infernali non solo in una delle cornici del Purgatorio, in realtà scorrendo la prima cantica, (e l’intero poema), troviamo innumerevoli esempi riconducibili alla superbia. Essa appare sin dal principio al lettore della Commedia con l’immagine del leone,[2] una delle tre fiere che ostacolano l’ascesa al colle, è poi indicata da Dante come una delle tre faville che ha acceso i cuori nel discorso di Ciacco[3] in cui si deplorano i vizi di Firenze: è dunque uno dei mali che ha indotto l’uomo alla perdizione e a sfidare Dio. Il concetto di superbia può essere accostato alla ybris del mondo greco classico, un ergersi prepotente dell’uomo a competere con tracotanza con la divinità che necessariamente è indotta a punirlo quando vuole oltrepassare i suoi limiti. Dante utilizza nei proemi del Purgatorio e del Paradiso degli exempla mitologici volti a dimostrare quanto la superbia sia dannosa e inammissibile e soprattutto incompatibile con l’umiltà del pellegrino durante il suo percorso di purificazione e tantomeno nell’ascesa al regno eterno. Nel proemio del Purgatorio infatti cita l’esempio delle figlie del re della Tessaglia Pierio che osarono sfidare Calliope nell’arte del canto e furono trasformate in gazze[4], allo stesso modo nell’incipit del Paradiso è presente l’episodio del satiro Marsia che ebbe l’ardire di gareggiare con Apollo nella poesia e fu scorticato vivo per punizione. È chiaro dunque che il Poeta deplori la superbia intellettuale dell’uomo che non accetta i suoi limiti, come risulta da queste terzine del III canto del Purgatorio[5] :Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.36
State contenti, umana gente, al quia;
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;39
e disïar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:42
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri”; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato.
Dante, di proposito, ha una caduta di stile nell’ utilizzare il termine forte “matto” per biasimare il tentativo superbo e presuntuoso della ragione umana di comprendere e penetrare l’essenza divina e il mistero della Trinità. Analogamente aveva definito folle, il tentativo di Ulisse di spingere la sua sete di conoscenza oltre ogni limite umano[5] senza l’ausilio della Grazia divina. L’uomo deve dunque rassegnarsi, questo è il monito del Poeta: se infatti avesse potuto comprendere ogni cosa, non sarebbe servito a Maria partorire Gesù, portatore della rivelazione. Nemmeno gli antichi sapienti, come i filosofi Aristotele e Platone, relegati nel Limbo, hanno avuto l’illuminazione della conoscenza piena, tanto più che erano privi della fede cristiana. Lo stesso Virgilio china il capo, anche lui dimora, seppur incolpevole, nel Limbo. Da questi versi e con gli esempi precedenti relativi al mondo classico e pagano, emerge il sincretismo dantesco, la sua mirabile capacità di armonizzare mito e spiritualità cristiana per scoprirne elementi accomunanti, uno dei quali, in base agli esempi riportati, è la vanagloria, il desiderio di conseguire una fama durevole per appagare l’inutile e sterile volontà di onnipotenza. Di questo si parla nella prima cornice del Purgatorio[6] dove si espia appunto il primo dei sette vizi capitali, (a cui corrispondono altrettanti ripiani che cingono la montagna). La pena a cui sono sottoposte le anime purganti dei superbi è sia fisica che morale: incedono lentamente gravati da pesanti macigni che li obbligano a chinare il capo un tempo altezzoso e, contestualmente, recitano il Pater Noster[7], parafrasato rispetto a quello biblico per far emergere il tono supplichevole che sottolinea la coscienza dell’umana debolezza degli spiriti purganti. Oltre a pregare meditano su esempi di umiltà premiata e superbia punita scolpiti in altorilievo nel marmo[8]. Quando Dante vede le anime contrite che si percuotono il petto, pronuncia un’apostrofe indirizzata ai superbi che vivono nel mondo[9]:O superbi cristian, miseri lassi,
che, de la vista de la mente infermi,
fidanza avete ne’ retrosi passi,123
non v’accorgete voi che noi siam vermi
nati a formar l’angelica farfalla,
che vola a la giustizia sanza schermi?126
Gli uomini boriosi sono poveri e infelici, mentalmente ciechi e non si rendono conto di essere come bruchi dai quali dovrà staccarsi come una farfalla, l’anima, di natura angelica, per volare umile e senza ornamenti al cospetto di Dio. Tornando al canto XI, Dante interagisce con tre personaggi che incarnano diversi modelli di superbia, (nobiliare, intellettuale-artistica e politica), in modo che ogni lettore possa riconoscere in loro la realtà storica rappresentata, secondo la tecnica medievale dell’exemplum. Il primo è Omberto degli Aldobrandeschi, un nobile feudatario che era stato così altezzoso in vita da disprezzare gli altri esseri umani senza considerarne mai la comune origine. La sua alterigia non solo l’aveva condotto alla morte ma aveva trascinato in rovina anche la sua intera famiglia. Il personaggio che nel canto spicca maggiormente è il famoso miniatore Oderisi, subito riconosciuto da Dante che lo definisce “l’onor d’Agobbio” e l’onore dell’arte dell’”alluminare” cioè della miniatura. Immediatamente, sentendosi lodare, l’anima si schernisce e ammette umilmente che un altro artista, Franco Bolognese ha ora una maggior fama e il primato nella sua arte:
“Oh!”, diss’io lui, “non se’ tu Oderisi,
l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte
ch’alluminar chiamata è in Parisi?”.81
“Frate”, diss’elli, “più ridon le carte
che pennelleggia Franco Bolognese;
l’onore è tutto or suo, e mio in parte.84
Oderisi confessa poi che il gran desiderio di eccellere gli avrebbe impedito in vita di essere cortese di riconoscimenti verso il suo rivale, ora però paga il fio della sua boria ma non avrebbe potuto farlo se in vita non si fosse pentito.
Ben non sare’ io stato sì cortese
mentre ch’io vissi, per lo gran disio
de l’eccellenza ove mio core intese.87
Di tal superbia qui si paga il fio;
e ancor non sarei qui, se non fosse
che, possendo peccar, mi volsi a Dio.
Prosegue il suo discorso con considerazione sulla vanità e caducità della gloria terrena, in linea con l’umiltà che deve dimostrare nel suo percorso di espiazione mettendo da parte la fama e l’ orgoglio conquistati nel suo passaggio terreno:
“Ahi vana gloria delle umane posse!
Com’poco verde in su la cima dura
Se non è giunta da l’etati grosse!”
Utilizzando una metafora botanica spiega che la fama è effimera come il verde delle foglie sulla cima degli alberi a meno che non giungano età di decadenza in cui tale fama possa permanere. Continua poi il discorso citando personaggi dell’epoca, ovvero Giotto che ha superato Cimabue della pittura e poi, toccando l’ambito letterario, cita Cavalcanti e Guinizzelli:
“Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido
La gloria della lingua; e forse e’ nato
chi l’uno e l’altro caccerà dal nido”
E’ evidente l’allusione a Dante stesso, come colui che supererà i due poeti stilnovisti e ciò ha subito sollevato il problema di un peccato di superbia da parte del Poeta che sembra ritenersi superiore a loro. In realtà Dante si allinea al discorso di Oderisi ed è consapevole che anche la sua fama sarà aleatoria, tant’è che il concetto viene ribadito nella terzina successiva in cui, per bocca di Oderisi, paragona ad un soffio di vento la gloria mondana:
“Non è il mondan romore altro ch’un fiato
Di vento, ch’or vien quinci e or viene quindi,
E muta nome perché muta lato”
Termina il discorso paragonando la vita umana ad un battito di ciglia in confronto all’inesorabile trascorrere del tempo e all’incommensurabilità dell’eterno. Dante ci spiega così la sua concezione di superbia che consiste non solo nell’aspirazione ad primeggiare sugli altri e nel non riconoscerne la superiorità o l’eccellenza, ma supera tutto questo con la consapevolezza che solo l’eternità di Dio e la sua grazia possono annullare ogni vanità terrena. L’artista ha solo il compito di rivelare la verità di Dio e farsi scriba Dei accettando la caducità della fama. Il terzo personaggio presentato direttamente da Oderisi, è Provenzano Salvani che un tempo era signore di Siena, tronfio del suo potere, ma che si redime sottoponendosi volontariamente ad un’umiliazione pubblica chiedendo l’elemosina in piazza del Campo a Siena per pagare il riscatto e liberare un suo amico dalla prigione, gesto che lo salva e gli permette di accedere al Purgatorio. Oderisi fa una profezia breve e oscura a Dante dicendogli che anche lui si dovrà umiliare, (riferendosi evidentemente all’esilio e al fatto che dovrà appellarsi al buon cuore dei signori che lo ospiteranno). Egli, infatti, pur essendo un poeta illustre ha rischiato di peccare di superbia e l’ha riparata con l’umiliazione dell’esilio. Oltrepassata la schiera dei superbi, anche Dante ha espiato insieme con loro il peccato e continua l’apostrofe del canto X con queste parole[10:
Or superbite, e via col viso altero,
figliuoli d’Eva, e non chinate il volto
sì che veggiate il vostro mal sentero!
Con tono sarcastico invita gli uomini a perseverare nella loro smisurato orgoglio e con testa alta in modo da non vedere la scellerata strada che hanno intrapreso. Mentre i due poeti proseguono, si avvicina a loro l’angelo dell’umiltà che li invita a salire verso la seconda cornice e cancella a Dante con un colpo d’ala una delle sette P, (che indicano i peccati capitali), quella della superbia, che l’angelo portiere gli aveva inciso sulla fronte. Dagli esempi riportati emerge la presa di coscienza da parte degli spiriti purganti del loro peccato e in ogni atto o parola si evidenzia il pentimento e l’umiltà che hanno sostituito totalmente la precedente alterigia. Non accade certo questo nel regno infernale in cui è grande il numero di coloro che si sono macchiati di varie forme del peccato di superbia ma ne espiano altri più gravi e attuali che ne hanno deciso la condanna nell’aura sanza tempo tinta, nei vari gironi in cui la voragine è distinta. Un esempio può essere Filippo Argenti[11], collocato nel quinto cerchio tra gli iracondi, immersi nel fango della palude stigia in cui si sbranano vicendevolmente. Il peccatore tenta di ingraziarsi Dante con un tentativo di captatio benevolentiae, ma egli, dopo averlo riconosciuto, ricorda la sua arroganza e prepotenza e lo respinge. Ne nasce un alterco in cui il dannato, visto il disprezzo del Poeta, tenta di rovesciare la barca. Virgilio abbraccia Dante e lo loda perche disdegna il male e gli ribadisce che in vita il dannato fu così arrogante da non lasciare nulla che ne adornasse la memoria, cosi come tutte le persone come lui sulla terra che si ritengono personaggi importanti, alimentano la loro alterigia e invece sono solo destinati a stare come porci nel brago.
Quei fu al mondo persona orgogliosa;
bontà non è che sua memoria fregi:
così s’è l’ombra sua qui furïosa.48
Quanti si tegnon or là sù gran regi
che qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi!”.
Quest’episodio avvalora l’ipotesi dei commentatori antichi che avevano posto nello Stige, accanto agli iracondi e agli accidiosi anche i superbi. Nel settimo cerchio, nel terzo girone dei violenti contro Dio, giace Capaneo che ha nella “superbia che non s’ammorza”[12] l’origine delle sue colpe e il suo eterno tormento, costretto a stare supino e immobile sotto un’orribile pioggia di fuoco. Nonostante la terribile punizione, il corpulento dannato si dimostra sprezzante e torvo tanto che Virgilio gli rivolge parole aspre e violente dicendogli che la sua maggiore punizione è la superbia che non si smorza neppure nell’Inferno e aggiunge che nessuna punizione sarebbe adeguata alla sua empietà.
“O Capaneo, in ciò che non s’ammorza63
la tua superbia, se’ tu più punito;
nullo martiro, fuor che la tua rabbia,
sarebbe al tuo furor dolor compito”.
Capaneo nel mito fu uno dei sette re che assediarono Tebe e combatterono con Polinice e fu fulminato da Giove che egli aveva sfidato a combattere sulle mura della città nemica. Il poeta latino Stazio nella Tebaide lo definisce bestemmiatore e spregiatore della religione. Sembra contradditorio il fatto che Dante lo collochi nell’Inferno dal momento che visse in epoca pagana: questo è un altro esempio del sincretismo dantesco che fonde realtà e mito per rappresentare con la figura di Capaneo un esempio di empietà e di folle superbia che spinge l’uomo a ergersi contro la divinità. Vanni Fucci[13] “in Dio tanto superbo” sconta la pena dei suoi furti sacrileghi nella bolgia dei ladri, la settima dell’ottavo cerchio. Questi dannati hanno le mani legate dietro alla schiena con serpenti che hanno il potere con il loro morso di incenerirli e di farli tornare come prima. Dopo aver condotto una vita bestiale e sanguinaria, non perde neppure nel regno dei dannati la sua disumanità e, stizzito per esser stato visto da Dante nella sua condizione misera, predice sventure ai Guelfi bianchi per ferirlo e rivolge gesti osceni contro Dio. Dante pronuncia un’invettiva contro la città di Vanni Fucci, Pistoia, dicendo di non aver mai visto uno spirito tanto superbo nei confronti di Dio, nemmeno Capaneo che, folgorato, era precipitato dalle mura di Tebe.
Per tutt’i cerchi de lo ’nferno scuri
non vidi spirto in Dio tanto superbo,
non quel che cadde a Tebe giù da’ muri.15
Bonifazio VIII indotto dalla sua “superba febbre”[14] al commercio di cose sacre, si trova nella bolgia dei simoniaci, ma viene nominato nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio dal consigliere fraudolento Guido da Montefeltro, avvolto come Ulisse entro una fiammella. Guido si fece frate francescano per espiare i suoi peccati ma fu indotto a trasgredire dal pontefice. Egli infatti lo fece chiamare, (così come l’imperatore Costantino malato di lebbra fece chiamare papa Silvestro), per chiedergli consigli su come espugnare e conquistare la fortezza di Palestrina (Guido era stato un capo militare). Nonostante egli avesse trovato deliranti le parole del pontefice, fu costretto ad assecondare la sua superba febbre di potere. Anche se il più arrogante e tracotante tra i due si dimostra Bonifacio VIII, è vero anche che Guido, così come Ulisse non riconosce l’umiltà di ammettere i propri limiti umani.
Ma come Costantin chiese Silvestro
d’entro Siratti a guerir de la lebbre,
così mi chiese questi per maestro96
a guerir de la sua superba febbre;
domandommi consiglio, e io tacetti
perché le sue parole parver ebbre.
Fialte[15], altro dannato è conficcato con gli altri giganti nel pozzo che si trova tra l’ottavo e il nono cerchio a corona del cerchio dei traditori. Le figure colossali sono dei ribelli, di fatto, abbattuti e diventano l’emblema della folle superbia sconfitta. Fialte fu uno dei giganti che tentarono la scalata al cielo per impaurire gli dei e volle sperimentare la sua potenza contro il sommo Giove. Le braccia che allora dimenò ora non le può più muovere, la sua tracotanza smisurata è stata pertanto sconfitta e resa impotente dalla vendetta divina.
“Questo superbo volle esser esperto
di sua potenza contra ’l sommo Giove”,
disse ’l mio duca, “ond’elli ha cotal merto.93
Fïalte ha nome, e fece le gran prove
quando i giganti fer paura a’ dèi;
le braccia ch’el menò, già mai non move”.
Anche il Paradiso contiene passi in cui la superbia è condannata ad esempio quando si parla di Lucifero, il primo superbo[16]. Nel cielo di Giove tra gli spiriti giusti, appare l’aquila che è formata da innumerevoli spiriti ma parla come se fosse un’unica persona. Dante chiede all’aquila di risolvergli un vecchio dubbio, cioè perché la giustizia divina condanni gli uomini che non conobbero Cristo. L’aquila spiega che l’intelletto umano non può capire le imperscrutabili ragioni della giustizia di Dio, sommo bene e fa l’esempio di Lucifero che fu la più alta tra tutte le creature, per non aver saputo attendere la luce della grazia cadde dal cielo imperfetto e perciò ogni natura inferiore a lui è un contenitore insufficiente per il bene infinito di Dio. L’uomo pertanto deve accettare i suoi limiti e accettare il dogma dell’assoluta divina giustizia.
E ciò fa certo che ’l primo superbo,
che fu la somma d’ogne creatura,
per non aspettar lume, cadde acerbo;48
e quinci appar ch’ogne minor natura
è corto recettacolo a quel bene
che non ha fine e sé con sé misura.
Il discorso su Lucifero viene ripreso anche nel nono cielo, il Primo Mobile[17] in cui Beatrice spiega a Dante come gli angeli furono creati per un atto d’amore da parte di Dio insieme con l’universo e con la funzione di motori dei cieli. Mentre porta avanti questo discorso ricorda la ribellione degli angeli la cui causa fu la malvagia superbia di Lucifero che Dante ha visto oppresso da tutto il peso della terra conficcato proprio nel suo centro.
Principio del cader fu il maladetto
superbir di colui che tu vedesti
da tutti i pesi del mondo costretto.57
Da tutti gli esempi addotti risulta nitida la differenza tra i peccatori di superbia rappresentati nell’Inferno che perseverano nella loro ostinazione e nella loro tracotanza, la contrizione e la conquista dell’umiltà degli spiriti purganti, la consapevolezza dell’ insufficienza delle capacità umane nella comprensione di molti aspetti dottrinari nel Paradiso. In ogni caso la lezione dantesca è evidente: l’uomo non può in nessun modo prevaricare la perfezione divina, tantomeno pretendere di capire fino in fondo i misteri dei dogmi della fede o la giustizia dell’ordine dato da Dio all’universo. Allo stesso modo tutte le creature di Dio indirizzate verso il bene per inclinazione naturale non devono rivolgersi al male né verso Dio né verso il prossimo per un insano desiderio di eccellenza e di superiorità che generi presunzione, orgoglio e tracotanza, vizi deplorevoli per il singolo, per la società e forieri solo di rovina.
Note
[1] Purg. XVII, vv.115-117
[2 Inf. I vv. 45
[3] Inf. VI. Vv 74
[4] Purg, I vv.
[5] Purg. III,34-45
[6] Inf. XXVI, 125
[7] Purg.XI
[8] Prrg, XI, 1-36
[9] Purg. X, 34-96 [1] Purg.X, 121-126
[10] Purg. XII 69-71
[11] Inf. VIII, 31-51
[12] Inf. XIV 63-72
[13] Inf. XXIV, 121-151 e XXV 13-15
[14] Inf.XXVII 94-98
[15] Inf.XXXI 91-96
[16] Par.XIX, 46-51
[17] Par. XXIX 55-57