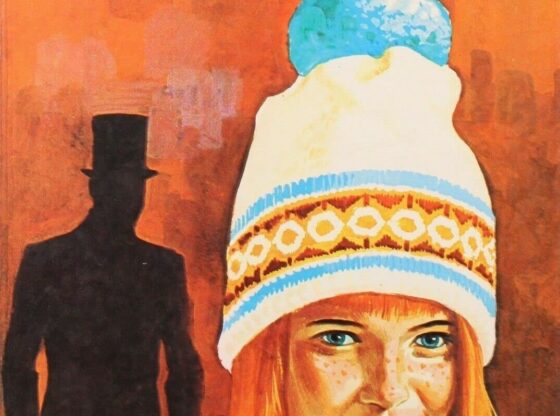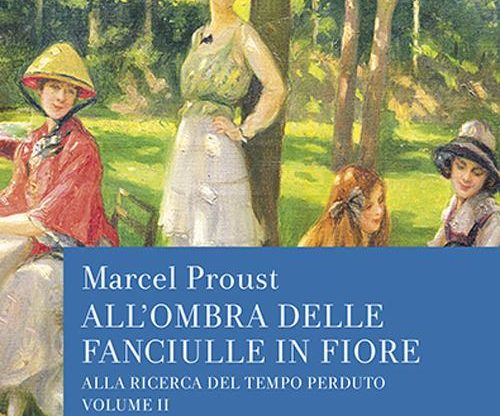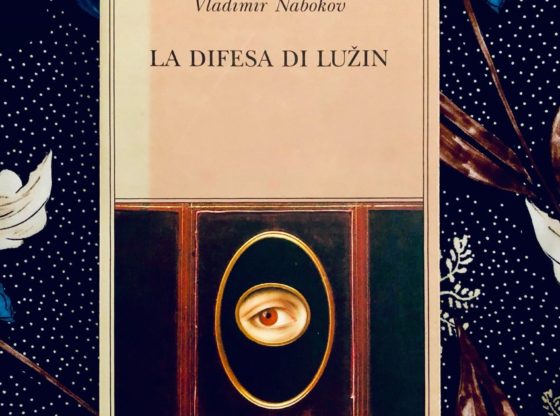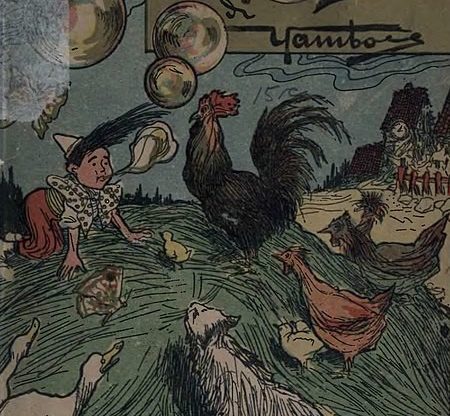Il passero solitario nella tradizione poetica
Di Graziella Enna
Il passero solitario che tanta fortuna ha avuto con Leopardi è un’immagine presente in Petrarca nel sonetto CCXXVI, e, come notò un famoso commentatore di Petrarca nel 500, Alessandro Vellutello, si ispira al salmo penitenziale 101, 8 “Vigilavi, et factus sul sicut passer solitarius in tecto” (resto a vegliare: sono come un passero solitario sopra il tetto).
Petrarca vuole indicare il senso di smarrimento che prova lontano dalla sua amata:
nessun passero sopra un tetto fu solitario quanto lo sia lui, né alcun animale selvatico nei boschi, dal momento che non vede il bel viso di Laura, né conosce altro sole, né suoi occhi hanno un altro oggetto da contemplare. Piangere è rimasto il solo massimo diletto del poeta, il riso è per lui dolore, il cibo è come l’amaro assenzio e il veleno, la notte è fonte di affanni, il cielo sereno per lui è comunque cupo, il letto come un campo di battaglia per l’impossibilità di un quieto sonno. Il sonno (qui Petrarca usa parole virgiliane “ consanguineus Leti Sopor”, Aeneis VI, 278), come si dice, è parente della morte e sottrae momentaneamente il cuore al dolce pensiero dell’amata che lo tiene in vita. Soltanto il luogo dove ora dimora Laura è fecondo, felice, con prati fioriti e luoghi ombrosi, mentre lui ha perso il suo bene e lo piange.
Canzoniere CCXXVI
Passer mai solitario in alcun tetto
non fu quant’io, ne fera in alcun bosco,
ch’i’ non veggio ‘l bel viso, et non conosco
altro sol, ne quest’occhi ann’altro obiecto.
Lagrimar sempre e ‘l mio sommo diletto,
il rider doglia, il cibo assentio et tosco,
la notte affanno, e ‘l ciel seren m’e fosco,
et duro campo di battaglia il letto.
Il sonno e veramente, qual uom dice,
parente de la morte, e ‘l cor sottragge
a quel dolce penser che ‘n vita il tene.
Solo al mondo paese almo, felice,
verdi rive fiorite, ombrose piagge,
voi possedete, et io piango, il mio bene.
Petrarca dunque si serve del passero per esprimere un rimpianto amoroso, Leopardi si distacca dal modello e mette in parallelo il piccolo pennuto e la sua vita. Inserisce la lirica nella seconda edizione dei Canti nel 1835, ma sicuramente la compose alcuni anni prima: essa è una riflessione sulla giovinezza, spesa nell’isolamento dei suoi studi, rievocata con malinconia e paragonata a quella del passero solitario, quando essa è già finita ed egli avverte l’approssimarsi dell’età matura.
Sono una prova della sua volontà di vivere appartato le parole che egli scrive in una sua epistola all’amico Viesseux, Leopardi presenta se stesso e la sua tendenza a quella che chiama absence :
”la mia vita, prima per necessità di circostanze e contro mia voglia, poi per inclinazione nata dall’abito convertita in natura è divenuto indelebile, è sempre stata, ed è, e sempre sarà perpetuamente solitaria, anche in mezzo alla conversazione, nella quale, per dirlo all’inglese, io sono più absent di quello che sarebbe un cieco ed un sordo. Questo vizio dell’absence e’ in me incorreggibile e disperato”.
Da una simile consapevolezza, risulta palese la tematica di fondo della lirica, una delle più autobiografiche del nostro Giacomo. Tra l’altro, nulla è lasciato al caso, neppure nella scelta del volatile cui si paragona, desunto dalla conoscenza precisa di un’opera scientifica del naturalista francese Buffon, “L’histoire naturelle des oiseaux”, scritta a metà del Settecento, in cui l’autore aveva conferito al passero “monticola solitarius”, dei connotati specifici descrivendolo come emblema patetico della solitudine. Un altro richiamo petrarchesco è evidente nell’incipit del componimento di Leopardi, che sicuramente e indiscutibilmente ha presente il sonetto CCCLIII:
Vago augelletto che cantando vai,
over piangendo, il tuo tempo passato,
vedendoti la notte e ‘l verno a lato
e ‘l dí dopo le spalle e i mesi gai,
se, come i tuoi gravosi affanni sai,
cosí sapessi il mio simile stato,
verresti in grembo a questo sconsolato
a partir seco i dolorosi guai.
I’ non so se le parti sarian pari,
ché quella cui tu piangi è forse in vita,
di ch’a me Morte e ‘l ciel son tanto avari;
ma la stagione et l’ora men gradita,
col membrar de’ dolci anni et de li amari,
a parlar teco con pietà m’invita.
Anche in questo caso Petrarca è spinto dalla necessità di trovare uno sfogo per le proprie sofferenze amorose e cerca conforto in un uccellino: così come l’animaletto rimpiange i mesi felici e luminosi, così l’amante sconsolato ricorda il suo passato che mai potrà tornare. Apparentemente la sorte del piccolo volatile potrebbe sembrare paragonabile a quella del poeta, ma c’è un discrimine che emerge nella prima terzina, ovvero la compagna pianta dall’uccellino è forse in vita mentre la speranza del poeta è vana dato che la morte ha portato via anima e corpo di Laura. Fra le righe del componimento di Leopardi, dunque, si potrebbe leggere anche il motivo della comparazione tra il poeta e il passero come elemento petrarchesco e, come nel sonetto dell’illustre precursore, si tratta di un paragone che mostra solo apparenti punti di contatto. Sia in Petrarca che in Leopardi l’io lirico e l’augelletto risultano alla fine distanti.
D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulta,
Sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri,
Pur festeggiando il lor tempo migliore:
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli,
Non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
Canti, e così trapassi
Dell’anno e di tua vita il più bel fiore.
Come in tutte le liriche leopardiane, nonostante l’apparenza, non si può parlare di descrizioni paesaggistiche in quanto la realtà in cui l’io lirico è immerso è filtrata attraverso stimoli visivi ed uditivi tipici della poetica del vago e dell’indefinito. Dalla cima dell’antico campanile (la chiesa di Sant’Agostino” a Recanati), il passero solitario canta ripetutamente verso la campagna, diffondendo l’armonia per tutta la valle. La primavera d’intorno splende nel suo fulgore e intenerisce il cuore a guardarla, tra belati di greggi, muggiti di armenti, (Nel verso 8 Leopardi ne richiama uno virgiliano tratto dal dall’VIII libro dell’Eneide quando Enea nel Lazio si reca dal re Evandro, v.353 “Udian greggi belar, mugghiare armenti”, trad. di Annibal Caro), evoluzioni di volatili nel cielo che festeggiano la stagione migliore della propria vita, mentre il passero osserva pensoso in disparte, disinteressato all’allegria, evitando i divertimenti, trascorre così il periodo migliore della propria esistenza. In questi versi e’ già preannunciata l’intenzione di stabilire un’analogia con la sua solitudine.
Oimè, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
Della novella età dolce famiglia,
Nella seconda strofa, in modo esplicito, il poeta parla di sé del suo modo di vivere simile al passero: non si cura inspiegabilmente dei divertimenti e del riso, dolci compagni della giovinezza (richiama l’espressione di Petrarca del sonetto CCCX: Zefiro torna e bel tempo rimena, e fiori e l’erbe sua dolce famiglia”)
E te german di giovinezza, amore,
Sospiro acerbo de’ provetti giorni
Non curo, io non so come; anzi da loro
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco natio,
Passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch’omai cede alla sera,
Festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
Odi spesso un tonar di ferree canne,
Che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
La gioventù del loco
Lascia le case, e per le vie si spande;
E mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo
Steso nell’aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica
Che la beata gioventù vien meno.
Egli non si cura dell’amore, fratello della giovinezza e fonte di sospiri nell’età matura, quasi fugge lontano da loro e trascorre la primavera della sua vita come un eremita estraneo al luogo natio. In un giorno di festa per il suo borgo, mentre il suono delle campane di mescola al tuonare di fucili, i giovani, vestiti a festa, si riversano nelle vie, guardano e si fanno guardare e dentro di loro si compiacciono, il poeta invece, si dirige, appartandosi, verso la campagna più solitaria, (richiama il Petrarca di “solo e pensoso”), rinvia ad un altro tempo divertimento e gioco, mentre il giorno sereno si dilegua cadendo tra i monti lontani e la luce del tramonto ferisce lo sguardo disteso nell’aria luminosa e sembra che dica che la gioventù beata sta finendo. Come in tante altre liriche, la caduta degli astri, è metafora visiva ricorrente ed indica non solo la fine della giovinezza ma anche la caduta delle illusioni ad essa strettamente legate. L’immagine del tramonto richiama anche il celebre verso virgiliano con cui termina la prima bucolica “maioresque cadunt altis de montibus umbrae”, di cui condivide lo stesso tono elegiaco.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitar non impetro,
Quando muti questi occhi all’altrui core,
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro
Del dì presente più noioso e tetro,
Che parrà di tal voglia?
Che di quest’anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro.
Nella terza strofa vengono evidenziati e confrontati la naturalezza e l’istinto del volatile e l’innaturalezza del comportamento del poeta. L’uccellino solitario, quando giungerà alla sera della vita che il destino gli darà, non si dorrà del suo modo di vivere, perché ogni desiderio degli animali è frutto dell’istinto naturale. Il poeta invece se non otterrà di evitare la soglia detestata della vecchiaia, quando i suoi occhi saranno muti per il cuore degli altri, e per loro il mondo sarà vuoto, i giorni futuri saranno più noiosi e tetri dei presenti, che cosa gli sembrerà un tale desiderio? Che cosa proverà ripensando agli anni giovanili? Che cosa gli parrà di se stesso? Forse si pentirà e spesso si volterà indietro senza consolazione. Ecco l’amara conclusione dei poeta, il passero e’ solitario per natura e non sbaglia a seguire l’istinto, l’uomo che si allontana dalla propria socialità e’ destinato in futuro a rimpiangere la sua scelta. L’analogia che si può creare tra il poeta ed il passero è pertanto solo quella del canto e quest’affermazione sembra valere anche per i sonetti di Petrarca. Per il volatile il canto è il modo in cui partecipa al tripudio della primavera, per Leopardi invece e’ la poesia di un uomo che non condivide il modo di sentire comune, dedito ali suoi studi ed alla sua vocazione artistica, che dunque rimpiange la sua giovinezza non pienamente vissuta.
Si potrebbe associare al “Passero solitario” leopardiano, una lirica intensa e delicata del poeta Paul Verlaine “Le ciel est par-dessus le toit”. Vari elementi possono accomunare le due poesie: l’assenza di un qualsivoglia intento bozzettistico, le sensazioni visive e uditive provate dall’io lirico, un uccello sul ramo che canta il suo lamento e gli stessi interrogativi di Leopardi, sulla giovinezza perduta. La lirica fu scritta nel 1873:
Il cielo è là sopra il tetto,
così blu, così calmo!
Un albero sopra il tetto
culla il suo ramo.
La campana, nel cielo che si intravede,
dolcemente rintocca,
un uccello, sull’albero che si vede,
canta il suo pianto.
Mio Dio, mio Dio, la vita è là
semplice e tranquilla,
questo rumore quieto
viene dalla città.
Che cosa hai fatto
tu che piangi senza interruzione
dimmi che cosa hai fatto
della tua giovinezza?
Verlaine nel 1873 fu condannato a due anni di prigione, a Mons. Nell’angusta cella medita solitario ed esprime il suo stato d’animo attraverso la musicalità delle parole, (che si può apprezzare sicuramente meglio nella versione originale francese). Attraverso una finestrella gli giunge l’immagine di un tetto, di un pezzo di cielo, dei rami di un albero mossi dolcemente da una leggera brezza e si meraviglia come se li vedesse per la prima volta, sente poi i rumori che gli giungono dall’esterno, il rintocco della campana ed il lamentoso canto di un uccello, che percepisce come un sereno e gradevole rumorio, indice della vita quieta fuori dalle mura del carcere. A queste sensazioni uditive e visive, ex abrupto, subentra la riflessione e l’invocazione a Dio, ma la domanda che termina il componimento e’ simile a quella che Leopardi maturo pone a se stesso, cioè si chiede tra le lacrime che ne sia stato della sua giovinezza non goduta. Ed è in questo pentimento che però Verlaine si rivolge a Dio anche se non è chiaro se si tratti di un’esclamazione o della volontà di riavvicinarsi a lui.
In entrambe le liriche dunque i versi iniziali sembrano tratteggiare quasi un quadro paesaggistico ma in realtà celano profonde riflessioni sulla propria esistenza ed il rimpianto ormai vano per tutto ciò che non si e’ vissuto.
L’immagine del passero viene ripresa anche da Giovanni Pascoli in alcune liriche presenti in diverse raccolte, due nei poemetti e una nei nuovi poemetti. La più conosciuta è sicuramente quella pubblicata nel 1896 su un settimanale e inserita in seguito nella raccolta “Myricae”. In questo caso il passero viene paragonato a una monaca descritta come una prigioniera nel convento mentre tenta di suonare tre note nell’organo a cui sono associate tre misteriose parole.
Tu nella torre avita,
passero solitario,
tenti la tua tastiera,
come nel santuario
monaca prigioniera,
l’organo, a fior di dita;
che pallida, fugace,
stupì tre note, chiuse
nell’organo, tre sole,
in un istante effuse,
tre come tre parole
ch’ella ha sepolte, in pace.
Da un ermo santuario
che sa di morto incenso
nelle grandi arche vuote,
di tra un silenzio immenso
La critica si è sbizzarrita nel ricercare quali possano essere le tre parole, forse le promesse di castità, povertà e obbedienza proferite nel momento in cui ha pronunciato i voti della monacazione. E’ sorto però il dubbio perché se la suora fosse stata felice della sua condizione non avrebbe sepolto le tre parole ma le avrebbe tenute sempre presenti con rinnovata gioia. Montale in un suo articolo aveva posto l’accento sulle tre note considerandole come una citazione dell’opera Manon Lescaut di Massenet. Tre note sole ripetute sottolineano l’aria in cui il protagonista Des Grieux vagheggia bramosamente di vivere felice con Manon in una casetta allietata dal cinguettio degli uccelli e canta tre sole parole: “o dolce incanto”. Dal momento che anche Manon era stata destinata alla vita claustrale e muore alla fine dell’opera senza realizzare neppure il suo sogno d’amore, la critica ritiene fondata l’ipotesi che Pascoli, citando la suddetta opera, ci suggerisca che la monaca abbia sepolto nel suo cuore le parole che le evocano un amore perduto, un sogno a cui ha dovuto rinunciare suo malgrado. Pertanto risulta chiaro che volutamente il poeta sia voluto partire da Leopardi per trattare un tema molto dibattuto cioè la monacazione forzata e la giovinezza perduta, ovvero gli stessi temi trattati dal recanatese e dal francese. L’immagine di Petrarca, nata per piangere il dolore inconsolabile e inappagato ha pertanto attraversato i secoli rinnovandosi e rivivendo in splendide liriche di grandissimi poeti.
In copertina l’immagine di un esemplare di passero solitario. Foto presa da informazioneonline.it
.