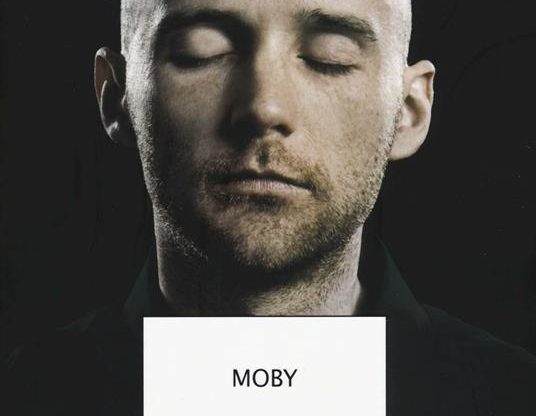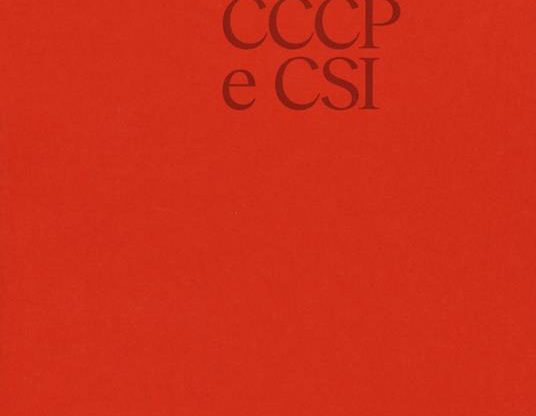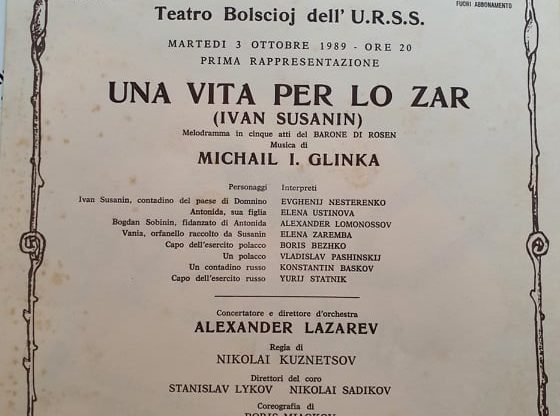Trovare una definizione di stile per quello che considero da sempre uno dei 30 dischi irrinunciabili del rock moderno non è affatto semplice. La seconda parte della nuova generazione rock degli anni ottanta si dimostrò molto attenta al recupero di alcune forme sonore della tradizione, specie in America (penso agli X, ai Blasters, ai Los Lobos, ai Long Ryders, ai Green on Red, ai Dream Syndicate ecc.) ma per i Gun Club dello scomparso da anni ed anni Jeffrey Lee Pierce, come detto, è arduo trovare una definizione per un genere che loro hanno creato in prima persona. La miscela infuocata, letteralmente, era originata dai tempi stretti, secchi, segaligni del punk, miscelati con un country slabbrato e digrignante, che si serviva di chitarre affilatissime e dello yodeling incredibile nel cantato del leader Jeffrey Lee. Già la copertina del disco, con loro tre davanti a due palme spazzate dal vento e con quel colore verde smeraldo intenso, fa comprendere che l’opera è di quelle imprescindibili. L’album di esordio precedente, “Fire of love”: splendido, in cui Pierce declamava il suo amore per la chitarrista dei Cramps (altri grandissimi e sui quali è uscita da pochissimo biografia su di loro irrinunciabile) Ivy Roscharch, aveva già fatto intendere di che pasta fossero i nostri eroi. Ma “Miami” è un’altra storia.
Questo country psicotico strapazzato e piegato al cantato ipnotico, assolutamente inarrivabile di Pierce, mostra già una grande maturità per loro che erano molto giovani. La Animal records, neonata etichetta di allora poi scomparsa, del compagno di Deborah Harry dei Blondie, Chris Stein, produsse il disco. A questo punto si entra in un tunnel magnifico che leva il fiato. Blues, country dissonante, rock, punk, suoni di un’altra dimensione, il tutto sotto il controllo micidiale del leader, vero mistico di quel periodo, folgorato dal voodoo (come si respira nel disco) dalla magia nera, ma pure dalle scritture sacre.
I brani sono delle autentiche saette a ciel sereno, micidiali staffilate, trapassate dal cantato gorgheggiante dell’artista n° 1 nel cantato in quegli anni, capace di farti sudare solo ad ascoltarlo con quella sua timbrica inimitabile. Pazzesco. Certo, adoravamo, in altri contesti, anche i Tuxedomoon di “Half Mute” ed altro, ma loro ci facevano scattare sull’attenti e questo fu fin quasi alla fine dell’avventura, nonostante lui fosse votato agli eccessi della droga e dell’alcol che lo distrussero e portarono alla morte ancora assai giovane: neanche trentottenne, nel marzo del 1996. Come tutti i maledetti. Sono 20, maledettissimi anni, quest’anno 2016 bisesto e funesto.
Una sola ballata, splendida, con una voce che ricorda il migliore Jim Morrison, la conclusiva “Mother Earth”, celebrazione di quella terra che lo avrebbe ricoperto definitivamente solo 14 anni dopo questo disco. Di questo sfortunato poeta dei lati oscuri dell’America più violenta, implacabile e senza misericordia alcuna, sono stati celebrati fasti e qualità dopo la bellezza di più di venti anni, nella prima decade di questi sciagurati Anni Duemila. Ma non bastò, non basta e non basterà. Tutti gli altri brani sono costruiti con uno spirito da corsaro indomito. Brani come “Like calling up Thunder “, “Run through the jungle”, rifacimento voodoo di un pezzo non suo, devastante, “Devil in the woods”, che ti fa alzare le chiappe dalla sedia, “Carry Home” e “Bad Indian” (questa la mia preferita in cotanto splendore), “Fire of love”, “John Hardy”, sono schegge di vetri coloratissimi che ti pungono e fanno sanguinare copiosamente, per davvero. Hanno tutte un’energia straordinaria che già allora ma,a maggior ragione oggi, non troviamo più. La loro iconografia, quella di Jeffrey in particolare, dacchè era la mente di tutto dalla A alla Z, era ansimante, inquieta, edificata dalle viscere della terra sul simbolismo voodoo e sul mistero che un cantante con quella voce e con quelle idee originalissime aveva più di ogni altro. La tradizione musicale americana li aveva fatti crescere ma loro l’hanno ripagata con un suono che non sarà mai più. Tutti li venerano, tra i loro colleghi oggi, ma in quegli anni, faticarono da morire ed in pochissimi li compresero. Irripetibile iato di una personalità devastante, di un’emotività incontenibile ed inquieta, di una sofferenza talmente palpabile da fare male fisico, prima che mentale.
E lui, una mattina di quel 1996, non si svegliò più. Da allora il rock non è più stato lo stesso, anche per quegli sciagurati che non hanno mai sentito parlare di lui e del “Club del Fucile”.
Jeffrey, per quello che hai regalato, la mia è povera ed umile cosa, ma fatta col cuore e la mente di chi ha tratto giovamento mentale e fisico dai tuoi suoni e dalla tua splendida e non replicabile voce. Uno dei miei primi cinque dischi rock preferiti: IRRINUNCIABILE–IRREPLICABILE–UNICO!
Che la terra ti sia eternamente lieve.
So long, Jeffrey.
 Miami
Miami
Rock
1982