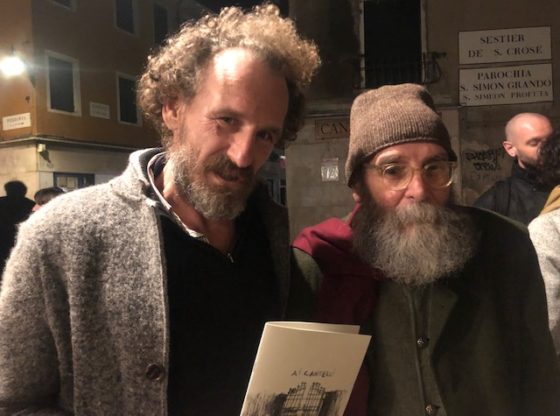Marco
Mi sarebbe piaciuto che mi evocasse, prima di sbattermi. E lanciando sé a me incollata e scelta dal suo cazzo, bruciava ogni nascita d’istante, suscitava nelle vene come una tensione instabile. Si faceva d’aria. Lui voleva guardare. Sarebbe stato sempre così. Trovo che i maschi non sappiano convivere con le finzioni, uomini che ne abusano, le strozzano anche, ma ne sono schiavi. Dall’esterno se ne annoiano, e il falso della finzione se li fagocita. Dicevo a Marco, mentre mi toccava con piacere, parlavo come fossi in un’altra stanza, a non cedere gonfia alle sue mani. Lui riesce a darmi tanta fiducia, che penso di somigliargli. Così abbiamo un talento nel doppiare ogni aspetto e ogni vita, non ci accontentavamo di una sola riduzione strepitosa. E ne pagavamo il prezzo. Insieme e sempre contenti e padroni di un unico punto accerchiato dal vuoto e terribile, contagioso. Capisco, dovrei imparare a scordare ciò che vedo mentre lo scopo, ma io non lo vedevo. Marco mi piace, vedevo me, i miei difetti, le qualità tutte appese all’estraneo, lo temo fino alle ossa. Su quell’isola greca, dieci anni ormai, lo conobbi su quella spiaggia sottile e uniforme, mi aveva guardata a lungo prima di coprirmi col suo telo. Era vento di Creta. Mi avrebbe detto poi, che si comincia dalla violenza, sostituendosi, per cercare le maniere dell’incontro, la costanza nella sua stessa profondità. Dentro. Come pelle tolta alla funzione e forte, già intelligente il velo di fuori. E iniziammo girando nel sale, più caldi del tempo, più che simili.
Giovanna
Come ricordare che passano le mani ora. Nelle mie carni piatte e sole, indiscernibili dalla prima natura accolta, appiccicata alla notte e ora col sole è uguale: i compagni non piangono la mia morte sopra quella barricata di ogni giorno. Mi sono lasciata al niente come mancia. Ora mi copre un silenzio richiesto e montato e impiantato. Ogni novità è saputa, a farmi immagine di quelle colture di amicizia, le tovaglie col pane sbriciolato prima che giungessero piatti colmati sbilenchi, e occhiate come fosse giusto, lecito, il mangiare da sola. Dopo che erano passati ad altra vita, i miei uomini, e tutti compagni. Ci si ritrovava da Donato, a fare il punto di colloquio nostro tra le nuove divise che il rappresentante tatuato abbronzato, rifilava all’oste, mentre la lotta veniva progettata: ogni angolo, presente o no la sabbia del potere, doveva essere taglio e conflitto: non aveva da essere, ma è. Nelle terragne schiusure della solidarietà sociale, prima che morissi. Colpita, caduta nella città che avrebbe dimenticato presto, tutti lombi scorticati saremmo. Femmina che non ha imparato a distinguere la forma dall’aria della forma: la mia vita. Ricordando il fresco urlo nel gesto nell’idea di piazza: invitare un compagno nel postoperaismo, dentro a una scuola di un quartiere occupato dalla vita bruciante, censurare le riprese con le domande incoerenti, raccogliere interventi cui corrispondere con il colore intimo dell’essere discenti da docente. Non smetteranno mai i compagni, di studiare. E forse è un bene. Il coniugare l’estetica del contatto, con la pragmatica dello scontro. Ciascuna cosa chiusa nella presenza, per macchie di popolazione colpevole del suo essere indebitata. Giacomo mi si dispone vicino, monta il braccio attorno al mio collo, si accinge al pensiero, percorre con quelle lagrime sue, che non sono morte, lo spazio del mio sorriso. Risultiamo attimi sottratti alla lotta così protocolli di incontro, capitoli di una narrazione incatenata al nulla eccitato quanto la cenere. Ci siamo lasciati devastare, reggendo il ritorno alle macchine che siamo stati sempre. Poi in mezzo, come avventura liminare, la venata tenda, il tempo della solitudine annoiata, un ricordo che fende l’aria destinata a schermo di una vita, i sentimenti deragliati e fatui, riconoscente fondo l’impazienza, risa ulteriori giri di parole, le rincorse nel dolore e con i denti macchiati di parole, verbi veloci.
Giovanna una compagna
Un rapporto è stato. Come ricordare che passano le mani ora. Nelle mie carni piatte e sole, indiscernibili dalla prima natura accolta, appiccicata alla notte e ora col sole è uguale: i compagni non piangono la mia morte sopra quella barricata di ogni giorno. Mi sono lasciata al niente come mancia. Ora mi copre un silenzio richiesto e montato e impiantato. Ogni novità è saputa, a farmi immagine di quelle colture di amicizia, le tovaglie col pane sbriciolato prima che giungessero piatti colmati sbilenchi, e occhiate come fosse giusto, lecito, il mangiare da sola. Dopo che erano passati ad altra vita, i miei uomini, e tutti compagni. Ci si ritrovava da Donato, a fare il punto di colloquio nostro tra le nuove divise che il rappresentante tatuato abbronzato, rifilava all’oste, mentre la lotta veniva progettata: ogni angolo, presente o no la sabbia del potere, doveva essere taglio e conflitto: non aveva da essere, ma è. Nelle terragne schiusure della solidarietà sociale, prima che morissi. Colpita, caduta nella città che avrebbe dimenticato presto, tutti lombi scorticati saremmo. La donna non ha imparato anche a distinguere la forma dall’aria della forma: la mia vita. Ricordando il fresco urlo nel gesto nell’idea di piazza: invitare un compagno nel postoperaismo, dentro a una scuola di un quartiere occupato dalla vita bruciante, censurare le riprese con le domande incoerenti, raccogliere interventi cui corrispondere con il colore intimo dell’essere discenti da docente. Non smetteranno mai i compagni, di studiare. E forse è un bene. Il coniugare l’estetica del contatto, con la pragmatica dello scontro. Ciascuna cosa chiusa nella presenza individualizzata, per macchie di popolazione colpevole del suo essere indebitata. Giacomo mi si dispone vicino, monta il suo braccio attorno al mio organo che sostiene il mio capo, si accinge al pensiero, percorre con quelle lagrime sue, che non sono morte, lo spazio del mio sorriso. Risultiamo attimi sottratti alla lotta così protocolli di incontro, capitoli di una narrazione incatenata al nulla eccitato quanto la cenere. Ci siamo lasciati devastare, reggendo il ritorno alle macchine che siamo stati sempre. Poi in mezzo, come avventura liminare, la venata tenda, il tempo della solitudine annoiata, un ricordo che fende l’aria destinata a ogni schermo di una vita, i sentimenti deragliati e fatui, riconoscente fondo l’impazienza, risa ulteriori giri di parole, le rincorse nel dolore e con i denti macchiati di parole, verbi veloci. Non misurano più il singolo morto, il cadavere da tumulare: sono formati standard. Ogni scompenso non taglia le carni di rigore, non opera sull’antico muscolo chiamato donna, una citazione di inadeguatezza, sono morta io lottando con i compagni vicini e ormai distanti: senza perdono. Né questa facile memoria di ogni tremito potente di contatti e collisioni, una storia inscritta nelle spoglie di una città di ora. Stiamo continuando a vincere.