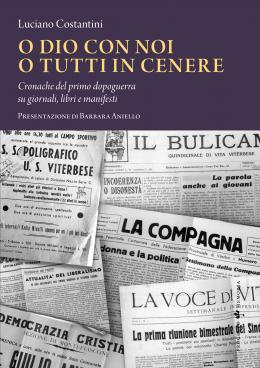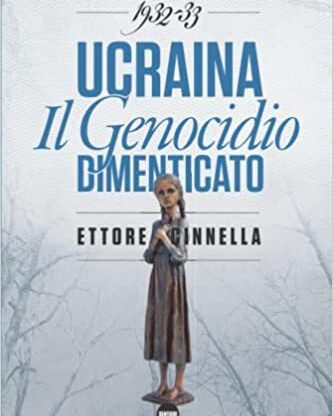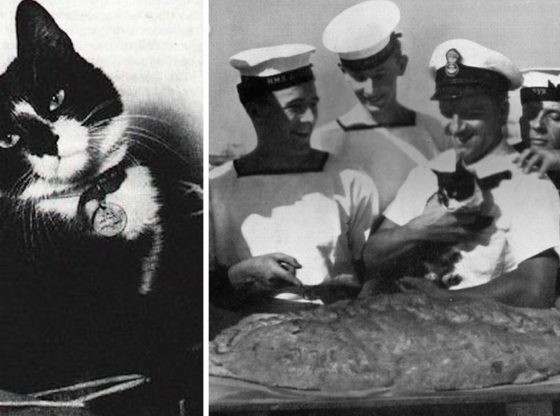Elie Wiesel fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1986 e definito “messaggero per l’umanità”.
E’ stato uno scrittore, giornalista, saggista, filosofo, attivista per i diritti umani, ma tra le decine di suoi libri è “La notte” quello in cui racconta la sua dolorosa testimonianza di sopravvissuto allo sterminio ebraico che può essere, a buon diritto annoverato tra quelle opere che tutti dovrebbero conoscere ed onorare per preservare la memoria della Shoah. Oggi più che mai.
“Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata”
Ed è la notte una sorta di filo conduttore che lega e informa le vicende di Elie Wiesel: l’ultima notte nella sua casa, l’ultima notte nel ghetto, l’arrivo del treno di notte ad Auschwitz e la prima notte nel campo che ha reso, appunto, la sua vita “una lunga notte”.
Viene forse in mente la massima di Seneca “lieve è il dolore che parla. Il grande è muto”, di fronte al silenzio di Elie che per dieci anni ha taciuto la sua vicenda: come tanti altri reduci, era convinto che nessuno gli avrebbe creduto, proprio come tanti anni prima, nessuno, lui compreso, aveva creduto a Moshè lo Shammàsh, personaggio che troviamo all’inizio della narrazione.
Viveva a Sighet, cittadina della Transilvania di Ebrei praticanti, Eliezer Wiesel, detto Elie, nato nel 1928 da genitori commercianti. Voleva essere un mistico, un cultore della religione ebraica, e a soli dodici anni nel 1941, studiava il Talmùd ma sognava di conoscere la Cabbalà. Fu un povero inserviente straniero di una sinagoga chassidica, dalla vita grama, Moshe lo Shammàsh, che ogni sera intratteneva il ragazzo a discutere su problematiche esistenziali, sugli imperscrutabili disegni divini, sui misteri della Cabbalà. Ma l’uomo fu cacciato via con altri ebrei stranieri: ben presto tutti dimenticarono i deportati, la vita scorreva tranquilla e agiata a Sighet, ma Moshè lo straccione tornò, aveva lo sguardo inespressivo, non cantava, non parlava più di Dio e non pregava più: raccontava di un terribile eccidio messo in atto dalla Gestapo da cui si salvò perché creduto morto. Nessuno volle credergli. Era la fine del 1942.
Trascorsero il 1942 ed il 1943, arrivavano le notizie trasmesse da radio Londra sugli sviluppi della guerra che sembrava però lontana agli ottimisti abitanti di Sighet. Emerge nella narrazione proprio il distacco con cui essi sentivano parlare dei bombardamenti, di entità che a loro apparivano astratte, come il fascismo ed il nazismo, dell’occupazione di altri territori europei, dei bombardamenti: solo per brevi istanti serpeggiava in loro l’inquietudine ma subito veniva dissipata. Persino quando i tedeschi occuparono la città, i più ottimisti li trovavano addirittura rassicuranti sebbene portassero un inquietante teschio nell’elmetto.
Ma poi gli eventi precipitarono ed in breve tempo la cittadina fu occupata, i suoi abitanti trasferiti in due ghetti nei pressi della città e dopo pochi giorni costretti a privarsi dei loro averi prima di marciare verso la stazione ed essere caricati nei carri bestiame,
“Siete ottanta in un carro – aggiunse l’ufficiale tedesco- se qualcuno manca sarete fucilati come cani… Le porte vennero richiuse. Eravamo in trappola fino al collo. Il mondo era un carro ermeticamente chiuso.”
Dopo strazianti giorni di viaggio, la notte più cupa fu quella in cui qualcuno lesse un cartello con un nome ignoto: “Auschwitz”. Poi il treno proseguì per Birkenau, non molto distante, prima che le porte si aprissero: buio, fiamme, un mefitico lezzo nell’aria, curiosi personaggi con delle giacche a righe che li bastonavano per introdurli nel luogo a loro destinato. Elie fu costretto a separarsi dalla madre e dalla sorellina ma rimase con il padre Shlomo. Durante il tragitto immagini infernali agli occhi del quindicenne Elie, ma fu solo il terrificante inizio dell’indescrivibile luogo che in poche ore già aveva mostrato il suo volto più aberrante: dopo inaudite violenze fisiche e il consueto rituale di disumanizzazione e privazione di ogni forma di dignità , divenne il numero A-7713 e una nuova marcia lo portò fino ad un altro campo attiguo: un cancello di ferro, con su in alto scritto: “il lavoro rende liberi”
Seguì un’ altra destinazione: Buna-Monowitz, duro lavoro sotto la sorveglianza di un essere spregevole e feroce che dispensava sevizie e violenze fisiche inenarrabili. L’unica ragione di vita di Elie diventa il cibo: “il pane, la zuppa: tutta la mia vita. Ero un corpo, forse ancora meno, uno stomaco affamato”
Ma le privazioni, il freddo, gli stenti, il dolore delle percosse ricevute non erano neppure paragonabili, seppur atroci, alle violenze psicologiche come quelle di assistere alle esecuzioni di altri prigionieri, senza poter levare lo sguardo per non subire la stessa fine.
“Dietro di me sentì un uomo domandare: “dov’è dunque Dio?” E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: eccolo, è appeso lì a quella forca.”
In Elie quel barlume di fede che inaspettatamente ancora albergava nel suo cuore e in quello dei più ligi praticanti, vacilla e si spegne, lui che un tempo era stato un mistico, convinto fermamente che anche solo una preghiera avrebbe potuto salvare il mondo. Ecco la sua reazione dopo le preghiere nella notte in cui terminava l’anno ebraico: “Perché benedirlo? Per aver creato nella sua grande potenza Auschwitz, Birkenau, Buna e tante altre fabbriche di morte? […] Ci hai eletto tra i popoli per venire torturati giorno e notte, per vedere i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli finire al crematorio?”
E ancora: “Ero io l’accusatore e l’accusato Dio. I miei occhi si erano aperti, ed ero solo al mondo, terribilmente solo, senza Dio, senza uomini; senza amore né pietà. Non ero altro che cenere, ma mi sentivo più forte di quell’Onnipotente al quale avevo legato la mia vita così a lungo.”
Il gelo invernale, il tormento delle selezioni del dottor Mengele, furono altre terrificanti prove da superare prima dell’evacuazione del campo e la marcia della morte sotto continue tormente di neve, anche di notte, che decimarono i prigionieri ridotti allo stremo dai chilometri percorsi e dai digiuni. Dopo una sosta nel campo di Gleiwitz, la marcia della morte continuò nel gelo su vagoni aperti prima di terminare a Buchenwald, dove per Elie si consumò l’ultima straziante tragedia: la morte dell’adorato padre. Si può sottolineare un altro aspetto della vicenda che colpisce profondamente il lettore: il rapporto di Elie con suo padre Shlomo, l’elemento propulsore che genera nei due personaggi la forza reciproca di resistere. In un certo senso si invertono i ruoli e il padre diviene l’essere più fragile e da proteggere, sebbene Elie sia consapevole della sua impotenza ed impossibilità di farlo. Colpisce profondamente l’umanissimo terrore di essere separati durante le selezioni, la paura di perdere l’unico sentimento puro rimasto in quell’abisso di degradazione. Ecco i pensieri di Elie durante la marcia: “La morte mi avvolgeva fino a soffocarmi, l’idea di morire di non essere più, cominciava ad affascinarmi[…]La presenza di mio padre era l’unica cosa che mi tratteneva, correva al mio fianco, senza fiato, allo stremo delle forze, alla fine. Io non avevo il diritto di lasciarmi morire: che avrebbe fatto senza di me?”
Queste invece le parole di Shlomo morente: “Ascoltami bene, piccolo: non dimenticare che sei in un campo di concentramento. Qui ognuno deve lottare per se stesso e non pensare agli altri . Neanche al proprio padre. Qui non c’è padre che tenga, né fratello, né amico. Ognuno vive e muore per sé, solo”.
Due mesi ancora nel campo, ma nulla scalfiva più il suo animo impietrito ora che suo padre non c’era più, solo l’istinto insopprimibile di nutrirsi lo tenne in vita. Ma il 10 aprile arrivò la liberazione, la fine di tutto, ma solo in apparenza.
“Un giorno riuscì ad alzarmi, volevo vedermi nello specchio… Dal fondo dello specchio un cadavere mi contemplava. Il suo sguardo nei miei occhi non mi lascia più”.
Questa, in breve è la vicenda della prigionia di Elie Wiesler. Mai parole furono più adatte di quelle di Primo Levi: “Meditate che questo è stato”.
Graziella Enna
 La notte
La notte
Saggistica, ebraismo
Giuntina
2007
112