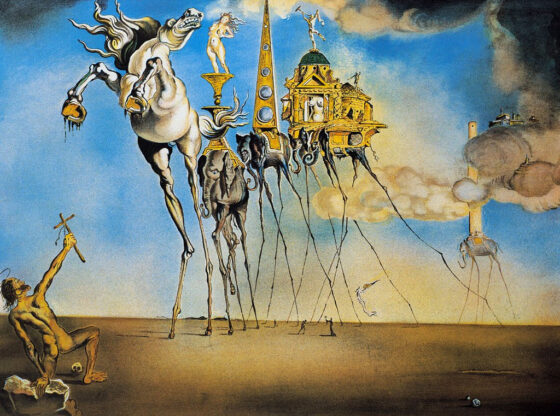Il piroscafo
Di Laura Vargiu
Alla fine era arrivato.
Dopo una serie di falsi allarmi che si erano susseguiti ansiosamente nel corso dei mesi precedenti, in molti avevano iniziato a credere – forse sperandolo – che il momento della partenza non sarebbe mai giunto. Invece, all’improvviso, il piroscafo era lì, davanti ai loro occhi, e pareva volesse ingoiarli tutti. Più che di una nave passeggeri, aveva l’aspetto di una da carico; e nemmeno con pochi anni addosso.
«Presto o tardi ci porteranno via, siatene certi… Non ci lasceranno per sempre su quest’isola!»
Imperterrito, Domenico aveva continuato a ripetere quelle parole, agli altri ma soprattutto a se stesso, forse per sentirsi meno impreparato il giorno in cui i tedeschi li avrebbero fatti imbarcare per davvero. In verità, non gli erano state di grande conforto quando, al termine della lunga marcia tra le strade fangose di Rodi, per lui e i compagni s’era profilata la grigia sagoma del bastimento che attendeva al porto il suo carico umano.
Tutto era grigio quel giorno: il cielo, il mare, gli uomini stessi, ridotti alla triste ombra dei soldati di un tempo. Ci si era poi messa pure la pioggia a incorniciare il quadro spettrale della partenza, infradiciando, a più riprese, corpi e pensieri ammassati sul molo in balia del destino e del freddo pungente di un inverno non ancora concluso. L’imbarco si protraeva già da un po’. Alla voce inquieta del mare s’intrecciavano le urla imperiose dei militari tedeschi che, con le armi spianate, dirigevano le operazioni di carico; dalla stiva traboccavano lamenti che intimorivano l’avanzare di chi ancora si trovava a terra o saliva sulla scala.
“Dio mio!” pensava Francesco, seguendo la fila giusto un passo davanti al compagno Domenico. “Ma in quanti vogliono stiparci là dentro?”
Il medesimo interrogativo, disorientato e atterrito, che tutti i prigionieri si ponevano e al quale non poteva non fare immediato seguito un’altra domanda, anch’essa priva di risposta, circa la destinazione finale del viaggio ormai prossimo. Improbabile che l’intenzione fosse quella di riportarli in Italia. Era già tanto che non fossero stati fucilati dal primo all’ultimo all’indomani di quel maledetto otto settembre che li aveva condannati senza scampo. Soltanto i più ottimisti, o i più ingenui, ancora riuscivano a credere, pur alla luce fioca degli avvenimenti recenti, nella possibilità di un ritorno a casa; tra costoro non mancava Francesco, aggrappato com’era alle proprie ostinate speranze che si riassumevano tutte in due semplici, disarmanti parole da lui stesso incise sulla sua gavetta: “Mamma ritornerò”.
Faceva pena quel giovane soldato dall’animo sognatore, suscitando qualche sorriso amaro nei cuori disillusi dei commilitoni più adulti, come Domenico, che della loro vicenda non vedevano altro esito se non quello decretato, un giorno o l’altro, da un colpo alla nuca. Il lieto fine sarebbe stato forse per altri, specie per gli alti comandi delle grandi imprese belliche studiate a tavolino, ma non per loro, semplice carne da macello, dimenticati laggiù alla mercé della rabbia e della vendetta altrui. Bestia strana, la guerra, famelica e proterva: una di quelle malattie insanabili che dapprima infiammano gli animi per poi gelare il sangue; uno sporco gioco d’azzardo che rimescola subdolamente le carte in tavola per confondere amici e nemici; la più colossale truffa ai danni dei poveri diavoli di ogni tempo e luogo, ai quali si promette tutto per dar loro infine il solito niente.
«Schnell[1]!» berciò poco distante uno dei tedeschi in quella sua lingua dai suoni taglienti che, a tratti, sferzavano le orecchie. Domenico riassaporò il calcio di un fucile nella schiena.
Poco più avanti altre guardie armate, prima di spingerli verso la scala, perquisivano in malo modo alcuni ufficiali nell’ingorda speranza di arraffare gli ultimi oggetti personali. Avevano fretta di concludere l’imbarco e partire, appariva chiaro. Il piroscafo, invece, non tradiva impazienza e ogni più recondito spazio del suo ventre sembrava anzi ben disposto a continuare ad accogliere la marea umana che forzatamente vi si riversava: l’ideale, in apparenza, per il trasporto di uomini che agli occhi degli ex alleati avevano meno valore delle bestie o delle più svariate merci. Chissà se ne avesse già trasportati in così gran numero, come si apprestava a fare stavolta. Di certo, la nave doveva racchiudere in sé molte storie poiché giungeva da lontano, dopo aver toccato altre destinazioni mediterranee e percorso, non era da escludere, persino qualche rotta atlantica. Se avesse avuto il dono
della parola, le avrebbe magari raccontate quelle sue storie di uomini e mare, di traffici e tempi trascorsi. E Francesco le avrebbe pure ascoltate volentieri. Ma proprio in quegli istanti la scala reclamava ogni attenzione; toccava a lui salire. Domenico fece per seguirlo, quando un «Halt!» inaspettato lo bloccò ancor prima di mettere piede sul primo gradino. Dal ponte uomini dell’equipaggio si sbracciavano in modo concitato, come a voler segnalare che nella stiva non vi fosse più posto.
«Tu no!» gli intimò in un brusco italiano il soldato di quella postazione, sbarrandogli il passo col fucile e con esso ricacciando subito indietro lui e gli altri che avanzavano in coda. Francesco si voltò per rendersi conto, non senza sgomento, di essere dunque l’ultimo uomo ammesso a bordo, mentre quasi la metà della propria compagnia veniva lasciata a terra.

Più volte Domenico incontrò lo sguardo smarrito che il ragazzo, durante la salita, rivolse verso il basso man mano che procedeva stretto gelosamente alla sua gavetta, tutto ciò che gli fosse rimasto in mano; quel suo accorato e muto “Mamma ritornerò” mai era risuonato tanto penoso come allora. Finché non scomparve, inghiottito anche lui dall’inferno di voci che si disperdevano nell’aria all’impietoso calar della sera e all’ingrossarsi del mare.
Ormai pioveva a dirotto. Sui volti della massa logora e stanca rimasta sulla banchina, in attesa di altra sorte, non si distingueva la pioggia dal pianto.
E così, carico d’esistenze e sogni sospesi, nonché colmo d’addii non pronunciati, il piroscafo prese il largo, già portando con sé l’ultima sua storia che solo in pochi, un giorno, avrebbero potuto raccontare
L’undici febbraio del 1944 l’Oria, un piroscafo da carico norvegese, salpò da Rodi alla volta del Pireo, il porto di Atene. A bordo oltre quattromila soldati italiani, fatti prigionieri sull’isola dai tedeschi dopo l’annuncio dell’armistizio nel settembre del ’43
Destinati a essere trasferiti nei campi di lavoro in Germania, essi erano stati ammassati in numero spropositato rispetto alla reale capienza della nave che, durante la notte del 12 febbraio, complici le avverse condizioni del mare, affondò nei pressi di Capo Sunio, un promontorio situato non lontano dal porto di destinazione. Tra italiani, tedeschi e membri dell’equipaggio, si salvarono pochissime decine di uomini. Non tutti i corpi verranno poi restituiti dal mare.
Al di là della sbrigativa etichetta di “dispersi” e pur essendo a conoscenza di quanto accaduto, lo Stato italiano non diede risposta al dolore delle famiglie in attesa dei propri congiunti che avevano perso la vita in quella tragedia dimenticata nelle acque dell’Egeo. Quello del Piroscafo Oria rappresenta uno dei peggiori disastri navali di tutti i tempi.
[1] “In fretta!”, in tedesco.
Il racconto è contenuto nel libro Viaggi. Racconti mediterranei, edizioni L’Argolibro 2016