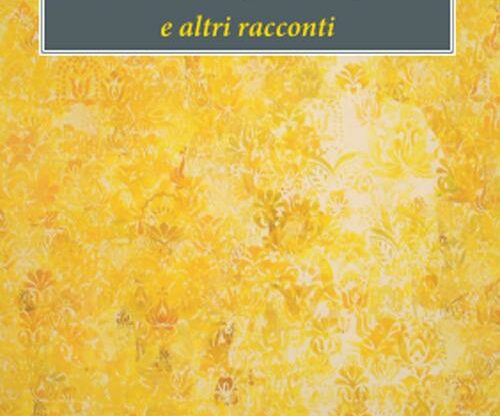In principio
Di Arianna Bonino
Assistere al suicidio di un padre, soprattutto se succede quando chi lo vede ha sette anni, è cosa che non può essere superata. Probabilmente si rimane con quello stupore e con l’inconfutabile logica di quella scelta. Fa specie che il suicidio sia detto “insano gesto”, forse nel tentativo di ridurre con la sinedocche la dichiarazione di morte di sé resa da sé; diversamente sarebbe oscena e scabra a dirsi questa cosa che è privarsi di esistere, dell’unica supposta proprietà vera, e farlo davanti agli occhi di un figlio bambino. E quell’ “insano” è ancora più grottesco: l’intenzione giudicante delle parole non convince e non vince. Vedere un padre togliersi da mezzo: la vista si perde, gli occhi si rovesciano indietro e dentro, e poi tornano a guardare avanti e quel padre non c’è più. Il mondo si capovolge per un istante appena, ma non si ferma, procede lineare. Intanto è fatto buio dentro. È solo questione di tempo, e sarà fin troppo – oppure poco – dipende dal lato del microscopio in cui si scruta.
Visto che tutte le storie vere partono dalla fine, come voleva Jaques Rigaut (anche perché, come lui scriveva, l’inizio delle cose non esiste, lo si cerca perché da qualche parte bisogna pur partire), decido di cominciare dalla fine, quella c’è: Vsevolod Garšin morì il 5 aprile del 1888, a pochi giorni dal salto che fece lanciandosi dal quarto piano del suo appartamento. L’”inevitabile epilogo”, si direbbe, guardando in controluce da cosa sia stata imbevuta la trama dei suoi trentatré anni.
“Insano gesto” di padre porta ad “inevitabile epilogo” di figlio. Furono i suoi occhi infantili a inquadrare la scena del padre che, stravolto dall’esperienza della guerra, non si curò di quello sguardo o forse non se ne accorse (e se invece lo avesse addirittura cercato?).
Tra i due capolinea ci sono una ventina di storie scritte da Garšin e la diagnosi di malattia mentale. Il solito quadro romantico. E così mi sono tolta da davanti quello che non si dovrebbe mai fare e si finisce per fare sempre: scandagliare la vita di chi scrive prima di leggere quel che ha scritto. Adesso devo essere così brava da leggere le storie di Garšin come se non ne sapessi nulla di quel padre, della guerra, di lui arruolato nonostante il suo pacifismo, dello schifo che ne provò, dei suoi tormenti mentali, del suo giovane suicidio.
Scelgo una delle novelle meno note: Attalea Princeps. Il titolo è il nome di una pianta. La storia è una favola breve, mi vien da dire breve come lui, ma non devo pensarci. È una palma brasiliana l’Attalea Princeps e quella della storia si trova in una serra di vetro, insieme ad altre piante, di diversa grandezza e aspetto, una grande serra che le protegge e le carcera. La serra di vetro è bella da vedere e cattura piante di origine lontanissima che crescono e vengono tenute sott’occhio dal clinico – e cinico – ricercatore che si premura di farne ridurre le estensioni ribelli che potrebbero mettere a rischio l’integrità della struttura, premendo dall’interno per uscire:
« Dirigeva il giardino botanico un illustre scienziato, che non tollerava alcun disordine, benché trascorresse la maggior parte del tempo al microscopio, nel suo studio privato, anch’esso di vetro, posto nella serra principale.»
L’immagine è una vertiginosa mise en abyme di rifrazioni e trasparenze impenetrabili: il vetro su cui poggia la sostanza osservata dal vetro della lente del microscopio, osservato dall’occhio vitreo anch’esso del ricercatore, chiuso nel cubo di vetro del suo laboratorio, cella anch’essa ingabbiata nella grande serra di vetro: mondi contenuti uno nell’altro, prigioni che non si parlano. Il ricercatore ha gli occhi chini sulla lente del microscopio, ingrandisce artificialmente un frammento. Le piante, e su tutte l’Attalea Princeps, guardano in alto, ai grandi spazi esterni e lontani, liberi e impossibili da conquistare.
Il desiderio di evasione è condiviso da tutte le piante, che nella fiaba dialogano in un delizioso coro multiforme, personificate in tipi psicologici dalla formidabile capacità di Garšin di comporre minuziosi ritratti in poche pennellate; si intrecciano nei dialoghi arboricoli la vanità dell’arrogante palma di sago, l’egoismo della panciuta cannella, l’umile essenzialità della felce, il cieco ottimismo del cactus. Ma c’è qualcosa che distingue L’Attalea Princeps da tutti gli altri vegetali che abitano la cella cristallina: lei non è ancora rassegnata alla cattività, sogna di liberarsi, crede di poter evadere davvero e manifesta il coraggio che un’azione tanto ardita richiede. Un ardimento che è duplice: lo sforzo dell’evasione potrebbe rivelarsi al di sopra delle reali capacità, così come è sconosciuto il mondo che là fuori l’attende, dopo quella minacciosa liberazione. La pianta non si scoraggia, nonostante il resto della flora le dipinga davanti agli occhi la teoria di ragioni per cui desistere da propositi tanto estremi. Un’erba banale e misera è l’unica a sostenerla nel suo ideale, pur non avendo alcuna forza fisica per unirsi all’ Attalea.
Ma ci sono anche umani in questa fiaba. Di uno ho già detto: il freddo scienziato. E poi entra in scena un personaggio chiave della storia: è a lui che si deve l’irrevocabilità della decisione di fuga maturata dall’Attalea. È un visitatore straniero, viene da lontano, da quel Brasile che è la terra madre anche della nobile pianta. Il misterioso visitatore si compiace di tanta bellezza verde e quando scorge l’altissima palma, la riconosce:
« “Ah”, disse “conosco questa pianta”. E ne pronunciò il vero nome. “Scusate” lo corresse ad alta voce dal proprio studio il direttore, che stava tagliando con cura degli steli con un bisturi “ma vi sbagliate, una pianta con quel nome non esiste. Questa è un’Attalea Princeps, originaria del Brasile”.
“Oh, sì” disse il brasiliano “vi credo con tutto il cuore, i botanici la chiamano Attalea, ma il suo nome vero è un altro”. “Il nome vero è quello che le ha dato la scienza” disse seccamente il botanico, e chiuse la porta del suo studio perché nessuno lo disturbasse, soprattutto la gente che non capisce che quando parla un uomo di scienza si deve tacere e ascoltare.”»
È questo è il momento più feroce del racconto, quello in cui la violenza è totale: il nome vero non esiste, l’identità è cancellata, la pianta si chiama come decide arbitrariamente di chiamarla – di riqualificarla – la scienza che in questo caso è l’autorità cieca e mortale che ha carcerato l’essere, annullandolo come soggetto vivente e riducendolo ad oggetto d’analisi.
Ma quel nome è stato pronunciato e con quel suono vero la pianta risveglia sé e il suo desiderio potente di esplodere fuori dal mondo di vetro in cui è costretta, come annuncia ai vegetali passivamente rassegnati al proprio destino: «Ora so cosa devo fare. Vi lascerò in pace: continuate a vivere come volete, brontolate fra voi, litigate per l’acqua e rimanente per sempre sotto questo cappello di vetro. Anche da sola troverò la strada giusta.»
La pianta cresce, si eleva, si fa forte, erompe in tutta la sua potente bellezza, fino a scontrarsi con la costrizione dell’inferriata: si piega, non avendo altra via di fuga, ma è solo una flessione momentanea: «”…O morirò o riuscirò a essere libera”». Un motto perfettamente romantico, ma c’è un’ombra grande qui, anche se mi ero ripromessa di non guardarla. Certo che è davvero ingombrante, irriducibile. Anche l’Attalea non si contiene e rompe quella gabbia, spaccando i vetri infine. Ma quel che appare della libertà sognata è un riflesso agghiacciante, mortale: «”Tutto qui? È per questo che ho sofferto e mi sono tormentata tanto a lungo?”».
C’è neve fuori, mista a vento e alla pioggia autunnale. C’è ghiaccio e tornare indietro è impossibile e nemmeno lo desidera. Ma non ci sono il tempo e il modo di chiederselo: la pianta viene abbattuta, inesorabilmente, così come i suoi resti gettati come pattume scompaiono sotto una coltre bianca e fredda.
Forse morire non serve a niente, come anche vivere.
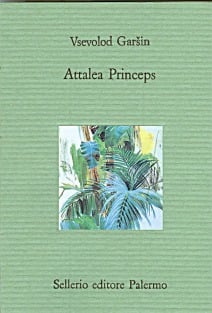 Attalea princeps
Attalea princeps
IL Divano
Letteratura
Sellerio
1992
32 p., brossura