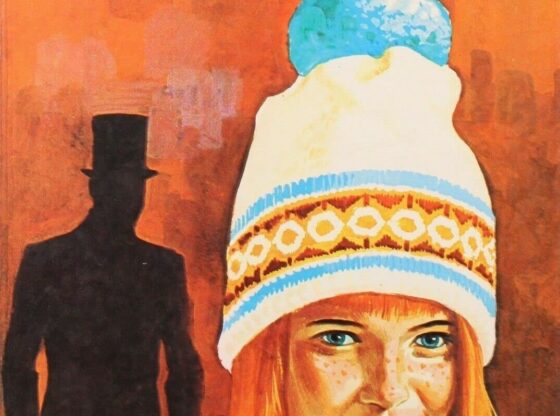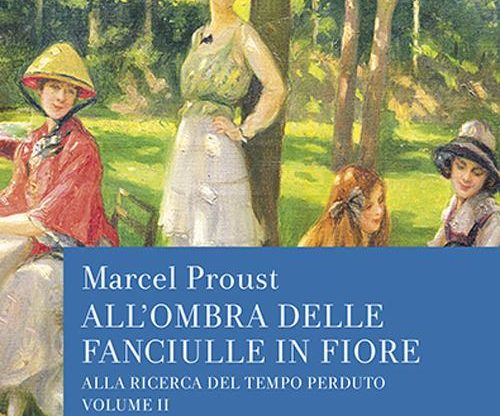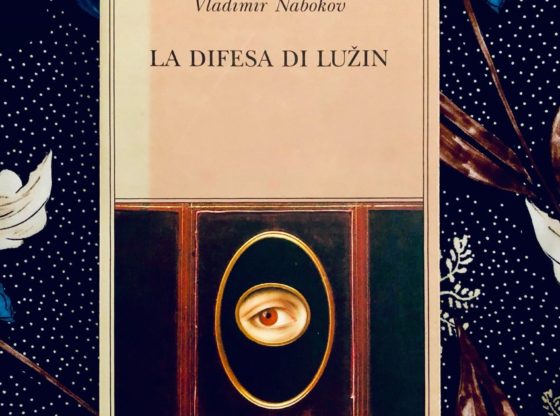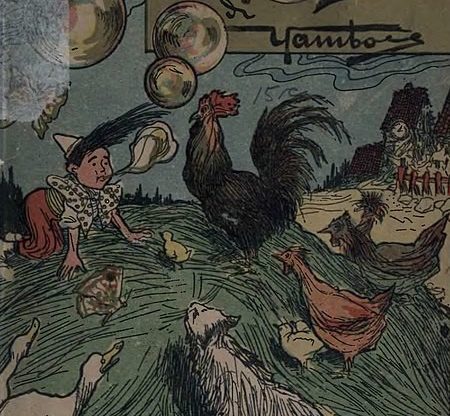Pietre, residui e oggetti impoetici
Di Graziella Enna
Nella lirica del Novecento, non solo italiana, sono presenti molti poeti che in polemica con l’aulicismo e il simbolismo, elaborano una poetica incentrata su oggetti desueti nella poesia e addirittura su pietre, inutili resti e insignificanti scarti. I poeti novecenteschi si interrogano sulla loro funzione e sul loro ruolo e si rendono conto della totale mancanza di certezze, vogliono contrapporsi al modello dannunziano, mentre accolgono, rielaborano e riadattano alcuni aspetti del modello pascoliano. La poesia del Novecento si riduce dunque alla scarnificazione della parola, all’abbandono, al prosciugamento, all’essenzialità, diventa espressione di un’età lacerata dalla Grande Guerra e dall’avvento dei totalitarismi. Indubbiamente la “pietra” più celebre è quella ungarettiana della famosa lirica “Sono una creatura” del 1916 (dalla prima raccolta “Il porto sepolto”):
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo
Questo componimento ha portato la critica a parlare di un Ungaretti “petroso”. In effetti egli è il precursore di poeti novecenteschi che tratteranno il processo di mineralizzazione e prosciugamento dell’io: nella lunga similitudine della breve lirica il poeta si identifica nella brulla pietra carsica per esprimere la propria impotenza di fronte al dolore dell’esperienza bellica. Intorno a lui vede solo desolazione e aridità nel paesaggio carsico. Il valore allegorico della pietra per esprimere una condizione interiore, gli giungono tuttavia dalla lirica di Dante e di Petrarca. In particolar modo l’elemento pietra rimanda alle “rime petrose” dantesche composte per una donna, il cui nome, Pietra, costituisce un senhal per indicarne la durezza, la repulsione all’amore, l’ ostilità e l’ insensibilità. La lirica “Così nel parlar vogl’esser aspro”, considerata l’ultima delle petrose è perciò costruita su un linguaggio aspro e difficile per esprimere una passione esasperata fino all’odio e segue la tecnica del trobar clus provenzale. Nella prima strofa il poeta afferma di voler essere duro così come donna Petra è dura di cuore, che ha una natura sempre più crudele, lo fa soffrire e lo tiene lontano; i suoi colpi bassi, come se avessero le ali, lo raggiungono spezzando ogni sua difesa . Non c’è protezione che ella non possa annientare .
Così nel mio parlar voglio esser aspro
com’è ne li atti questa bella petra,
la quale ognora impietra
maggior durezza e più natura cruda,
e veste sua persona d’un diaspro
tal che per lui, o perch’ella s’arretra,
non esce di faretra
saetta che già mai la colga ignuda;
ed ella ancide, e non val ch’om si chiuda
né si dilunghi da’ colpi mortali,
che, com’avesser ali,
giungono altrui e spezzan ciascun’arme:
sì ch’io non so da lei né posso atarme.
Nel finale che ha un sapore quasi gnomico è evidente la volontà del poeta di vendicarsi sulla donna e si appella alla canzone perché colpisca Petra che l’ ha conquistato e le trapassi il cuore con una freccia, in modo da acquistare onore con la vendetta.
Canzon, vattene dritto a quella donna
che m’ha ferito il core e che m’invola
quello ond’io ho più gola,
e dàlle per lo cor d’una saetta,
ché bell’onor s’acquista in far vendetta.
Altre parole petrose e stesse tematiche si possono trovare nelle prime due sestine del componimento “Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra” in cui egli descrive il paesaggio dell’anima in cui gli elementi naturali si ricollegano alla donna, alla sua avvenenza ma anche alla sua durezza di fanciulla-pietra. Ecco la prima strofa in cui il poeta anche nella stagione invernale, metafora della vecchiaia, non sente più debole il desiderio perché esso è radicato nella dura pietra, la sua amata, ma quella strana creatura si mantiene gelida come la neve che non si scioglie neppure in primavera quando le colline ritornano verdi e fiorite.
Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra
son giunto, lasso!, ed al bianchir de’ colli,
quando si perde lo color ne l’erba;
e ’l mio disio però non cangia il verde,
5si è barbato ne la dura petra
che parla e sente come fosse donna.
Anche Petrarca utilizza l’immagine della pietra, egli reca nel suo stesso nome, dal valore simbolico, la parola “petra” legato alla parola “arca”. Nella celebre canzone 129, una delle più ammirate da Leopardi, “Di pensier in pensier, di monte in monte”, segue la cifra del paesaggio-stato d’animo, alla ricerca di luoghi solitari e remoti in cui sfuggire al mondo e celare il suo tormento interiore, sulla scorta della rimembranza e dell’immaginazione. Racconta una vicenda di metamorfosi della sua anima e nella quarta stanza (vv. 40-52) immagina di vedere nella sua solitudine la sua donna viva e dalla bellezza ineguagliabile, ma quando poi subentra la percezione della sua reale condizione si sente come pietrificato su una pietra vera e diviene un tutt’uno con essa: parole, il pianto e i pensieri sono pietra.
I’ l’ò piú volte (or chi fia che mi ’l creda?)
ne l’acqua chiara et sopra l’erba verde
veduto viva, et nel tronchon d’un faggio
e ’n bianca nube, sí fatta che Leda
avria ben detto che sua figlia perde,
come stella che ’l sol copre col raggio;
et quanto in piú selvaggio
loco mi trovo e ’n piú deserto lido,
tanto piú bella il mio pensier l’adombra.
Poi quando il vero sgombra
quel dolce error, pur lí medesmo assido
me freddo, pietra morta in pietra viva,
in guisa d’uom che pensi et pianga et scriva.
Tornando alla poesia del Novecento, il poeta russo Osip Mandel’stam (1891 – 1938), considerato a buon merito uno dei più grandi poeti russi di quel secolo, pubblica la raccolta “Kamen”, (“La pietra”) nel 1913 molti anni prima di essere perseguitato dal regime staliniano e di trovare la morte in un gulag siberiano. Il termine russo kamen è anagramma di akmè, termine greco alla base del movimento chiamato Acmeismo, a cui il poeta appartiene. La lirica dal titolo “La conchiglia” evidenzia la cifra della poetica dell’autore: egli abbandona la dimensione soggettiva e simbolista per approdare ad una lirica in cui tutto ciò che è materiale, concreto e oggettivo è considerato degno di poesia. Egli utilizza, in contrasto, un linguaggio solenne con lo scopo di riabilitare la prosaicità della realtà che lo circonda pur trattando oggetti sdegnati dalla poesia. La sua profonda cultura classica, la ricerca di un linguaggio sublime, le influenze di Dante e Petrarca, (che egli conosceva a memoria in italiano), gli permettono di raggiungere un’arte raffinata.
Notte, forse di me non hai bisogno;
dalla voragine dell’universo
io – conchiglia senza perle – sono
gettato sulla tua proda, riverso.
Con noncuranza fai schiumare i flutti
e riottosamente vai cantando,
ma la bugia d’una conchiglia inutile
ti sarà oggetto d’amore e di vanto.
Verrai a giacerle accanto sulla sabbia
e a ricoprirla della tua pianeta;
a renderla, verrai, inseparabile
dall’enorme campana degli abissi irrequieti;
e il vano della fragile conchiglia –
nido di un cuore ove nessuno alloggia –
ricolmerai di schiuma che bisbiglia,
ricolmerai di nebbia, vento e pioggia…
Mandel’stam, anche in un’altra lirica del 1912, sempre tratta dalla suddetta raccolta, parte da materiali e oggetti modesti e li esprime con un linguaggio preciso e ben definito:
Una fiamma disperde
la mia arida vita;
e accantono la pietra:
ora il legno mi ispira.
Esso è rozzo e leggero:
da un tronco vengon fuori
e midollo di quercia
e remi di pescatore.
Sotto, a configger pali!
Fate risuonare, o mazze,
un ligneo paradiso
di oggetti imponderabili!
Tra i poeti italiani del Novecento Guido Gozzano, (esponente di spicco della corrente crepuscolare), contrappone a una lirica aulica, o come dirà Montale per “poeti laureati”, la prosaicità e grettezza del quotidiano, offrendo elenchi di oggetti e inutile ciarpame definiti “buone cose di pessimo gusto”, riposte in stanze chiuse, simbolo di immobilità e riflesso dell’incapacità del poeta di aderire alla realtà che lo circonda. Gli oggetti rappresentati non hanno dunque un valore analogico e simbolico, come nella lirica decadente, ma indicano il processo di trasformazione dell’io in oggetto, la cosiddetta “reificazione” tipica non solo di Ungaretti, Gozzano ma anche, da lì a poco, di Sbarbaro e Montale. Le cose rappresentano inoltre la nostalgia per un passato foriero di malinconia seppur descritto in modo ironico. Una delle liriche più rappresentative di questi temi può essere considerata “L’amica di nonna Speranza”, tratta dalla raccolta “I colloqui” (1911). Nella prima strofa si ha un’enumerazione foltissima di oggetti che il poeta immagina in un salotto piemontese del 1850: il salto nel passato scaturisce dall’osservazione di una vecchia foto della nonna Speranza datata 1850 e dedicata alla sua amica Carlotta. Gli oggetti elencati sono solo ciò che resta di una passato tranquillo e certo che ormai non esiste più e divengono il simbolo dell’inaridimento dello spirito. Un altro aspetto importante è l’accostamento degli oggetti più disparati, dal pappagallo impagliato alle stoffe damascate, a termini aulici della tradizione letteraria, uno per tutti il verbo dantesco e pascoliano “immilla”.
Loreto impagliato e il busto d’Alfieri, di Napoleone,
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!
il caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti,
i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro,
un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve,
gli oggetti col mònito, salve, ricordo, le noci di cocco,
Venezia ritratta a musaici, gli acquerelli un po’ scialbi,
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d’anemoni arcaici,
le tele di Massimo d’Azeglio, le miniature,
i dagherottipi: figure sognanti in perplessità,
il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto,
il cúcu dell’ore che canta, le sedie parate a damasco
chermisi… rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta!
Anche poeta Camillo Sbarbaro, segue la cifra dell’aridità, della secchezza, di oggetti pietrificati in cui l’io del poeta sembra quasi mineralizzarsi. Nella prima delle prose poetiche appartenenti alla raccolta “Trucioli”, del 1920, si manifesta appunto la volontà dell’io di identificarsi in una vite, non cercando in essa gli aspetti del rigoglio e della vitalità, bensì la sua precarietà nell’essere cresciuta radicata ad un lastrico, a una pietra. Tutto richiama la percezione dell’inerzia, di una natura disanimata, infeconda a cui per un attimo contrappone l’infanzia, ormai smarrita per sempre. Non gli restano che uno sguardo vetrificato e un ciottolo pesante al posto del cuore. Il disseccamento dell’anima sofferente che si fa pietra è un topos della sua produzione poetica.
Ormai somiglio a una vite che vidi un dì con stupore. Cresceva su un muro di casa nascendo da un lastrico. Trapiantata, sarebbe intristita.
Così l’anima ha messo radice nella pietra della città e altrove non saprebbe più vivere. E se ancora m’avviene di guardar come a scampo ai monti lontani, in realtà essi non mi parlano più.
Mi esalta il fanale atroce a capo del vicolo chiuso. Il cuore resta appeso in ex voto a chiassuoli a crocicchi. Aspetti di cose mi toccano come nessun gesto umano potrebbe.
Come la vite mi cibo di aridità. Più della femmina, m’illudono la sete e gli artifizi. Il lampeggiar degli specchi m’appaga.
A volte, a disturbare l’inerzia in cui mi compiaccio affiora, chi sa da che piega di me, un mondo a una sola dimensione e, smarrita per esso, l’infanzia.
Al richiamo mi tendo, trepidante mi chino in ascolto…Ah non era che il ricordo d’un’esistenza anteriore!
Forse mi vado mineralizzando.
Già il mio occhio è di vetro, da tanto non piango;
e il cuore, un ciottolo pesante.
La raccolta “Ossi di seppia” di Montale parte da oggetti scartati, inutili residui, detriti miseri e insignificanti, come appunto gli ossi di seppia. I paesaggi presenti nella raccolta risultano pietrosi, riarsi dalla salsedine, disseccati da un’impietosa canicola che diventano metafora dell’aridità esistenziale. Il linguaggio poetico “petroso” richiama certamente Dante e si confà alla descrizione del paesaggio prosciugato, assetato e impoverito. La tematica di tutto ciò che è un rifiuto, determina un sentimento di fallimento esistenziale, pertanto la poesia è popolata dai cosiddetti “correlativi oggettivi” cioè oggetti che rappresentano la condizione esistenziale dell’uomo. Questa locuzione fu utilizzata dal poeta Thomas Eliot con l’intento di ricercare emozioni negli oggetti che ci circondano. L’arsura e il prosciugamento della natura circostante si ripercuotono sulla dimensione psicologica del poeta e causano inaridimento interiore, impossibilità di provare sentimenti vivi e intensi.
Gli oggetti prescelti sono umili, dimessi, prosaici e le realtà rappresentate, povere, poco poetiche, offrono una visione desolata del mondo. Nella sezione che porta lo stesso titolo della raccolta si legge la lirica “Gloria del disteso mezzogiorno” in cui il paesaggio è assolato, nella piena calura estiva, l’ombra è assente e la luce accecante trasfigura tutti gli oggetti facendo assumere loro l’aspetto di sagome e parvenze. Presente il motivo dell’aridità, emblema del male di vivere, evidenziato dalle parole “un secco greto”, “l’arsura, in giro”, “una reliquia di vita”, “squallore”.
Gloria del disteso mezzogiorno
Gloria del disteso mezzogiorno
quand’ombra non rendono gli alberi,
e più e più si mostrano d’attorno
per troppa luce, le parvenze, falbe.
Il sole, in alto, – e un secco greto.
Il mio giorno non è dunque passato:
l’ora più bella è di là dal muretto
che rinchiude in un occaso scialbato.
L’arsura, in giro; un martin pescatore
volteggia s’una reliquia di vita.
La buona pioggia è di là dallo squallore,
ma in attendere è gioia più compita.
Nella sezione VII dell’opera chiamata “Mediterraneo” , il poeta si confessa di fronte al mare usando l’immagine del ciottolo trasportato dalle onde, fa un bilancio della propria vita, consapevole di non aver compreso la realtà circostante, troppo ripiegato in se stesso, si sente perciò inetto e impossibilitato a reagire, inerte proprio come un sasso. Solo la voce del mare col suo canto può sciogliere il suo rimpianto.
VII
Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale
siccome i ciottoli che tu volvi,
mangiati dalla salsedine;
scheggia fuori del tempo, testimone
di una volontà fredda che non passa.
Altro fui: uomo intento che riguarda
in sé, in altrui, il bollore
della vita fugace – uomo che tarda
all’atto, che nessuno, poi, distrugge.
Volli cercare il male
che tarla il mondo, la piccola stortura
d’una leva che arresta
l’ordegno universale; e tutti vidi
gli eventi del minuto
come pronti a disgiungersi in un crollo.
Seguìto il solco d’un sentiero m’ebbi
l’opposto in cuore, col suo invito; e forse
m’occorreva il coltello che recide,
la mente che decide e si determina.
Altri libri occorrevano
a me, non la tua pagina rombante.
Ma nulla so rimpiangere: tu sciogli
ancora i groppi interni col tuo canto.
Il tuo delirio sale agli astri ormai.
Montale, ci offre dunque una poesia arida che non può comunicare certezze, ma aiuta ad acquistare coscienza della dolorosa condizione esistenziale per non cadere in facili ottimismi . Molto vicino a lui è T. S. Eliot, poeta angloamericano, che nella seconda strofa della lirica “Ciò che disse il tuono”, tratta da “La terra desolata” del 1922, utilizza «correlativi oggettivi», per esprimere la percezione tragica del mondo e la capacità di osservare la realtà senza illusioni. Il poeta vuole evidenziare le perdite e i traumi dovuti alla Prima Guerra Mondiale e ci restituisce immagini di un paesaggio scabro, inaridito, desertificato. Si serve qui dell’immagine della roccia e dell’acqua come dicotomia esemplificativa che possiede un’alta valenza simbolica.
Qui non c’è acqua ma soltanto roccia
Roccia e non acqua e la strada di sabbia
La strada che serpeggia lassù fra le montagne
Che sono montagne di roccia senz’acqua
Se qui vi fosse acqua ci fermeremmo a bere
Fra la roccia non si può né fermarsi né pensare
Il sudore è asciutto e i piedi nella sabbia
Vi fosse almeno acqua fra la roccia
Bocca morta di montagna dai denti cariati che non può sputare
Non si può stare in piedi qui non ci si può sdraiare né sedere
Non c’è neppure silenzio fra i monti
Ma secco sterile tuono senza pioggia
Non c’è neppure solitudine fra i monti
Ma volti rossi arcigni che ringhiano e sogghignano
Da porte di case di fango screpolato
Dagli esempi riportati è chiaro dunque che la poetica dei “correlativi oggettivi” informi tanta poesia del Novecento e apra la strada a un nuovo linguaggio poetico in grado di esprimere il disagio esistenziale e il senso di smarrimento, tipici di quel secolo, senza tuttavia dimenticare la tradizione poetica dei secoli precedenti e soprattutto la lezione di Dante e Petrarca, indiscussi archetipi che si pongono al di sopra di ogni corrente e tendenza rinnovandosi continuamente nella tradizione letteraria non soltanto italiana.