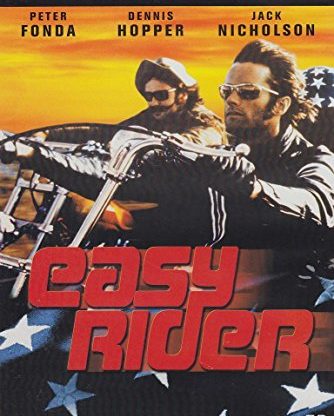“È vero, parlo dei sogni, io, figli d’una mente oziosa, generati da un’inutile fantasia fatta d’una sostanza tenue come l’aria e più incostante del vento, che spasima ora per il gelido grembo del nord, ma poi, gonfia di rabbia, si svolge sbuffando verso un nuovo amore, il sud umido di rugiada. ”
“Romeo e Giulietta”, W.Shakespeare (atto I scena IV)
A cosa servono i “nomi”? che siano nomi comuni o nomi propri, nomi di cose o nomi astratti. Cioè: a cosa servono quelle parole con cui siamo soliti designare il mondo circostante, fatto di oggetti e persone, e che sono irrinunciabili strumenti con cui ci muoviamo nella complessità di quella che viene, sbrigativamente, definita (per altro con un nome!), “realtà?
“NOME” notoriamente deriva dal greco “nomos”, termine che indicava innanzitutto la “legge”, ma che era anche in strettissimo rapporto lessicale con “nume”, il dio!, e poi con “numero”, e dunque, da un lato, con il concetto di potere, dall’altro con quello di quantità e ritmo…in altri termini il nome è qualcosa che stabilisce, o ristabilisce, un ordine, un sistema, un codice, una sequenza; un “nome” ci fissa e consolida, ci circoscrive e delimita, ci segna e ci condanna ad essere per sempre quella precisa cosa o persona. Dunque non ci si meravigli che in “Ultimo tango a Parigi” (Bernardo Bertolucci, 1972) i due protagonisti non si scambino i nomi: non potevano avere nomi perché non volevano essere parte di alcun ordine o sistema; senza il nome potevano, infatti, supporre di sfuggire ai binari incapsulanti della dimensione sociale, senza il nome la loro relazione non sarebbe stata delimitata e avrebbe, forse, conservato una pervietà, una via di fuga; è noto, d’altra parte, che il film si chiude con la richiesta di Paul (Marlon Brando) di conoscere il nome di lei, Jeanne (Maria Schneider), e quel nome viene gridato dalla protagonista, ma coperto dallo sparo della pistola con cui Jeanne uccide Paul: il “nome” risulta, dunque, latore di morte, un traumatico mezzo di interruzione della fluidità della vita, una vera e propria epigrafe lapidaria.
Va osservato, a tal proposito, che nel cinema di Bernardo Bertolucci l’uso del nome, negato o nascosto, somiglia all’uso che lo stesso regista fa del “carrello”( Dolli o Dolly), cioè della macchina da presa su binari con cui l’operatore attraversa la realtà, risalendo o ridiscendendo, dall’alto al basso, e viceversa, in un tentativo di mostrare lo spazio circostante senza volerlo, però, definire, lasciandolo libero di aggrumarsi intorno alla camera da presa, di fronte all’occhio dello spettatore, sia che si tratti di spazio chiuso di interni o sia esso uno spazio aperto, di una città dominata da ponti e palazzi liberty: ciò che Bertolucci cercava nei suoi lavori era la delineazione dei personaggi e delle storie narrate al di fuori di coordinate squadrate, in uno spazio-tempo fluido ed indefinibile, non contaminato dalla rigidità intellettualistica, uno spazio-tempo, cioè, non bloccato nella sua vitalità.
C’è una lirica di Baudelaire, tratta, ovviamente, da “I fiori del male”, che, credo sia scolpita nella memoria e nell’immaginario di tanti di noi e che può in parte chiarire quest’aspetto.
A una passante, di Charles Baudelaire
La strada era assordante, urlava tutt’intorno,
Esile ed alta, in lutto, regina dolorosa,
una donna passò, con la mano fastosa
sollevando il vestito, di trine e balze adorno.
Leggera, nelle gambe una scultorea grazia.
Negli occhi suoi, cielo ove s’annuncia l’uragano,
bevevo, come quello ch’è fatto ossesso e strano,
la dolcezza che incanta, il piacere che strazia.
Un lampo poi la notte ! Bellezza fuggitiva,
che con un solo sguardo la vita m’hai ridato,
non ti vedrò più dunque che nell’eterna riva ?
Altrove, in lontananza, e tardi, o forse mai !
Non so dove tu fuggi, tu non sai dove vado,
io t’avrei certo amato, e tu certo lo sai !
In questo sonetto c’è un effetto simile a quello cercato da Bertolucci in “Ultimo Tango”: l’istante conoscitivo sopravanza e annulla il tempo tradizionale e si innesta in una sorta di Eterno per il quale sono, però, indispensabili, l’anonimato dei personaggi e la fugacità temporale e spaziale: la “passante” di Baudelaire è circonfusa da luci veloci e sfuggenti; la donna è osservata dal basso verso l’alto, ma obliquamente, come una sorta di scheggia imprevedibile e fluida, destinata a “passare”, andare oltre, lasciando dietro di sé la percezione di qualcosa di non avvenuto e, come tale, straordinario, epico ed irrinunciabile.
Quasi 150 anni dopo, invece, Bertolucci fa incontrare i due e li fa diventare amanti, quasi che il Cinema avesse una valenza realizzativa dei sogni, e, invece, purtroppo, il sogno, al contatto con la realtà , anche se di celluloide, si sfalda e conduce a ciò a cui il sogno somiglia di più, cioè alla “morte ”(come ben asserito da Amleto nel famoso monologo!); d’altra parte Bertolucci non solo ha parlato spesso di un suo sogno come precisa eziologia del film, ma soprattutto va ricordato che il regista era figlio di un grande poeta del ‘900, Attilio, il quale sicuramente doveva moltissimo, in termini di poetica, come tutti i lirici del ‘900, a Baudelaire.
E si osservi, inoltre, che Jeanne è “vestita” come una dama, come un’ icona tardo-ottocentesca, con quell’enorme, e bellissimo, cappello fiorito a tese larghe, e quel collo candido e piumoso… dunque la Parigi de “I fiori del male” non è poi così lontana!
Paul, al contrario, è solo “coperto” da un vecchio cappotto di cammello, spettinato e connotato nel volto da un ostile disorientamento; a differenza della “passante” di Baudelaire qui è lui ad essere in lutto: è un uomo a cui è morta da poco la moglie, suicida nel loro albergo di modesta categoria. I due, Jeanne e Paul, incrociatisi sotto il Pont de Bir Hakeim, che il regista aveva reso già famoso ne Il Conformista , si ritrovano prima in un bistrot, dove lei è entrata per telefonare e lui per andare al bagno, poi in un appartamento vuoto dello stesso palazzo, ed è l’appartamento (con le luci “aranciate” volute dalla fotografia del grande Vittorio Storaro) che diviene immediatamente il terzo protagonista del film.
Una casa vuota è, infatti, come una persona senza nome, e, al contempo, è come lo spazio-tempo adimensionale di cui parlavamo: l’alto e il basso sono la stessa cosa; le stanze non hanno una destinazione e non sono necessarie né funzionali al tutto; una casa vuota avrebbe bisogno di immaginazione e progetti, come quelli nutriti da Jeanne che intende riempirla e viverla con il suo Tom, attore e regista d’avanguardia con cui, per altro, sta girando un film; una casa vuota, invece, è soprattutto uno spazio disabitato: nella dimensione retorica più comune una casa è essa stessa “famiglia”, dunque luogo di accudimento e protezione, un “tetto” grazie al quale i suoi abitatori trovano riparo e rifugio e anche, se possibile, conforto e affetto; qui, invece, Paul dà spazio al senso del suo fallimento esistenziale: “Ora ti farò un discorso sulla famiglia”, dice Paul a Jeanne un attimo prima della famigerata scena di sodomia del film; e il fatto stesso che il film abbia finito con il coincidere nell’immaginario collettivo con quella stessa scena per la quale ha subito incredibili vicissitudini censorie, fa capire che la frase di Paul, sopra riportata, è certamente determinante e centrale per l’interpretazione del film.
Si tratta ovviamente di un evidente riferimento alla profonda crisi che aveva da tempo investito la civiltà dei Padri, una crisi che se, da una parte, è riferibile alla Rivoluzione Industriale, dall’altra ha accompagnato per secoli in forme sottese l’evolversi delle istituzioni sociali dell’Occidente; ”…Non avea case di famiglia vòte…”(Dante Alighieri, canto XV del Paradiso), dice Cacciaguida a Dante nel cielo di Marte, descrivendo la Firenze dei suoi anni; e intendeva rilevare che quella città era, nell’XI secolo, ancora luogo abitato prevalentemente da strutture parentali e che le “case” erano spazi finalizzati soprattutto a contenere famiglie; la descrizione di Cacciaguida serviva a Dante per creare un forte contrasto con la sua Firenze, quella del 1300, che, al contrario, viene descritta nella Commedia nel suo stato di abbandono e generale decadenza, una decadenza che è innanzitutto civile e politica e spiega l’esilio e le vicissitudini di Dante stesso. Il clima degenerativo che, secondo Dante, coinvolge le famiglie, e svuota le case, così com’ è descritto dal sommo poeta, non è dissimile, però, da quello della Parigi di “Ultimo tango”: qui un uomo e una donna si incontrano in una casa sconosciuta e abbandonata, caratterizzata da un fatiscente gusto Liberty, diventano amanti e sperimentano la loro estranea sessualità, mentre intorno si accentua un senso di “finis vitae”, incredibilmente sottolineato dalla colonna sonora di Gato Barbieri, grande sax che porta nella città lumière la sua Argentina e nei tanghi fa affiorare il senso borgesiano del “pensiero triste che balla”.
Di fatto, quando uscì “Ultimo tango” era il 1972, le vicende politiche mondiali non avevano apparentemente nulla in comune con la decadenza del sistema medievale analizzato e sofferto da Dante, tuttavia la crisi del mondo occidentale era egualmente sotto gli occhi di tutti e presentava una simile rispondenza di dati, da un lato propriamente politici, dall’altro sociali e antropologici: mentre gli USA facevano i conti con lo scandalo Watergate, nel nostro paese l’omicidio Calabresi ci immergeva negli anni di piombo; alle Olimpadi di Monaco un attentato palestinese faceva strage di atleti israeliani, una strage che, vanificando lo spirito olimpico, ci ricorda uno dei più cocenti problemi dei nostri anni, quello dell’impossibile pacificazione del Medio-Oriente. Sembra lontanissima l’atmosfera della fine degli anni ’60, che pur tuttavia era già carica di pesanti aporie e di accuse al sistema occidentale; ora, però, il clima era cambiato totalmente e risultava spento irrimediabilmente il senso di una possibile conversione delle nuove generazioni alla ridefinizione del mondo sociale e politico; “Ora ti farò un discorso sulla famiglia”, dice, dunque, Paul a Jeanne; come a dire: “Quella famiglia borghese a cui tu aspiri, è essenzialmente violenza brutale; non c’è casa, rifugio, tetto che ti possa difendere dalla famiglia stessa che, nel chiuso delle abitazioni, continua da secoli e millenni a perpetrare le più cocenti nefandezze, destinando i più deboli dei suoi membri ad umiliazioni e ad una non sempre definibile infelicità”; d’altra parte anche la vita di Paul era segnata da una sconcertante infelicità: Paul non viveva in una casa, ma in un alberghetto equivoco, non aveva una moglie fedele, tantomeno aveva figli, l’amante della moglie possedeva una vestaglia identica alla sua (l’amante, Marcel, è un ineffabile e composto Massimo Girotti), la suocera lo considerava tutto sommato responsabile del suicidio della figlia e tutto il suo mondo era quel cappotto vecchio con cui coprirsi nella fredda Parigi.
Dunque non ci si deve stupire che Bertolucci rappresenti questo quarantacinquenne, che ha il volto di Brando, girare per Parigi a cercare, in maniera più o meno consapevole, la morte per mano di una giovane e bella borghese, già promessa sposa a un altrettanto giovane di belle speranze , entrambi in cerca di una confortevole, sicura e prestigiosa dimora borghese; in questo senso lo stupro che Paul esercita su Jeanne è di fatto un’inconsapevole provocazione, in grado, forse, di esprimere brutalmente l’angoscioso disorientamento che lo attanaglia…Paul è l’uomo adulto e maturo (tali si era ancora considerati negli anni ’70, a 45 anni di età) che scopre di essere sconnesso con il mondo che lo circonda, e che, dati anagrafici alla mano, aveva già 40 anni durante il ’68 ed era, dunque, troppo vecchio per assimilarne i propositi rivoluzionari e le speranze di riscatto, e troppo giovane per contrapporvisi in termini di reazione generazionale: la struggente musica di “el gato” Barbieri accompagna Paul verso l’unica destinazione possibile per un’esistenza di questo genere, la “morte”, mentre un “ultimo” tango dà sostanza ad una rappresentazione di forme e composizioni che, nella loro statuaria eleganza, ricordano le storie borgesiane di lame e coltelli, di morte e duelli. Diventa facile morire, così, per mano di chi non ci appartiene, di chi conserva ancora il senso di recupero della dimensione dei padri e con la rivoltella di ordinanza del padre, nella casa di famiglia, come a chiudere la sua personale disavventura e, al contempo,come se ubbidisse ad un input del genitore: restituisce così, uccidendolo, credibilità a Paul che, in limine mortis, finge di credere di potersi ricostruire una vita con la sconosciuta, chiedendole il nome; cade in una posa fetale, rielaborando il lutto di un uomo senza “padri” e che non è stato “padre”, e conclude quel suo famigerato “discorso sulla Famiglia”: per lui la famiglia non c’è mai stata, non c’è mai stata una casa, forse non c’è mai stato neanche lui stesso.
Molti anni dopo, con “The Dreamers”, Bertolucci riparte dalla Parigi del ’68 e nei pressi di un altro ponte, ci mostra non un angosciato Marlon Brando di mezza età, ma un giovanissimo: è l’attore Michel Pitt, Matthew, uno dei protagonisti del film; straordinariamente giovane, corti capelli biondi e una copia spiegazzata dei Cahiers du Cinema nella tasca della giacca, Matthew viene ripreso mentre si dirige verso la Cinématheque Française che era occupata dagli studenti. Comincia così “The Dreamers”, che non racconta lo scollamento di un uomo maturo, come Paul, ma indaga sulle possibili contraddizioni che caratterizzano la generazione che appartiene anagraficamente al ’68 e che viene strappata al privato e sollecitata a scendere in strada; apparentemente il film del 2003 non ha nulla in comune con “Ultimo Tango”, a parte Parigi e l’epoca di ambientazione, eppure è possibile capire il film in questione proprio osservando alcuni aspetti di “The Dreamers”. Bertolucci ripropone, infatti, in esso un suo stabile convincimento: è l’intimità dei rapporti interpersonali che costituisce un’angolazione privilegiata per analizzare dinamiche sociali e politiche di più vasta gittata; in una coppia, o in un mènage à trois, si instaura una vera“microfisica del potere” che nel caso di “Ultimo tango” disvela come per alcune generazioni l’ipotesi di una rivoluzione risulti non solo improponibile, ma addirittura capace di veicolare scollamento, sregolatezza e morte; nel caso di “The Dreamers” è lo stesso squilibrio del rapporto a tre che sbilancia e disarticola i protagonisti, destinati a dividersi nei due segmenti , quello dei gemelli, forti della loro duplicità, e quello dell’americano Matthew che resta solo con le sue illusioni pacifiste, mentre dalla strada arriva in casa un sasso che sembra dissacrare quel luogo in cui Matthew è rimasto con i suoi sogni; ed è proprio il “sogno” la cifra che ricollega i due film: i sognatori hanno vissuto, e probabilmente, continueranno a vivere “sognando”, attraverso il cinema. E un “sogno” era l’origine di “Ultimo Tango”, e sogni erano tutti i film citati dai personaggi di Bertolucci.
E un “Cinema-Sogno” è quello che Bertolucci contrappone al “Cinema -Realtà” della Nouvelle Vague, dalla quale, dopo averla amata in maniera più che maniacale, si allontana, così come aveva già fatto precedentemente dal cinema di Pasolini. Solo I “sognatori” riescono infatti ad uscire dalla radicalità che immobilizza, quella delle facili soluzioni, comprovabili solo a livello intellettualistico, e solo i “sognatori” riescono a liberarsi dalle catene dell’ordine vigente.
La libertà, che accompagna i sogni, che sgorga dai sogni e che crea l’arte cinematografica, ci può guidare verso una ridefinizione di ruoli e rapporti interpersonali nei quali, come disse Jean-Luc Godard non è impossibile, infine, catturare “lo splendore del vero”.
BRUNELLA SACCHETTI