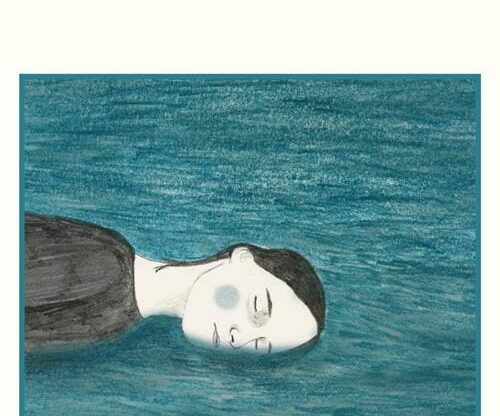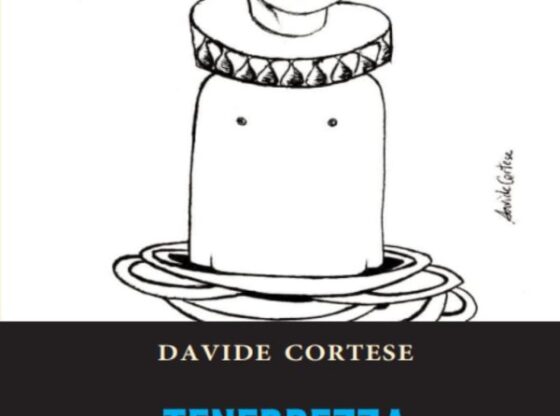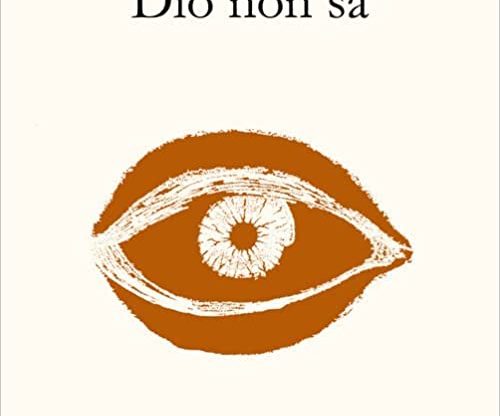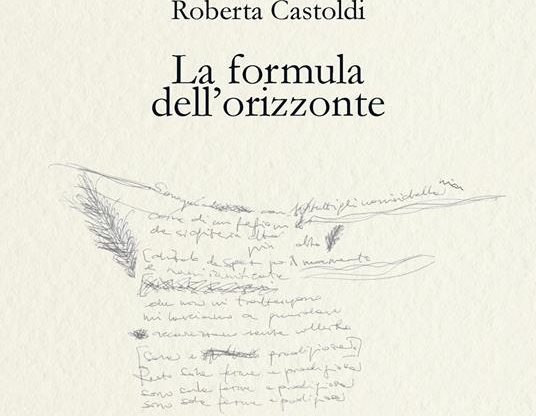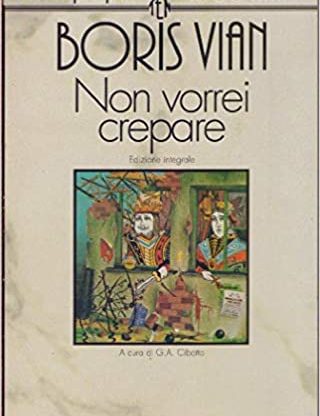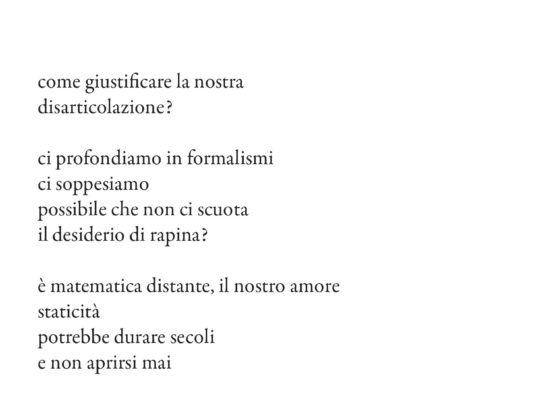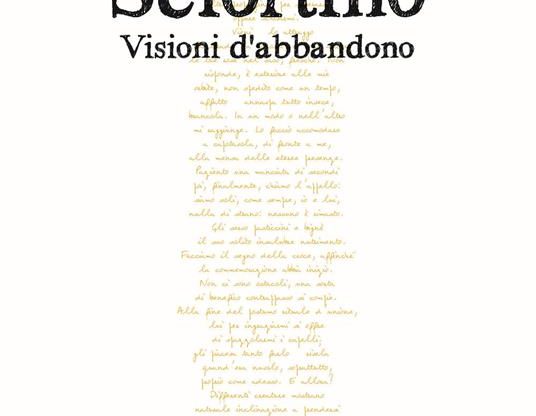Cetta Petrollo e Fabio Barone, incontro con due libri di poesia
Di Simone Gambacorta
Mi è capitato recentemente di leggere due libri di poesia che hanno saputo farmi compagnia e allora vorrei parlarne velocemente qui perché mi fa piacere contribuire anche in modica parte alla loro conoscenza e spero anche alla loro diffusione. Sono Giochiamo a contarci le dita di Cetta Petrollo (Zona) e Il giuramento sulla città di Fabio Barone (Capire Edizioni). Quindi un’autrice con un suo percorso e un autore esordiente.
Cetta Petrollo è la moglie di Elio Pagliarani, poeta colossale della letteratura italiana contemporanea (La ragazza Carla). Nel 1961 rienrò nell’antologia I novissimi, curata da Alfredo Giuliani e destinata a cambiare le cose. “In essa figuravano (insieme a quelli del curatore e di Balestrini, di Edoardo Sanguineti e di Antonio Porta) anche versi di Pagliarani. Era nata la Neoavanguardia: che si chiamò Gruppo 63 a partire dal suo primo convegno, all’Hotel Zagarella presso Palermo, nell’ottobre appunto 1963”, scrive Andrea Cortellessa nel Dizionario biografico degli italiani. Questo per dire che quando parliamo di Pagliarani parliamo di un poeta e di un intellettuale che è stato particolarmente importante non su uno ma (almeno) su due piani: sul piano del proprio percorso autoriale e su quello del contributo al rinnovamento della nostra letteratura.
Se però qui parlo di Cetta Petrollo non lo faccio per questo motivo, parlo di lei in quanto autrice di poesie “in proprio”. Questa specificazione potrebbe sembrare buffa, se non fosse necessaria: di solito, quando si tratta delle mogli o dei figli di qualcuno di importante, si tende a lasciarsi confondere, come se, per una malintesa legge dei vasi comunicanti, le qualità letterarie o intellettive di una persona potessero trasferirsi d’ufficio ai suoi congiunti oppure ai suoi discendenti. Cetta Petrollo è invece poeta in proprio, in linea autonoma, e lo è da parecchio tempo. Giochiamo a contarci le dita è il nuovo frutto del suo lavoro di scrittura e il timbro del titolo riflette il tono dei versi.
Quelli che ci porge nelle sue pagine sono versi con una caratteristica molto precisa e a voler essere attenti sarebbe più corretto dire che questa caratteristica è in effetti una presenza, cioè la felicità: quella di Giochiamo a contarci le dita è una poesia senza dolore, che parla dell’amore, della felicità e del tempo che passa e lo fa con una semplice e grandiosa pienezza di luce.
Quel che di triste il vivere dà a tutti, in questi versi non è assente: sta però in secondo piano. La scena è tutta della vita, ma senza vitalismi cretini. Ed è una scena che respira senza ingombri tipo groppi alla gola o lacrimoni mordi e fuggi. “Lo dico in modo diretto. / Sono felice / scrivo da tre giorni / negli angoli del tempo. / E sono felice”.
Siamo molto, anzi troppo abituati al “dolorismo” (Savinio, Nuova enciclopedia) oppure a quello che possiamo chiamare “intensismo”, che è un’amplificazione kitsch se non propriamente trash di struggimenti a buon mercato. A tutto questo Cetta Petrollo oppone la vita e lo fa con una voce che esprime la compartecipazione alle cose e ai momenti di ogni giorno e “che si fa apprezzare per l’agilità brillante dei movimenti” e per la sua “sottile e discreta ironia”, dice Maurizio Cucchi nella prefazione.
Per quanto invece riguarda il libro di Fabio Barone Il giuramento sulla città, la parte che mi ha più colpito, perché secondo me è quella con una maggiore presa in termini di sguardo contemporaneo, è “Impressioni dalle citta”. Quando in un libro di poesia compare la parola “città”, il pensiero corre in mille direzioni, a cominciare naturalmente da Baudelaire fino a zigzagare in ogni dove, arrivando persino dalle parti di Manuel Vazquez Montalban (la città come forma quadrata) o di Jim Morrison (la città come circonferenza). Questo tanto per dire che tipo di orizzonte ci si trova di fronte.
La città dove si muove lo sguardo di Barone è un’astrazione plurima e composita fatta di frame diversi: Pescara, Francavilla, Roma o addirittura la Berlino dei film di Wenders. Per spiegare il discorso di questo giovane autore, direi così: esiste la corporeità del mondo (tutto quello che vediamo e tocchiamo, “la febbre della materia”, per usare parole sue) ed esiste la corporeità di ognuno di noi come individuo. La parola di Barone nasce (è scritta) dall’attrito tra queste due forme di corporeità.
Più ancora che drammatico, è un attrito problematico (“d’improvviso non so più cosa vuol dire oggi”) e visionario (“le / sirene nella notte come grandi braccia a / farsi spazio tra i palazzi”). Tutto qui è sguardo che cerca “una traccia, un segno leggibile nel viavai / dell’universo”, ma tutto è anche oggetto di ascolto, acufene urbano captato da una sonda che riversa “in testa il rumore della città”. Una delle ultime poesie tira le fila del’intero libro: “Però sale, un odore dalle strade / sale come un’immagine nella mente”.
Scrive Davide Rondoni nl testo in quarta di copertina che “Barone intende la poesia come indagine febbrile nell’ombra, nella semioscurità del vivere catturato da luoghi comuni e distrazione. Una indagine che tra sfumature, frammenti di discorsi e occhiate cerca il cuore umano della città”.
Il libro ha dentro tanta sera (c’è un preciso punto foscoliano) e si chiude con una poesia dedicata a Ettore Spalletti. Questo giusto tributo, che richiama inevitabilmente la solarità pastellata delle opere del maestro, suggerisce di riflesso il nome di un altro artista abruzzese, anche lui abitato da una sensibilità adriatica e purtroppo anche lui scomparso, Franco Summa, che alla città (in primis Pescara) ha consacrato tutta la sua ricerca.