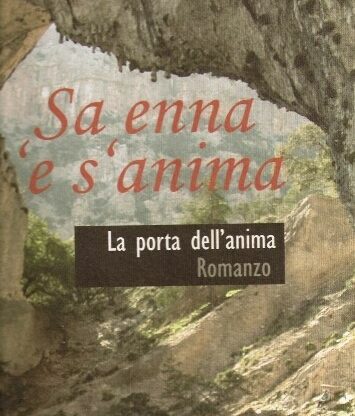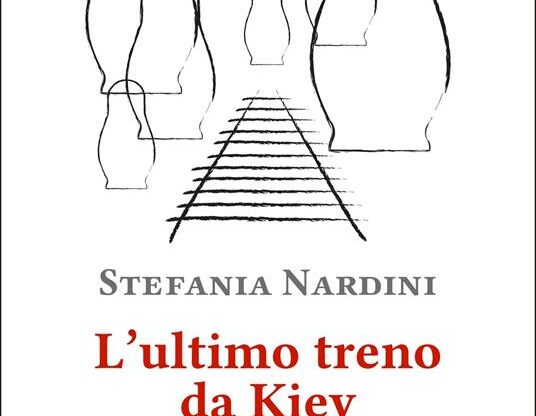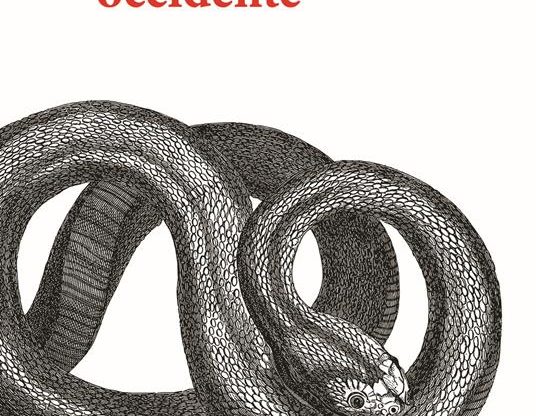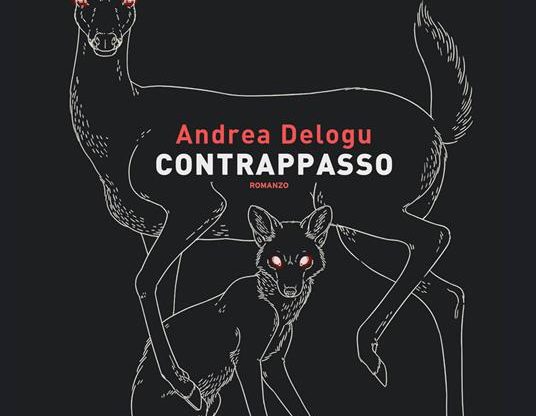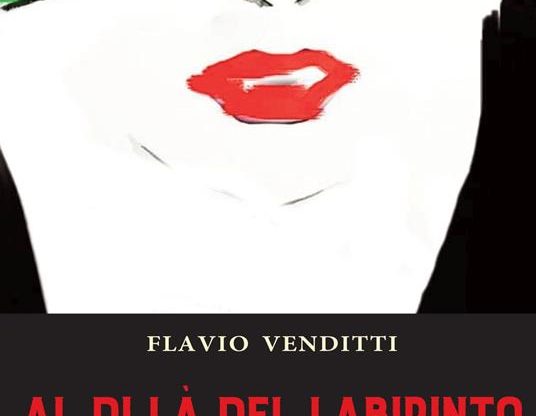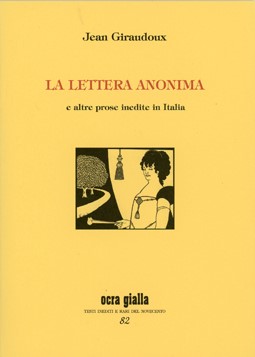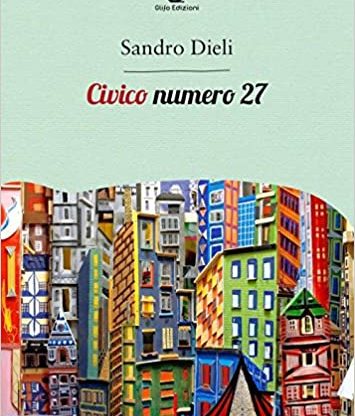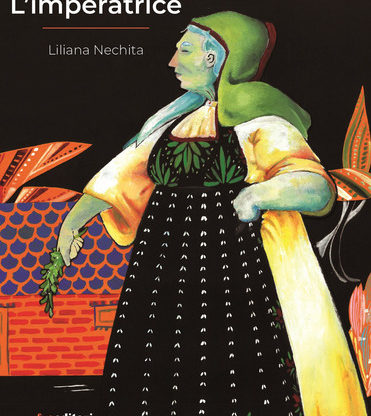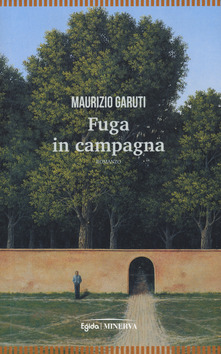La prigionia di una somiglianza
Ogni riferimento a fatti, persone o cose è puramente casuale
Di Marcello Caprarella

«Certo sarebbe meglio che non ci fosse
niente, niente di tutto questo, niente di
commovente e che non ci fosse nessun
gemello.»
Fëdor Dostoevskij, Il sosia
il sommelier mi fissò trasecolato e poi portò la bottiglia al tavolo a cui davo le spalle. «Perché mi hai tenuto nascosto che avevi un fratello gemello?» mi domandò ridacchiando Miguel corbacho Johnson, direttore
del Dipartimento di Anglistica dell’Universidad complutense di Madrid. Era il 16 dicembre 1999 ed eravamo a cena al Jockey. Festeggiavamo la pubblicazione di un nostro studio sulle scrittrici inglesi e scozzesi del Novecento.
Mi voltai e lo vidi. Gli altri clienti ci guardavano, forse stupendosi che due omozigoti si fossero ritrovati per caso nello stesso ristorante e fingessero di non conoscersi. Diciamo che io ero e ancora sono una bella copia del mio sosia. Oltre a un corpo un po’ più snello e armonico, avevo e ho dei lineamenti meno asprigni dei suoi, più morbidi e arrotondati.
Ma queste sottigliezze le potevamo e possiamo percepire solo io e lui; per qualunque estraneo e persino per un conoscente sarebbe stato difficilissimo allora ed è difficilissimo oggi non confonderci l’uno con l’altro. Stessa attaccatura alta, stessa lunghezza e pettinatura con la riga – io a destra, lui a sinistra – dei capelli neri; stesso nasone grifagno e stessa bocca sdegnosa; stessa forma sfuggente del mento; stesso pallore e stesso tipo di barba che si
rade di mattina e rispunta di pomeriggio, lasciando una specie d’ombra di fuliggine bluastra in viso. Le luci soffuse mi impedirono quella sera di distinguere il colore dei suoi occhi, ma le sopracciglia, folte e ispide, erano identiche alle mie.
il mio capo mi svelò l’identità di quell’altro me e sfoderò l’umorismo macabro con cui era solito condire le conversazioni: «È il giallista Antonio Prados Maldonado e ha più o meno la tua età. Un dilema para el comisario Aguado, la sua opera prima, ha venduto un mare di copie. Domenica scorsa ho visto una sua foto sul supplemento de El País e ho pensato a te. Secondo varie leggende germaniche e nordiche, chi incontra il proprio Doppelgänger è destinato a morire presto.» «Ma mica è detto che debba essere io, dei due, a morire, no?» azzardai. Ridemmo. A tavola con il mio duplicato umano c’era un uomo sulla sessantina che gli porgeva dei documenti. Era il prestigioso
agente letterario rafael Poveda Sepúlveda. Non lo conoscevo. Arrivarono il nostro vino, il carpaccio di capriolo, il pâté di pernice al ginepro e, tra un boccone e l’altro, ebbe inizio uno spettacolo di pirotecnica intellettuale diretto da Miguel corbacho Johnson. Quando portarono in tavola il suo filetto alla Wellington e il mio piccione di Bresse al profumo di maggiorana, aveva già citato Plauto, Dostoevskij e Mark twain, per un approccio letterario al problema della duplicazione dell’identità. Seguirono rapidi atterraggi su Hans christian Andersen, Edgar Allan Poe, Yeats,
Oscar Wilde, Papini, Borges e altri autori meno noti. Mi indicò ancora una volta il tavolo che era dietro di me, come
a volermi far intendere che non dovevamo perdere di vista lo spunto che aveva fatto sgorgare il suo affascinante monologo, che riprese:
«Viaggiando a cavallo verso Drusenheim, un giorno Goethe incrociò un tipo identico a lui e che portava uno sfarzosissimo vestito grigio con dei ricami in oro. Otto anni dopo, nel percorrere la stessa strada – sempre a cavallo, ma in direzione opposta – Goethe incontrò di nuovo quell’uomo. Sennonché stavolta era lui, Goethe, a portare un vestito grigio con ricami dorati. Voglio dirti, caro Edoardo, che l’incontro con il Doppelgänger può anche far presagire un capovolgimento favorevole della situazione. Tra qualche anno, magari, non sarà morto nessuno, lo scrittore acclamato sarai tu e avrai dimenticato questo ragazzino che tanto ti somiglia e che non sa trinciare una beccaccia.»
Pochi istanti dopo tutto il ristorante sentì un’esclamazione molto poco elegante lanciata dal mio sosia. il timbro della voce era uguale al mio o lo ricordava molto. Era la voce di quando mi incazzo. in un maldestro intento di fiocinatura con coltello e forchetta, mulinati iracondamente, al mio “gemello ritrovato” era volata via la selvaggina dal piatto. Quando mi passò davanti con lo sguardo fisso verso l’uscita, ebbi modo di osservare che era alto quanto me: un metro e settantasette, centimetro più, centimetro meno. il maître lo aiutò a indossare il cappotto. il giallista mi guardò con aria discherno e mi fece un ciaociao con la manina, serrando le labbra in una smorfia che voleva esprimere insieme
compiacimento e stizza, e che coronò con un gesto affermativo del capo, come Ollio quando dice “UMPF!” a Stanlio. Uscì senza attendere il suo agente letterario. Non lo inseguii per dirgliene quattro perché stavo ordinando il dolce.
Oggi, 25 luglio 2017, a diciott’anni da allora, Antonio Prados Maldonado è ormai famoso in tutto il mondo, mentre io, Edoardo Fabbricini, mi trovo da due mesi nel carcere di Montejo del río, a cinquantatré chilometri da Madrid e a più di millecinquecento da Pistoia, dove sono nato e dove mio padre e mia madre sono morti quattro anni fa, a tre mesi di distanza l’uno dall’altra. La mamma, francese di carcassonne, si chiamava Oriane e se ne è andata prima, a nemmeno settant’anni, bruscamente: tumore al pancreas, di quelli incurabili. Al babbo, di cinque anni più anziano, non ha retto il cuore. Il mio babbo si chiamava Lorenzo. A ripensarci, è meglio che i miei genitori non ci siano più. La morte gli ha evitato lo strazio di vedere il loro unico figlio travolto da una vicenda più grande di lui. Ho divorziato un anno fa. La
mia ex moglie, spagnola, si chiama Marta. Alberto, nostro figlio, è nato a Madrid, dove abitavamo, e compirà tre anni a settembre. Lo psicologo del carcere dice che scrivendo si superano i traumi, che la scrittura può essere catartica e rappresentare un appiglio per la redenzione. Stronzate! Lo psicologo mi parla sempre come un prete parlerebbe a una pecorella smarrita in un confessionale, come se io dovessi farmi perdonare una colpa. E invece, se scrivo, è perché coltivo l’illusione della vendetta dell’innocente, per gridare al mondo sordo che Antonio Prados Maldonado mi ha sottratto l’opera che avrebbe potuto rendermi celebre e ricco. Al processo non poteva andare bene. il mio legale low cost era una mezza calzetta; fumava come un turco, portava sempre la stessa camicia dal collo bisunto e gli puzzava l’alito di liquore.
«Non dire niente! Fingiti folle!» mi bisbigliava, suadente e mezzo addormentato, credendo di rassicurarmi durante il dibattimento. Era quella la linea di difesa che aveva predisposto, la sua Maginot. Non gli ho dato retta. L’arringa, in forma di dichiarazioni spontanee, l’ho tenuta io, ma il penalista di grido assoldato da Prados Maldonado ha smontato sardonicamente le mie argomentazioni, e l’impianto accusatorio eretto dal Pubblico Ministero era solidissimo. risultato: tre anni di reclusione per usurpazione dell’identità, aisensi dall’articolo 401 del codice Penale spagnolo. La pena minima prevista per questo reato è di sei mesi. La massima, appunto, di tre anni. A me, per evitare la galera, sarebbe bastato ottenere una pena inferiore ai due anni, essendo incensurato. A far saltare i conti sono state le aggravanti della durata e continuità della condotta illecita della quale mi si accusava e, in ancora maggior misura, le minacce di morte rivolte alla controparte qualche mese prima. Racconterò tutto, ma chiedo ai lettori che non ho di pazientare ancora per qualche pagina. il presente pesa troppo, mi risucchia nel suo gorgo e mi fagocita. Devo dire che questo centro penitenziario non è di quelli fatiscenti e sovraffollati, anzi è moderno e ben tenuto. È diviso in módulos, che sono i diversi bracci ai quali vengono assegnati i detenuti, in funzione del profilo delinquenziale e del tipo di reato commesso. Nel mio módulo, il 6, siamo sottoposti al regime carcerario ordinario, che qui si chiama segundo grado penitenciario e che vige pure nel “paradiso” del módulo 5, in cui vengono ospitatisolo i carcerati più anziani e i politici che sono dentro per corruzioni varie. I módulos dei detenuti pericolosi sono il 7 e l’8. il módulo 4 è quello de los gitanos, cioè degli zingari, ma accoglie anche molti africani. il 10 è il módulo de los estudiantes, occupato da studenti universitari che danno gli esami con il sistema della UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia – o da gente che
vuole prendersi un diploma di scuola media o superiore frequentando i corsi che vengono a impartire qui dei docenti inviati dal Ministerio de Educación. Nei restanti módulos c’è di tutto un po’. Per tutti i “nuovi acquisti” il primo contatto con il carcere avviene nel Módulo de Ingresos. io ci sono rimasto quasi due giorni completi, il 24 e il 25 maggio, in una cella singola. tutta la giornata dell’arrivo è trascorsa fra visite mediche e un colloquio con una gentilissima assistente sociale. La sera del secondo giorno sono venuti dei funzionari a schedarmi e poi sono entrato nel carcere vero e proprio. A fine maggio faceva già caldo, ma non avevo lo spirito adatto per pensare alla primavera inoltrata e alla sierra, cioè la vicina montagna. col passare dei giorni, però, uno recupera anche la capacità di osservazione, che è un sintomo della voglia di vivere. Delle due prime settimane trascorse in questa galera ricorderò sempre le margherite abbarbicate sugli anfratti dei muri di cinta del patio, tenaci come i peli che spuntano dalle orecchie dei vecchi.
La mia cella è uguale a tutte le altre: dieci metri quadri, un letto a castello, una scrivania, una sedia, un armadio, un televisore e un bagno con doccia, la cui temperatura non è regolabile. L’acqua è sempre gelida. Per l’igiene personale ci viene fornito periodicamente un nécessaire standard molto spartano: sapone liquido, deodorante stick, carta igienica, spazzolino, dentifricio e pettine. il cambio delle lenzuola è ogni dieci giorni. Quanto ai vestiti, vado
in giro in tuta da ginnastica. Il compagno di cella che la sorte mi ha assegnato si chiama Ramón Dávila Fresnedoso ed è un ex bancario quarantottenne di media statura, pienotto, scuro di capelli e di carnagione olivastra. ricorda un tricheco, con il suo baffo rado e setoloso. È finito dentro undici mesi fa per una truffa ai danni di alcuni correntisti danarosi della filiale del Banco Santander in cui lavorava e dalla quale proponeva investimenti in mirabolanti e inesistenti fondi
azionari di paesi emergenti. La tattica per guadagnarsi la fiducia dei risparmiatori era quella piramidale: con una parte dello stesso denaro accumulato nella prima fase dell’imbroglio venivano pagati dei sostanziosi interessi a uno qualunque di quelli che avevano abboccato, affinché questi diffondesse la buona novella e contribuisse ad alimentare la voragine delle finte operazioni che, essendo finanziate con soldi veri, servivano a loro volta a pagare altri investitori della prima e seconda ora. I raggirati, attirati dalla chimera di ulteriori e facili guadagni, affidavano il resto dei risparmi – quelli di una vita – a Ramón, genio delle finanze. il crollo dello scenario di cartapesta era solo questione di tempo.