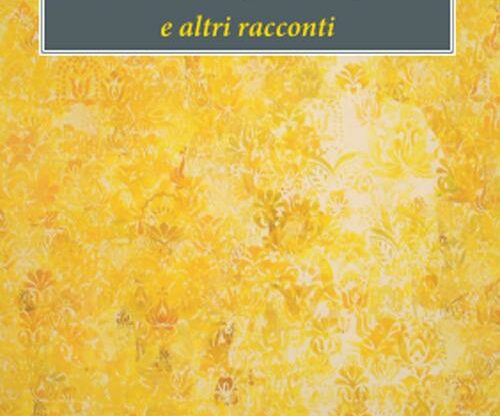Quando il cielo non farà più paura
Di Laura Vargiu
“Avete provato il peso delle nostre bombe.
Altre seguiranno.”
(da un volantino alleato su Cagliari, seconda guerra mondiale)
Ogni volta in cui per le vie del vecchio quartiere risuonava l’allarme, il piccolo Fisietto non era mai propenso a scendere di buon grado al rifugio insieme agli altri. Anzi, puntava i piedi cercando di opporre, a suo modo, una qualche speranzosa resistenza.
A fargli mutar parere ci pensava Rosa, sua madre, che lo persuadeva puntualmente – e rapidamente, data la contingenza del momento – a suon di sberle.
«E ringrazia che non c’è tuo padre, sennò le prendevi per davvero!» gli strillò lei pure quel pomeriggio, mentre se lo tirava dietro per un braccio.
Come se, fino a quel momento, in assenza del capofamiglia lontano, le avesse prese per finta, pensava tra sé il bambino. Se fosse dipeso da lui, quando all’improvviso la sirena riempiva l’aria con la sua voce stridula, sarebbe sempre rimasto a correre e a saltellare per strada, anche se, uno a uno, i suoi compagni di giochi venivano requisiti alla svelta dall’agitazione folle di genitori e parentame vario. Questo durante il giorno; se poi l’allarme squarciava il silenzio notturno, il risultato non cambiava, con l’aggravante che si doveva abbandonare il tepore del proprio letto per andare a nascondersi là sotto, dove, come era solito ripetere suo zio Antonio, faceva un freddo boia.
«Ma io come faccio a vedere gli apparecchi americani?» si azzardò allora a piagnucolare. Sua madre non perdeva più tempo a rispondergli nemmeno con il più secco e spontaneo dei suoi soliti “cittidì1!”.
Aveva una fissazione particolare per gli aeroplani, Fisietto; cosa poi nemmeno tanto strana per un bimbetto di cinque anni vivace e curioso quale lui era. Del resto, a quell’età, per sognare a occhi aperti basta poco. Figurarsi se i sogni giungono dal cielo con un paio d’ali meccaniche e il rombo di un motore! Solo che, ormai da qualche tempo, dal cielo non arrivavano più sogni, ma morte e distruzione.
La città ne portava evidenti i segni, disseminati a ogni angolo di strada. Cumuli di macerie e squarci anonimi si sostituivano a luoghi ed edifici fino a poco prima familiari, infliggendo al volto urbano ferite profonde pari a quelle che già in troppi, tra gli abitanti sopravvissuti, portavano addosso; e alcune non sarebbero mai più guarite. Come quelle del vecchio ziu Piras, su sabatteri2, il quale, se dalla guerra del ’15-’18 era ritornato tutto intero, ora sotto le rovine della sua bottega nei pressi della stazione dei treni ci aveva lasciato una gamba. O come quelle della figlia quindicenne di comare Peppina, che lavorava alla Manifattura tabacchi e che, da quando i bombardieri americani avevano iniziato sorvolare la città gettandovi il loro carico di morte, non parlava più ed era come impazzita. A chi tra i due fosse andata peggio non si poteva affermare con certezza.
Fisietto sentiva raccontare queste e altre storie che vedeva pure scorrergli davanti, ché la città non era enorme e specie nel quartiere, simile a un piccolo paese, ci si conosceva tutti. Così come i suoi occhi innocenti si abituavano alla vista quotidiana delle macerie e devastazioni dei bombardamenti, maledizione a cui nemmeno l’isola s’era potuta sottrarre; di morti non ne aveva mai visti direttamente, ma sapeva che, in un tale sfacelo, c’erano pure quelli, tanti da perdere il conto e reali quanto i morsi della fame che spesso lo punzecchiavano. Nonostante tutto ciò, quella di guardare gli apparecchi americani, mentre essi volavano alti come uccelli sopra la sua testa, restava una tentazione troppo forte, difficile da estirpargli dalla mente.
La fame, a dispetto del pranzo consumato da poco, l’accompagnava intanto che seguiva sua madre ancora una volta controvoglia. Tutt’intorno uno sciame di gente atterrita che, riempiendo la viuzza di urla, si precipitava là dove sperava, o s’illudeva, di aver salva la pelle.
Il rifugio verso cui correvano tutti, da quella e dalle vie adiacenti, non era, in verità, un vero e proprio rifugio antiaereo: si trattava piuttosto della grotta sottostante una delle chiese del quartiere; già luogo di dolore e patimenti disumani in epoca lontana secondo la tradizione religiosa popolare, quell’antica cripta finiva per accogliere le sofferenze dell’oggi generate dalla medesima e insanabile stupidità umana di sempre. E raccoglieva così tanti novelli martiri di una guerra sempre più dura da sopportare. Bambini, donne, uomini si accalcavano all’ingresso con la fondata paura di non trovare posto all’interno, ché il ricordo della carneficina delle settimane precedenti proprio davanti a quel portone era ancora ben vivo in tutta la città. Nei lunghi attimi che precedevano la discesa, unico miraggio di salvezza, giovani e vecchi si ritrovavano di colpo con la stessa incerta prospettiva di vita sentendosi fragili giunchi senza età che un vento capriccioso e imprevedibile avrebbe potuto spezzare da un momento all’altro. O come il bestiame tra cui un pastore inesperto e disattento avrebbe scelto a caso i capi da destinare al macello.
Pianti, ingiurie e spintoni si aggrovigliavano lungo la ripida scalinata, dove ogni volta in molti rischiavano di rompersi l’osso del collo; aveva voglia a sgolarsi il custode che teneva le chiavi della cripta, raccomandando di scendere piano e con ordine. A chi vedeva infine svanire la possibilità di rifugiarsi là sotto, altro non restava da fare che rimettersi a correre alla svelta per cercare posto nella più capiente galleria sotterranea del vicino ospedale civile; ma ci si sarebbe accontentati di una qualsiasi puzzolente cantina o di un’anonima tana sottoterra in cui sprofondare fino a che l’inferno che si annunciava oramai imminente non si fosse placato.
«Presto, presto!» s’incitava, intanto, dal profondo della cripta; la gente si distribuiva fin nei suoi più angusti recessi, con l’abitudine e la perizia forzate di chi conosceva il posto.
Un odore pungente di sottosuolo e umidità aggrediva le narici di Fisietto già dopo i primi gradini: non gli piaceva né amava l’oscurità che di colpo lo ingoiava al chiudersi del portone che stroncava bruscamente ogni residua speranza di poter vedere gli apparecchi americani, portatori di cotanto scompiglio in città. Pur nella propria incoscienza di bambino, si chiedeva per quanto tempo ancora le persone si sarebbero dovute nascondere come topi, privandosi dell’aria aperta, del sole, del mare il cui profumo s’infilava stuzzicante nei vicoli dei vecchi quartieri ormai polverosi di rovine; allo stesso modo, anche se non domandava niente a voce, s’interrogava sul ritorno di quel babbo partito soldato del quale la sua memoria ancora acerba non poteva conservare altro se non un’ombra che sapeva di sogno e la percezione fugace di qualche carezza.
La guerra glielo aveva portato lontano, suo padre: oltremare, gli aveva raccontato la mamma asciugandosi troppe lacrime ribelli; in su corru ’e sa furca! 3, gli avevano precisato, con un misto di rabbia e commiserazione, zie e ziette del quartiere che a loro volta avevano mariti o figli in divisa nello stesso luogo non ben precisato. Ma, per quel che ne sapeva lui, la guerra c’era anche lì, nel cuore della loro piccola città, se guerra significava case diroccate e tozzi di pane per i quali la gente doveva fare lunghe file con una tessera in mano e che non bastavano mai a riempire la pancia in grazia di Dio. Pure gli aeroplani facevano parte della guerra, si capiva, ma quelli continuavano ad affascinare l’immaginario di Fisietto. Accucciato a terra accanto a sua madre, che per loro due cercava sempre un angolino ben distanziato dalla gradinata d’accesso, il bambino sbadigliò, un po’ per la fame, un po’ per il torpore che l’ambiente buio e sovraffollato del rifugio instillava ogni volta nella sua vivacità. Qua e là, la timida luce di qualche lampada rischiarava volti atterriti e dava a tutti la sensazione di essere come degli spettri.
«Maladittus!4» si alzava rabbioso più di un gemito dal brusio di sottofondo, senza bisogno di precisare a chi s’indirizzasse l’esclamazione, mentre qualcun altro non faceva mistero di invidiare coloro che già erano sfollati nei paesi dell’entroterra.
Era il momento, quello della rassegnata attesa che dall’esterno la voce prepotente delle bombe zittisse tutte le altre, in cui si ripetevano vecchi discorsi o se ne facevano di nuovi; e pure abbastanza accalorati.
«Gesu Cristu miu! Perché ci fanno questo?» continuava a domandare e a domandarsi una donna di mezza età, scotendo la testa attorno alla quale si riannodava il fazzoletto con gesto esperto.
«Eh, comare Bonaria… Che cosa possiamo farci?» le rispose un tale suo coetaneo, noto nel quartiere per la sua rivendita di vino annacquato e la camicia nera indossata da un ventennio. «Del resto, si sa: la guerra è guerra!»
A commento, la gente seduta accanto ai due prese a mormorare qualcosa, finché non si levò un uomo originario di una città di miniera, ancora giovane ma inabile al lavoro e all’arruolamento perché monco di un braccio.
«La guerra è guerra, ha ragione, signor Luigi!» esclamò questi, rivolto all’altro. «Ma noi» e con la sola mano che gli restava fece un ampio gesto a indicare la folla dei presenti «intendo lei, io, comare Bonaria, persino zia Teresica» e qui indicò una vecchia sdentata che se ne stava seduta poco più in là «noi a loro, a questi americani che vengono ad ammazzarci manco fossimo cani, che male abbiamo fatto?»
Tacquero tutti, all’istante. Troppo semplice era la risposta, al punto da far avvertire di colpo, greve come un macigno, la totale assurdità del conflitto in atto.
Come a consigliare, o a imporre, di abbandonare simili chiacchiere e ragionamenti, un boato risuonò in lontananza. Poi un altro. E un altro ancora.
Bombardavano il porto, fece in tempo a osservare qualcuno a gran voce, prima che nel rifugio ogni parola distinta venisse sopraffatta da mille altre indistinte, schiacciate tra gemiti, pianti e preghiere. Oltre a quello della Madonna e di Nostro Signore, Fisietto sentiva disperate invocazioni anche all’indirizzo della santa cui era dedicata quella cripta tramutata in riparo antiaereo e, ancor più, del martire del quale lui portava il nome.
«Salvaci, Sant’Efis!» s’appellavano con tono accorato donne e uomini a Sant’Efisio, domiciliato a pochi metri di distanza là in superficie in una chiesetta che, miracolosamente, stava ancora in piedi, mentre della ben più maestosa Sant’Anna, nella strada adiacente, sopravviveva soltanto la facciata.
Da quando il padre era stato chiamato alle armi, il bimbo c’era andato spesso con la mamma ad accendere una candela e a recitare una preghiera affinché il santo, che nella sua vita terrena era stato a sua volta un soldato, proteggesse chi loro attendevano, riportandoglielo a casa sano e salvo. E che proteggesse tutti quanti, Sant’Efisio, ché i patimenti degli innocenti lui sì che li poteva comprendere! Ogni cosa sarebbe stato possibile con l’intercessione di un santo tanto glorioso, persino i miracoli più inimmaginabili; in fin dei conti, non si diceva forse che, molto tempo addietro, egli avesse salvato la città dal flagello della peste? E per questo la città ancora lo ringraziava e venerava, portandone il simulacro in processione solenne.
Di quella grande festa, che ritornava puntuale ogni anno allo sbocciare del mese di maggio, Fisietto conosceva ben poco per via della sua giovanissima età; avendone però sempre sentito raccontare pure dai ragazzini più grandi, non gli riusciva difficile fantasticare sulle vie del quartiere imbandierate e fiorite, i drappi rossi ai balconi e alle finestre, i carri a buoi, cavalli e cavalieri. La guerra aveva purtroppo sbiadito colori e profumi dell’antica ricorrenza e nessuno sapeva se nel maggio successivo, con la città ormai semidistrutta dalle incursioni aeree alleate, il cocchio del santo avrebbe sfilato come da tradizione.
Nel frattempo, i boati delle esplosioni s’erano fatti più vicini e pressanti, facendo tremare l’umida cripta al pari di coloro cui dava riparo. Qualche goccia d’acqua, dall’alto della nuda roccia, picchiettò sulla testa spettinata di Fisietto che fu preso d’un tratto dal desiderio di farsi piccolo piccolo tra le braccia di sua madre. E Rosa se lo strinse forte al petto, quel figliolo, lo stesso al quale solo poco prima, in strada, non aveva lesinato scapaccioni e strattonate.
«Li senti? Senti cosa fanno i tuoi americani?» gli sussurrò all’orecchio con una voce che era tutta dolcezza, quasi a domandargli perdono per le sberle precedenti
Certo che li sentiva, e li immaginava pure con i loro aeroplani! In quel momento, però, tutto ciò di cui aveva bisogno era rifugiarsi nel silenzio di quell’abbraccio, dove il suo cuore di bambino diventava tutt’uno con quello materno, lontano e al riparo dal frastuono delle esplosioni e dalla morte che serpeggiava impietosa là fuori.
Chiese soltanto: «Ma’, quando potrò guardare gli apparecchi?»
«Quando il cielo non farà più paura» gli rispose lei in un ultimo sussurro, accarezzandogli i riccioli neri.
Rimase così, stretto al tepore rassicurante di sua madre, mentre intorno a loro continuava la nenia delle preghiere degli adulti e del pianto dei più piccoli.
Stette immobile, con gli occhi chiusi, in attesa che il portone del rifugio si aprisse di nuovo, forse sognando che il babbo soldato tornasse a casa e la statua di Sant’Efisio sfilasse ancora tra il profumo delle rose a primavera; e magari che giungesse presto un tempo in cui gli apparecchi americani non avrebbero più intimorito nessuno e lui, con il naso all’insù e la manina alzata in segno di saluto, avrebbe potuto seguirne il volo sopra la sua piccola città.
In un cielo immenso, finalmente, di pace e speranza.
Tra febbraio e maggio del 1943, nel vivo della seconda guerra mondiale, la città di Cagliari fu pesantemente bombardata dalle forze aeree alleate.
A più riprese nel mirino dei B-17 americani (le famose fortezze volanti), i quartieri storici si ridussero ben presto a cumuli di macerie. In quello di Stampace la cripta di Santa Restituta, in via Sant’Efisio, diventò un rifugio antiaereo; in prossimità del suo ingresso, tra la chiesa omonima e quella di Sant’Anna, già nel mese di febbraio ebbe luogo una delle più impressionanti stragi di civili registrate all’epoca nel capoluogo sardo, come ricorda una lapide posta dall’amministrazione comunale in memoria delle vittime.
Dalle stesse vie stampacine anche il primo maggio di quell’anno terribile, nel rispetto di un voto antico di secoli, prese avvio la processione di Sant’Efisio: il simulacro del martire, portato su un camioncino e seguito da un manipolo di fedeli, passò tra le rovine di una città spettrale, ormai in gran parte sfollata, sulla quale le incursioni aeree non erano ancora terminate.
Per via delle “lunghe, terrificanti ed assillanti distruzioni di guerra” e delle innumerevoli perdite umane, nel 1950 l’allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi insignì Cagliari, dichiarata città martire, della medaglia d’oro al valor militare.
Laura Vargiu
1 Sta’ zitto!
2 Il calzolaio
3 3 Letteralmente, nel corno della forca!
4 Maledetti!
L’immagine di copertina è Chiaro di luna, di Mario Sironi