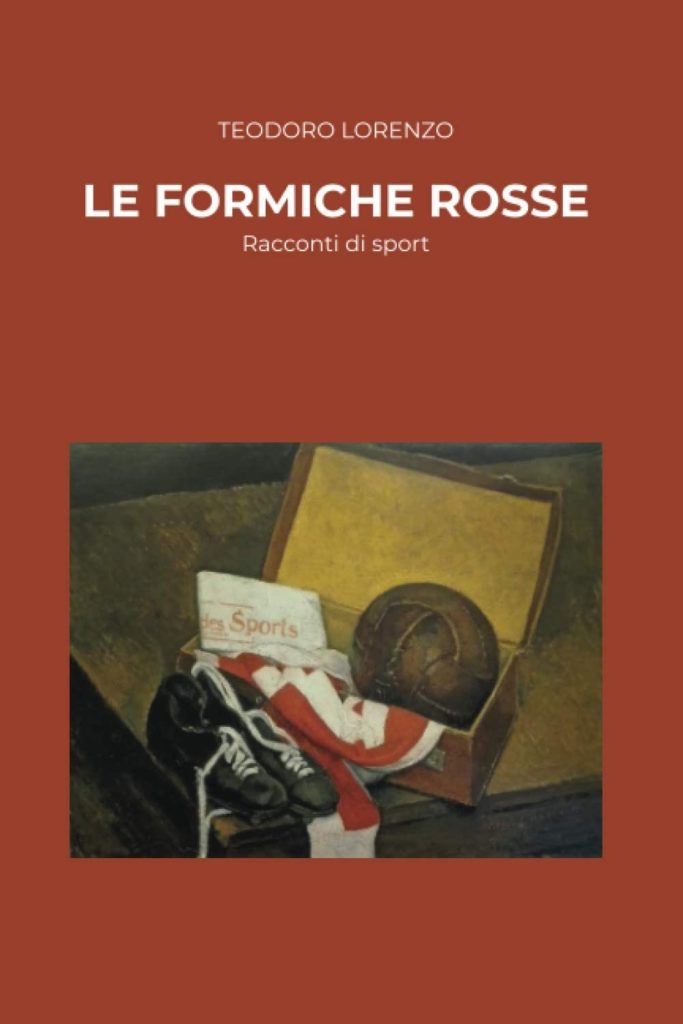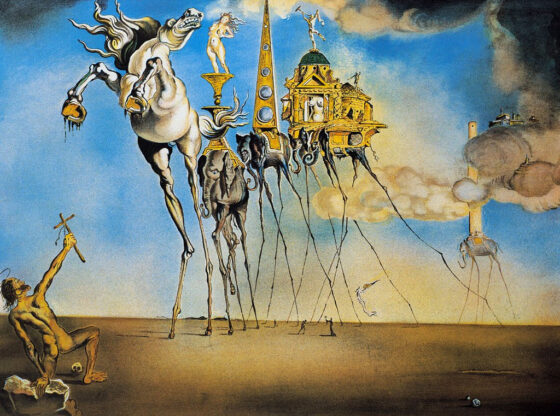IGNAZIO E TERESA
Di Teodoro Lorenzo, racconto tratto dal libro Le formiche rosse
Quando nacque i familiari tutti e gran parte del paese aspettavano frementi al piano di sotto che squillasse tra quelle pareti di pietra il primo vagito, a cui avrebbero legato gioia e sorrisi.
Ogni manifestazione della vita non era soltanto un avvenimento privato, da celebrare nell’intimità della famiglia, ma un rito collettivo il cui significato si era tramandato intatto nel corso dei secoli.
Così capitava a Barumini, duemila anime o poco più arroccate sulla crosta montuosa della Marmilla, nel cuore segreto e impervio della Sardegna.
Appena un puntino sulla carta geografica, un grappolo di case grigie aggrappate al raspo della montagna; lì ad un passo dal cielo e lontano, lontano dalla terra.
Forse per questo tutto si svolgeva senza rumore e senza frenesia seguendo un’armonia che non era quella degli uomini ma piuttosto quella delle sfere celesti.
Forse per questo la vita, in ogni sua espressione, nascita, matrimonio, morte non rappresentava un mero accidente formale da trascrivere su qualche registro ma aveva origini e dignità divine, da salutare e benedire con ossequioso rispetto da tutti indistintamente.
E nella casa dei Fadda in quel lontano pomeriggio del sessantuno, troppo freddo per essere già aprile, si era data convegno la gente di Barumini.
Nasceva un bambino, una stilla divina era caduta sul loro paese e avrebbe preso, di lì a poco, sembianze umane. L’eterno miracolo della vita che si rinnova si stava per compiere tra quelle pietre. La vita chiamava, bisognava andare a renderle omaggio.
Un’ultima dolorosa spinta, un ultimo straziante gemito e poi lacrime di gioia si confusero alle gocce di sudore sul viso di mamma Grazia.
“Maschio! “esclamò la vecchia levatrice quando trionfante levò al cielo, come calice di vin santo, quel fagottino zampettante.
Le sue deboli braccia, che avevano tratto dal buio chissà quante delle persone raccolte al piano di sotto, non avevano fatto alcuno sforzo per sollevarlo al di sopra del capo per mostrarlo a Dio e al mondo.
Era leggero quel batuffolo di vita, così leggero da creder che sotto la pelle colore del bronzo lo scheletro delle sue ossa fosse fatto di zucchero filato.
Iniziò così la vita di Ignazio Fadda, con semplicità, senza annunci o fiocchetti azzurri appesi alla porta.
Perché semplice e rude era la vita di Barumini.
Uomini e donne già in piedi quando il sole è appena un pallido arco dietro le montagne, laggiù ad est. Al lavoro tutto il giorno gli uni sui pascoli le altre davanti al forno o chine sul cucito.
Soltanto una pausa quando il sole tocca lo zenit per consumare il pasto; un sottile foglio di pane bagnato e un pezzo di formaggio. Poi di nuovo al lavoro fino all’ultimo raggio di sole che si appoggia sulle spalle come una mano affettuosa e spinge gli uomini a fare ritorno a casa e le donne ad affaccendarsi in cucina per preparare la cena.
Così tutti i giorni in un fluire ininterrotto che non ammetteva vittimismi, sorretti da una fierezza dura, intransigente, da un rispetto di sé che escludeva cedimenti o compromessi, da una dignità che non era semplice principio teorico ma essenza stessa del loro essere, carne e sangue del loro corpo.
Inflessibili verso se stessi, alieni da qualsiasi falsa consolazione vivevano pervasi dall’idea che la condanna biblica inflitta ai due peccatori al momento della cacciata dal paradiso terrestre: “Tu lavorerai col sudore della fronte. Tu partorirai con dolore “non fosse una filosofia su cui elucubrare ma una legge divina a cui bisognava piegarsi senza lamenti.
Ignazio Fadda crebbe tra questa gente cominciando ben presto la stessa vita e nutrendosi degli stessi principi.
Non ebbe altra scuola che il contatto quotidiano con le cose; i suoi maestri furono gli altri uomini, le bestie, i boschi. I suoi libri furono le stelle del cielo e l’erba dei prati.
Di parole ce ne furono poche nella sua infanzia e tutto quello che imparò lo imparò imparò dal silenzio della Giara quando vi portava le bestie a pascolare.
Nel mondo che lo circondava Ignazio riconosceva una fierezza che non diventava mai superbia, una consapevolezza di sé che non scivolava mai in presunzione.
Tutto gli sembrava vero, colto nella sua essenza: animali, alberi, uomini gli apparivano nel nocciolo del loro essere, senza finzioni o mascherature.
Ed era felice di trovare di tutto questo una meravigliosa corrispondenza dentro di sè.
Aveva cioè la sensazione che il suo animo e le cose attorno a lui fossero due specchi che riflettevano la stessa immagine.
Anche lui si era ritrovato nel midollo delle sue ossa, impastato con il suo stesso sangue, la stessa fierezza, e quindi il virile orgoglio di essere un uomo.
Che non voleva dire essere superiore agli animali che brucavano l’erba attorno a lui o agli alberi che spingevano le loro cime verso il cielo ma possedere la loro stessa genuina e innata dignità e aver fatto propria la consapevolezza che tutto procede secondo un ordine, quello voluto da Dio, che non prevede gerarchie di valori e dove ogni essere assolve alla sua autentica e insostituibile funzione.
Ne aveva di tempo per pensare, Ignazio, appoggiato al fusto di un leccio durante le lunghe giornate lassù, alla Giara dei Gesturi.
Anche la bellezza del posto invitava alla riflessione, stimolava i suoi pensieri.
Era una bellezza rude, essenziale, che non si lasciava cogliere al primo sguardo; una bellezza da scoprire pian piano. Sembrava che alla Giara non importasse di piacere anzi si sforzasse di nascondersi.
La Giara dei Gesturi era una meravigliosa donna ritrosa per timidezza e per condizione, indifferente agli sguardi dei maschi per la via, che sotto i panni ruvidi di una povertà antica lasciava intuire l’opulenza maestosa del suo corpo.
Ignazio non si stancava mai di contemplarla e spingeva i suoi occhi fino a dove arrivava lo sguardo ed anche oltre, in un meraviglioso gioco dell’immaginazione, per scoprire le pieghe più nascoste di questo corpo meraviglioso.
In un’incredibile offerta di pietra al cielo, rocce rossastre circondavano la pianura come orli di un enorme vassoio all’interno del quale la natura aveva ordito meravigliosi ricami vegetali e animali.
Lecci e sugheri si alzavano dalla pianura come se volessero guardare al di là delle rocce e poi lentischi, corbezzoli, asfodeli mentre cinghiali, martore, volpi e pernici correvano in mezzo a quei colori.
Ignazio si soffermava su ogni particolare per stampare sulla lastra della sua mente il negativo di quella stupenda fotografia; se gli acidi della nostalgia e del ricordo avessero un giorno sommerso la sua mente, quell’immagine avrebbe ripreso colori e lucentezza dandogli conforto.
Quello che più lo entusiasmava della Giara erano le mandrie dei cavallini selvaggi.
Era uno spettacolo meraviglioso osservare i loro mantelli lucidi e udire l’eco degli zoccoli sul basalto che giungeva alle sue orecchie come un festoso inno di gioia prima di perdersi nel vuoto.
Amava quei cavalli. Piccoli di taglia ma robusti nel torace e possenti nelle zampe, incarnavano nel loro galoppo senza meta l’idea stessa della libertà e della fierezza.
Non si lasciavano avvicinare da nessuno e interrompevano la loro corsa solo per abbeverarsi ai “pauli”, ampi stagni di acqua piovana, che in primavera si coloravano di bianco per la fioritura dei ranuncoli. Solo in quei momenti Ignazio aveva la fortuna di guardarli da vicino. Ed era emozionante osservare quegli occhi che mai avevano incrociato quelli di un padrone, quegli zoccoli che mai avevano sentito il ferro, quel dorso su cui mai si era appoggiata una sella.
Anche al paese i cavalli erano amati e di essi aveva sentito parlare gli anziani. Su di essisi mischiavano verità e leggenda: erano il vento, liberi e imprendibili, e ciò eccitava la fantasia della gente.
Ignazio aveva sentito dire che una volta l’anno peones provenienti da altri paesi catturano tra i branchi i migliori esemplari e li trascinano via, via dalla libertà, via dalla vita in mezzo a urla umane e nitriti di terrore.
Una volta l’anno il silenzio attonito della Giara dei Gesturi, quel silenzio eterno che sembra annunciare qualcosa di eclatante e meraviglioso, l’inizio stesso del mondo forse o la discesa di un’astronave, viene infranto in milioni di schegge impazzite. L’ordine divino che unisce pietre, animali ed erbe viene per un giorno travolto e violentato. Il vetro perfettamente luminoso e levigato della Giara viene inciso da urli di sangue.
Ma Ignazio non ci credeva. Fantasie, aveva pensato osservando i cavallini nel loro sfrenato galoppo. Nessuno riuscirà mai a mettere loro una briglia.
Eppure come sarebbe stato bello cavalcarne uno. Lo avrebbe fatto senza sella, così da aderire perfettamente alla sua carne, sentire la vibrazione delle sue ossa, perfino il pulsare del suo cuore. Si sarebbe stretto al suo collo e avrebbero galoppato insieme in un’ebbrezza di libertà e potenza.
Ignazio aveva cominciato prestissimo a salire sul cavallo che suo padre usava per i suoispostamenti e quando gli era possibile se lo portava alla Giara insieme alle bestie, camminandogli a fianco con il braccio appoggiato sul dorso. E andavano così, al passo,dritti ed impettiti come dama e cavaliere sulle bianche scalinate di marmo di qualche castello illuminato a festa.
E arrivati alla Giara, incollati insieme, cominciavano il loro galoppo al suono che arrivava dalla terra e dal cielo; il rumore degli zoccoli e lo stormire del vento.
Cavalcare per lui era come stare seduto sullo sgabello di casa o per terra appoggiato ad un leccio: una posizione assolutamente naturale.
Ma non era una questione di tecnica. Non aveva avuto né insegnanti né addestramento; la sua naturalezza, la sua eccezionale abilità erano frutto della perfetta intesa che riusciva a creare con il cavallo. Era un continuo scambio di emozioni, una osmosi di sentimenti, un passaggio di corrente fatta di brividi, sussulti,tremori.
Un filo legava quei due cuori e lungo questo filo correvano parole di sangue,di muscoli, di tendini che solo Ignazio sapeva decifrare.
Accadeva con tutte le bestie; con le galline e i conigli del cortile, con i gatti e i cani randagi.
Era un legame speciale quello che univa Ignazio a tutti gli animali; con essi gli riusciva facile comunicare, facile capire e farsi capire, amare e farsi amare. Gli bastavano sussurri o carezze, come se parole meravigliose fossero attaccate al suo fiato o impresse nel palmo della mano e gli animali fossero in grado di leggerle e capirle.
La solitudine, il quotidiano contatto con essi, l’osservazione continua dei loro comportamenti lo avevano avvicinato a quel mondo fino a sviluppare queste eccezionali qualità.
Una parola all’orecchio del suo cavallo o una carezza sul muso prima di prendere il galoppo sulla Giara bastava per creare tra loro un’atmosfera di complicità amorosa.
Attaccato al suo collo Ignazio si lasciava trascinare e travolgere dall’impeto della corsa svuotandosi mano a mano di ogni volontà e di ogni pensiero prima di fermarsi nuovamente tra gli armenti in silenzioso ruminare. Come se durante la corsa si fosse liberato di ogni scoria, come se la galoppata fosse ogni volta una corsa a ritroso nel tempo volta a recuperare l’integrità e la purezza della nascita.
Erano attimi di intensa gioia. Poi i pensieri ricominciavano ad affluire alla mente.
Ve n’era uno curioso, di cui un po’ si vergognava; una debolezza non in sintonia con quelle montagne e con la vita che lì si conduceva.
Si vedeva così alto e maestoso su quel cavallo che,socchiudendogli occhi, si immaginava eroico condottiero avvolto in un mantello colorato, portato in trionfo da una folla entusiasta che invocava il suo nome.
Magari proprio il re di quel popolo di cui aveva sentito parlare i vecchi del paese; quel popolo antico che era stato padrone di tutta la Sardegna e che aveva costruito quelle strane torri a forma di cono che vedeva agli angoli della sua Giara, eterne sentinelle a presidio di quel pezzo di paradiso.
Sciocchezze, sì, ne era consapevole anche lui, ma era l’unica concessione che permetteva alla sua vita di bambino già vecchio, l’unico morbido guanciale che aveva sul cuore e su cui ogni tanto aveva piacere di affondare il viso.
Altri pensieri lo ghermivano alla fine della corsa, ogni giorno più tristi.
Non gli piaceva la vita che conduceva e gli ardori dell’adolescenza, che non conoscono mezze misure, lo spingevano verso una risoluzione drastica.
Non si lamentava, non era la sua natura. Sopportava in silenzio, a testa bassa, gli stenti di sempre ma sentiva in qualche parte del suo corpo che la vita poteva essere diversa e che era giusto pretendere di più.
Ogni tanto udiva i vecchi parlare di posti lontani, di città piene di gente, di luci. Alcuni addirittura avevano attraversato il mare, il mare! e descrivevano con occhi scintillanti quel viaggio marziano.
E un demone aveva preso posto nel cuore di Ignazio e con più insistenza gli urlava: “Parti, parti, fuggi via “
Aveva sedici anni, si sentiva pronto a farlo, si sentiva maturo per questo passo ma il pensiero di abbandonare i suoi vecchi genitori lo legava a quelle rocce.
Ma il demone diventava ogni giorno più esigente e dall’angolo che aveva preso si allargò a tal punto da occupare interamente il suo animo e non lasciare più posto ad altri pensieri.
Si confidò una sera con i genitori che avevano già intuito dai suoi silenzi i tormenti che lo angustiavano. Capirono, con gli occhi velati di lacrime gli diedero la loro benedizione e Ignazio partì.
Non poteva sapere quale sarebbe stata la sua vita futura ma era certo che l’avrebbe trascorsa accanto ai cavalli.
Decise di dirigersi verso sud, verso il capoluogo.
Fece il suo viaggio prima su una corriera sgangherata e cigolante poi su una vecchia carrozza di treno con i sedili unti e strappati. Tenne la faccia incollata al finestrino e la valigia sulle ginocchia mentre fuggivano via le stazioni dai suoi occhi, una ad una.
Ignazio si sentiva bene; gli sembrava tutto un gioco. Abituato all’imponenza delle sue montagne,dietro il vetro tutto gli appariva più piccolo; le stazioni, gli animali, perfino gli uomini. Un mondo di plastica, come costruzioni per bambini.
Ma quando finalmente giunse a Cagliari la prospettiva si ribaltò e gli bastò notare la prima occhiata che gli rivolsero le persone sul marciapiede della stazione, a metà tra sorpresa e derisione, per capire che il gioco era finito.
Vagabondò alla ricerca di una pensione.
Tante cose, troppe e tutte assieme, lo avevano stordito: la folla, la confusione, le case che sembravano voler bucare il cielo, e poi il mare… ragazzi… che spettacolo, il mare!
Era ubriaco di immagini e novità.
Avrebbe dovutocercarsi un lavoro ma di quello non si preoccupava. Era venuto fin lì per i cavalli, non poteva immaginare altra occupazione, ma si sentiva sicuro, e convinto che nessuno l’avrebbe rifiutato.
Al proprietario della scuderia Flores infatti bastò sapere che veniva da Barumini e che per anni aveva fatto il pastore per affidargli la cura dei suoi cavalli. La sua nuova vita era cominciata.
Ogni giorno sistemava e ripuliva la stalla, portava la biada ai cavalli, li strigliava, accomodava la sella e i finimenti prima dell’allenamento; al termine li asciugava dal sudore e li copriva con mantelle e coperte, con dolcezza, come se fasciasse neonati.
Ignazio cominciava a conoscerli e giorno dopo giorno sentiva che quel filo misterioso e invisibile che lo legava agli animali si faceva anche con loro sempre più sensibile.
E quando era nelle stalle accanto ai suoi cavalli, suoi perché ormai li sentiva parte di sé, avvolto nello stesso calore, respirando la stessa aria, confuso in una unica nuvola di fiato aveva l’impressione di non essersi mai allontanato dalla Giara.
Di cavalli così maestosi e imponenti non ne aveva mai visti.
Osservarli mentre si avviavano verso la pista accompagnati dagli allenatori, impassibili e alteri come re in mezzo alla loro corte di paggi o quando si lanciavano al galoppo con falcate precise come compassi ed eleganti come passi di mannequin era per Ignazio un godimento che si rinnovava ogni volta.
Era orgoglioso di avere amici così fantastici, i soli purtroppo.
Quelle occhiate maligne alla stazione di Cagliari erano diventate regola ed abitudine quotidiana. Nessuno tranne i cavalli lo capiva.
Introverso per natura,non per scelta o cattiveria, non incline alle compagnie fragorose ma cresciuto nella solitudine della Giara, parco di parole perché maturato tra i silenzi delle sue montagne, Ignazio non trovava affinità con il mondo degli uomini, ed emarginato dagli altri e appartato per inclinazione, si rifugiava sempre più spesso nelle stalle per accarezzare mestamente qualche cavallo e lì, davanti a quel confessionale di muscoli e carne, confidare le sue pene.
La gente più o meno scopertamente lo derideva e anzi vedendolo continuare serenamente la vita di sempre, chiuso nel suo amore per i cavalli e nel ricordo della sua terra, senza cambiare di una virgola il suo comportamento per compiacere o farsi accettare, si accaniva contro di lui con maggiore ostinazione e cattiveria.
Nano, nano delle montagne, gli dicevano, e quella parola, nano, detta con quel tono velenoso, tra scherno e disprezzo, gli aveva aperto una ferita nel cuore.
Non aveva mai badato al suo aspetto fisico, convinto che fossero altre le virtù da coltivare; convinto che fosse la sostanza e non la forma a stabilire il valore di ogni essere vivente, uomo o bestia che fosse. Questo almeno aveva imparato dalla rude essenzialità della Giara.
Soltanto nel momento in cui gli avevano rivolto quell’offesa Ignazio aveva preso coscienza del suo essere.
E proprio lui che non si era mai sentito piccolo di fronte alle montagne della Barbagia ora si sentiva piccolo davanti a quegli uomini.
Ma lassù tutto procedeva secondo il respiro potente ed equanime della natura che non aveva centimetri di misurazione; dove il leccio e la formica avevano la stessa altezza.
Ignazio invece cominciava dolorosamente, sulla sua pelle, a scoprire gli uomini e le loro ignobili scale di valori, i loro squallidi scaffali in cui raggruppano e separano; i belli i ricchi i potenti i poveri i brutti i nani. Tante etichette da attaccare a tanti scaffali I nani. Lui apparteneva allo scaffale dei nani.
All’interno della scuderia la situazione era ancora peggiore. Gli altri stallieri, ma anche i fantini e gli allenatori che si erano accorti della sua straordinaria dimestichezza con i cavalli, tutti lo guardavano in tralice.
Il proprietario della scuderia, il commendator Flores, cominciava a volergli bene e anche questo non aiutava la distensione dei rapporti tra lui e gli altri.
Ignazio sperimentava sulla sua persona, per la prima volta, il senso della parola invidia. Imparava l’abbecedario di quel mondo, cominciava a conoscere lo squallido alfabeto con cui veniva scritta la maggior parte del libro degli uomini.
E più progrediva nella sua conoscenza più si rifugiava tra i suoi cavalli alla ricerca di un po’ di verità, di un po’ di giustizia.
E quando il suo animo era colmo di malinconia e appoggiare la testa contro quei musi amici non bastava a rasserenarlo, in silenzio, guardandosi attorno come un ladro, montava su un cavallo e cominciava a cavalcare per la campagna circostante.
Ritornava bambino sulla Giara dei Gesturi.
Montava sempre la stessa cavalla, l’ultima arrivata.
Appena vide scendere dal camion che l’aveva trasportata alla scuderia quella cavalla piccola di stazza e dal pelo nero, lucido come inchiostro di china, Ignazio se ne era sentito irresistibilmente attratto.
Scalciando e sbuffando era stata trascinata nel recinto ed era rimasta lì, da sola, staccata dagli altri, a scavare nervosa la terra.
E nel recinto, tra quei cavalli tutti ugualmente belli ed imponenti, lei, così piccola, sembrava un pollicino nero in mezzo ai giganti.
Teresa; così l’aveva sentita chiamare.
E Ignazio non aveva potuto fare a meno di osservare come fosse simile la sua condizione a quella di Teresa.Che disdegnava la compagnia degli altri cavalli, rifiutava il morso, le briglie, la sella; non si lasciava cavalcare, non si piegava né alla frusta né allo zucchero degli allenatori.
Ignazio le vide scintillare negli occhi la stessa fierezza dei cavallini della Giara e non riuscì a trattenere la commozione.
Il commendatore osservava furioso le bizze di quella cavalla costatagli fior di quattrini e i vani sforzi dei suoi fantini che, seppure arrivavano a salirle in groppa, non riuscivano mai a lanciarla al galoppo, strappandole semmai un lento e annoiato trotticchiare.
Ma Ignazio aveva intuito fin dalla prima occhiata che Teresa sarebbe stata capace di sbaragliare qualsiasi concorrente.
Gli era bastato osservare i suoi occhi e i lampi di fierezza che lanciavano, il torace profondo che nessun sottopancia normale avrebbe mai potuto fasciare, la muscolatura perfetta e compatta delle sue zampe, quella schiena nera, salda e vibrante come un pezzo d’acciaio, per capire che quella cavalla era un campione.
Quando poi la cavalcò per la prima volta quelle impressioni trovarono una meravigliosa ed anzi ancora più sorprendente conferma. Teresa sprigionava dinamite.
Era una perfetta e sofisticata macchina da corsa, una fuoriserie luccicante dentro cui batteva un cuore immenso e generoso, che avrebbe saputo sopportare fatiche e sofferenze, un cuore che Ignazio aveva voluto sentire battere prima di arrivare alla sua certezza; Teresa era nata per vincere.
L’aveva cavalcata, di nascosto a tutti, senza sella, come faceva da bambino con il cavallo di suo padre.
E Teresa l’aveva accolto con gioia, come se lo stesse aspettando da sempre, come se in quel piccolo corpo di uomo dalla voce così dolce e suadente avesse riconosciuto le stesse malinconiche linee del suo cuore.
Da quella volta, quasi tutte le sere, quando riportava i cavalli nelle stalle,Ignazio aspettava il momento propizio per non correre il rischio di essere visto e poi, dopo essersi issato sulla sua groppa, si lanciava al galoppo. E che gioia sentiva crescergli dentro.
Gli sembrava di vivere il suo sogno di bambino: quello di cavalcare uno dei cavallini della Giara.
Solo così, attaccato a quel cuore, Ignazio dimenticava le amarezze della sua vita, dimenticava quelle parole, nano, nano delle montagne, che sentiva ripetere ogni giorno, dimenticava l’invidia degli altri e quella tensione quotidiana che si allentava solo nei giorni precedenti la gara quando il lavoro teneva occupata la gente della scuderia e il pensiero della corsa non lasciava spazio ad altro.
Ma il fatto che Teresa si rifiutasse ostinatamente di correre cominciava a preoccupare un po’ tutti e rendeva la vita ogni giorno più difficile.
Il commendatore era furibondo ed ogni volta che vedeva quella cavalla nera perennemente stizzosa gli venivano alla mente la speculazione fallita, i soldi buttati e le illusioni svanite. Quel diavolo nero era arrivato dall’inferno a turbare la tranquilla esistenza di un uomo dabbene.
La sua naturale ritrosia, l’innato rispetto per sé e per gli altri, rispetto che significava accettare il proprio posto con dignità, senza sconfinamenti non richiesti, impedivano ad Ignazio di presentarsi al commendatore e confessare “Mi faccia cavalcare Teresa. Solo io sono in grado di farlo”.
Ma una sera il destino parlò per lui.
Ritornato alla stalla dopo la sua quotidiana galoppata con Teresa, trovò ad attenderlo il commendatore, avvertito chissà da quale malalingua, che lo stalliere di Barumini, il nano delle montagne, si concedeva il lusso di cavalcare uno dei cavalli della scuderia,per giunta il più importante.
Non sapeva il serpente che le cose sarebbero andate ben diversamente da quello che aveva immaginato.
Il commendatore non gli diede alcuna punizione, non mostrò rabbia né collera, non lo cacciò dal paradiso terrestre, se quello era l’intendimento del serpente. Disse poche cose mentre Ignazio riconduceva Teresa nel suo box, precise e taglienti:
“Tra una settimana si corre il Gran Premio di Chilivani. Lo correrai tu. Se sei così bravo da cavalcare questo tizzone nero, per giunta senza sella, vincerlo non ti sarà difficile. Sarà meglio per te.”
Il seguito si svolse in fretta, come immagini accelerate di un film.
Ignazio non aveva mai pensato di fare il fantino, anche se la struttura fisica e l’eccezionale abilità nel cavalcare lo indirizzavano naturalmente verso quel destino. Sentiva dentro di sé, fin dai primi anni trascorsi nella solitudine della Giara, che la sua vita sarebbe stata legata ai cavalli. Ma star loro accanto e respirarne la stessa aria gli sarebbe stato sufficiente. Diventare un fantino era una possibilità talmente esaltante che Ignazio, educato alla vita dura delle sue montagne, dove i sogni non sono contemplati, non aveva cullato nemmeno per un istante.
E adesso diventava realtà proprio quel sogno mai sognato.Lui con indosso la sgargiante casacca rosso-verde della scuderia Flores allineato ai nastri di partenza per la sua prima gara con Teresa.
Si sorprese lui stesso di non essere per nulla emozionato. Neanche quando guardò le tribune gremite di gente, neanche quando lo starter diede il via, neanche durante la corsa.
Ignazio pensò per un attimo che non poteva essere lui a vivere quel sogno. Che in realtà fosse un altro quello che stava partecipando al Gran Premio di Chilivani davanti a quella tribuna piena di gente.
Solo così poteva spiegare la sua indifferenza; come se tutto quello non lo riguardasse.
Sapeva che avrebbe vinto. Quel fuoco nero volava sotto di lui, imprendibile, irraggiungibile; divorava metri su metri sfiorando il terreno; le altre giubbe galleggiavano lontano dietro di lui.
Vincere non fu che una formalità.
Quando oltrepassò il traguardo una folla entusiasta lo circondò.
In quell’attimo finalmente si rese conto di quello che era accaduto e di quello che stava accadendo.
Una scossa elettrica gli attraversò la schiena.
Dall’alto del suo destriero,avvolto da una bandiera rosso-verde con la quale i dipendenti della scuderia gli avevano avvolto le spalle, quegli stessi che fino a qualche giorno primo lo avevano schernito, tra una folla plaudente che invocava il suo nome gli sembrò di essere veramente quel condottiero che sognava di essere da bambino; il re del popolo dei nuraghi.
E come si sentiva alto e imponente sul suo cavallo e quanto piccoli e meschini e ridicoli quelle persone che applaudivano sotto di lui e sorridevano e si avvicinavano per stringergli le mani.
Sparì come di incanto ogni triste pensiero. Altro che nano delle montagne. Lui quel giorno, in un colpo solo, aveva trovato la sua vita, il suo mestiere e la sua miniera d’oro.
E adesso si sentiva un gigante.
Quando scese da Teresa e appoggiò i piedi sulla sabbia della pista si sentì a cavallo della terra. Era potente ormai, e destinato a diventarlo sempre di più.
Non si rese conto in quel momento, Ignazio Fadda, che aveva soltanto cambiato scaffale.
Il racconto è tratto dal libro Le formiche rosse. Per acquistarlo cliccare QUI