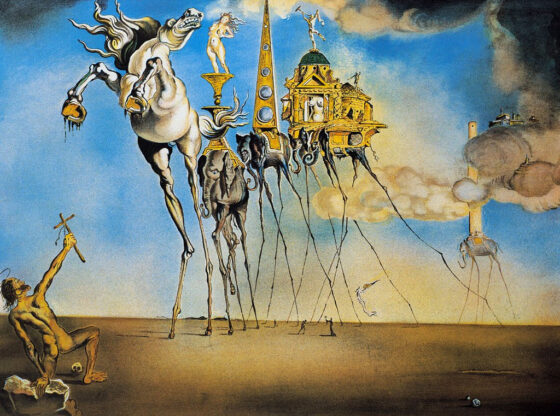L’Estate di Bea
di Patrizia Di Donato
C’e’ una foto sulla cappa che sovrasta la grande stufa a legna. E’ priva di cornice e la qualità della carta ne denuncia l’assenza. Le estremita’ sono leggermente accartocciate, i colori appaiono stanchi e un leggero strato di polvere l’arrosa e la protegge.
La foto vive in cucina. Ne assorbe gli odori, i vapori, il fumo del camino, il profumo delle tovaglie fresche di bucato, il ronzio di un’ape impertinente. Riconosce l’acciottolio della mezza, il bonario borbottio dell’acqua nella pentola e tutti i suoni, quando si concentrano su quell’atto arcaico e solenne dell’accostarsi al desco.
Poi le parole belle, tenere, quelle piene di rabbia, di apprensione, di dispiacere. Le parole quando stanno zitte e pesano più di uno schiaffo. Poi? Le visite degli amici, le cene di polente, i tappi sul soffitto, gli zii che ritornano, le lacrime, le risate, la musica, gli abbracci, e i baci.
La vita. Tutta una vita dentro una stanza dove da sempre, si custodisce il sacro fuoco dei vincoli ancestrali.
L’assenza di cornice nella foto, potrebbe apparire come un deliberato atto di negligenza. Non intendo in alcun modo tutelarti, non sarò io a difenderti dal tempo, sei tu il ricordo, devi farcela da solo, non attenderti una protezione, un argento, un legno intarsiato, una doratura, non aspettarti nulla da me. Dimostra quanto vali, senza l’aiutino di un riflesso del vetro ladro.
E invece non è affatto così, perché la bimba della foto si chiama Bea e allora tutto si capovolge e gira vorticosamente su sé stesso, per tornare sempre al punto di partenza.
E’ un’assolata giornata di fine d’agosto e Bea indossa un paio di pantaloncini verdi e una maglietta a righe, bianca e verde. Dietro alle sue spalle si staglia il monte Cervino. Suo padre si è dinoccolato e ha posizionato la macchinetta fotografica dal basso verso l’alto, ottenendo l’effetto ottico di un piccolo corpo alto quasi quanto una montagna.
I capelli biondi sono legati in una piccola coda di cavallo, mentre una frangetta ribelle e scomposta si contorce libera e spensierata. Non è ancora giunto per lei, il tempo degli specchi, per questo lascia che tutto sia vero.
Il peso del corpo grava tutto sulla parte sinistra, la parte dei sogni, dei colori, dell’astrazione. Anche la piccola spalla si abbassa adeguandosi alla scelta, la gambetta destra accetta rigida, di sostenerne lo sforzo. La mano sinistra stringe un piccolo occhiale da sole. Qualcuno, forse io, deve averle chiesto di toglierli perché il ceruleo degli occhi si offre solo temporaneamente al suono del suo nome. Bea guardaci, sorridi Bea, facci vedere gli occhietti belli.
Gli scarponcini da montagna sfiorano un ginepro nano e decine di soffioni sembrano attendere il clic per librarsi dall’alto delle sue dita.
E’ stata lei stessa a chiedermi di mettere la foto lì.
Al mio rapido annuire, aveva delicatamente abbandonato la fotografia accanto ai tre vasetti con le scritte in greco e quando avevo sottolineato l’assenza di una cornice lei aveva risposto:
– Va bene così, meglio così. Deve stare così. E’ una foto libera.
E così l’avevo lasciata.
Bea ha sempre avuto uno strano rapporto con le cose, con la realtà che la circonda, con gli accadimenti, con le stagioni. In inverno, indossa maglie a maniche corte, in cui i contorni di ridicoli teschi, brillano in vistose paillettes.
D’estate invece, trascina degli improponibili scarponi, Dottor Martens mi corregge, e maledice il caldo mai così caldo come quest’anno. Le maniche delle maglie coprono le piccole mani che appaiono rapidamente solo per afferrare l’ennesima tazzina di caffè.
Anche il suo rapporto con il cibo e’ fugace, frugale, diverso. Parsimonioso, ecco sì, come se dovesse sempre risparmiare per qualcuno, come se il cibo fosse sempre troppo per alcuni e poco per troppi.
Guai a chiamarla per il pranzo o per la cena.
-Mangerò quando avrò fame. Ma chi li ha stabiliti gli orari per mangiare? A quale pazzo è venuta l’idea balzana del pranzo e della cena? Esiste un’abitudine a una necessità?
-Non siamo bestie Bea, siamo esseri umani civili, educati- rispondevo con saccenza.
-Hai ragione, siamo esseri umani. Le bestie sono migliori di noi. Loro mangiano quando hanno fame. Noi non ci nutriamo, noi ci esibiamo.
Avrebbe desiderato tanto partire Bea. Andare via lontano. Raggiungere l’amata Africa.
-Dimmi la verità. Se decidessi di andare a vivere in Africa, non per una vacanza intendiamoci ma per un vero e proprio cambiamento di vita, diciamo un reale trasferimento, tu, come la prenderesti?- mi aveva chiesto un giorno mentre riduceva una polpetta in piccole parti infinitesimali, neanche dovesse alimentare un esercito di pulci.
Ha sempre finto di essere altro, di odiare il rosa, il romanticismo, le moine. Le scarpe eleganti che le regalavo le riavvolgeva nella loro carta velina, mi ringraziava e correva rapida a infilarsi un paio di quelle scarpe da tennis con le borchie e qualche strappo da storia vissuta, si accertava che suoi piedi aderissero sempre alla terra, come se vivesse in un eterno timore di scivolare via, trascinata da una folata maligna.
Eppure di una cosa sono certa, se un giorno le avessi chiesto, con lo sguardo mesto:
-Bea, solo per questa volta, potresti mettere le scarpe eleganti? Lo faresti per me?
Ecco io sono certa che lei avrebbe indossato scarpe rosa, con inserti di pizzo, con tacchi argento, o lucide con strass. Lo avrebbe fatto per me, sono sicurissima avrebbe accettato senza battere ciglio, perché io sono sempre stata il centro da cui rifuggire, un impedimento al suo Dio mio come sei diventata grande, al suo attraversare le strade del mondo senza sostare troppo sul ciglio, senza il timore di ciò che potrebbe. Ma sono anche stata il magma della sua terra, il cuore caldo in cui scaldarsi negli inverni delle delusioni, il tetto, la coperta gigante, le orecchie giuste, quelle che solo tu puoi capire, gli occhi che notano il rossore accennato sulla punta del naso, le labbra quando s’imbiancano e affrontano la paura. Sua madre.
-Che domande, sei mia figlia, un minimo di dispiacere lo proverei, ma penso che alla fine me ne farei una ragione. Sei un’adulta ed è giusto che tu viva la tua vita.- mentii.
A quel punto lei cominciò a ridere.
-Ecco, me lo sento, stiamo giungendo a grandi passi alla fase “come dice Gibran”, i figli non sono cosa tua, ti camminano accanto ma non ti appartengono, eccetera eccetera. Vecchio mantra che ripeti più per convincere te stessa che per altro. Io ti consiglio di fare come quando ci si cava un dente. Occhi serrati, uno strappo deciso e il dolore piano piano si allevia. Certo, la lingua sentirà la voragine dell’assenza ma lentamente le carni si ricomporranno e tutto tornerà alla normalità. Hai apprezzato l’esempio poetico?
-Con un dente in meno però !- avevo riso, nel mio esasperato egoismo, tranquillo che si trattasse solo di un gioco.
E anche lei rideva. Io però di più, perché Bea è la mia vita e di Gibran me ne frego.
Quella di andar via è sempre stato un suo refrain. Ogni volta che dissentivo o le imponevo qualcosa, lei afferrava la porta della sua cameretta e prima di sbatterla violentemente urlava:
– Tu, e la tua maledetta sindrome di Atlante. Tanto me ne andrò, ah se me ne andrò!! Vedrai se me ne andrò!
Ma la sua rabbia era un volo di farfalla, rapido e impalpabile. Dopo pochi minuti, la sentivo scendere lentamente le scale, apparire in cucina come se nulla fosse e infine sedere davanti al camino, non prima di aver allegramente chiesto:
-Mammì, stasera faccio l’essere umano. Ceno con voi, volete?-
Mi stava bene così. Ero contenta. Bea che sognava di vivere altrove, io che convincevo suo padre ad acquistarle una nuova auto, lei che invitava tutti i suoi trenta amici, io che friggevo fino al mattino, lei che beveva un rum e giurava mai più, io che chiamavo il pediatra nel timore di una dipendenza, lei che abbracciava sua sorella incinta e piangeva perché solo le cretine mettono al mondo figli, perché questo è un mondo schifo, io che le porgevo il nipotino ,lei che non voleva più renderlo a sua sorella, lei che scompare una notte e noi che allertiamo anche la protezione civile.
Stavamo bene così. Avremmo potuto vivere per sempre così. E invece no.
Perché i rettangoli bianchi, i fogli con le lettere nere, sono sempre in agguato. Ci spiano. E al momento opportuno entrano senza bussare, senza chiedere: Vorreste smettere di ridere?
Loro non devono fare domande alcune. Entrano e stazionano sul tavolo della cucina. Per giorni.
Possiedono nomi altisonanti, a volte ignoti. Bisogna cercare sui vocabolari, su google, sulle enciclopedie. Le Diagnosi sono despoti, entrano e basta. Non puoi cacciarle vie, minacciare di chiamare i carabinieri, chiedere aiuto ai vicini. Le Diagnosi vincono sempre. Davanti a loro i muscoli si accorciano, la voce torna indietro, le mani si irrigidiscono e i piedi rattrappiscono.
Raramente le Diagnosi sono uno scherzo. Sono incapaci di ridere, si appropriano dei denti altrui, dei suoni gioiosi, dell’allegria, di cose che non useranno, di orpelli di cui strada facendo
si libereranno.
Bea non sarebbe mai più tornata in Africa. Né per poco, né per molto. Questo esigeva la Diagnosi.
Di ritorno dal suo ultimo viaggio in Africa, prima che la Diagnosi entrasse a casa nostra, Bea aveva dovuto pagare un supplemento per il peso della valigia, avendo superato di molto il peso consentito. Aveva caricato di tutto. E allora, nel momento in cui tutti noi eravamo fermi come monumenti tristi davanti alla Diagnosi, fu in quel preciso momento che capii quel peso in più, come se avesse intuito che qualcosa sarebbe andato storto e lei non avrebbe più messo piede su quella amata terra.
E allora aveva trovato una soluzione. Avrebbe portato l’Africa con sé.
Innumerevoli frammenti d’Africa da ricomporre in un appartamento tutto suo. E così fece. Entrare a casa sua era come varcare la soglia di un luogo ricreato da un’immigrata. Si avvertiva il dolore di una vita trascinata altrove e coraggiosamente ricomposta, una strada di casa, un profumo lontano, il micronucleo di una famiglia distante, di un canto che non rimbalza fra le pareti del chiuso, vola alto, scivola fra il mare e il deserto, le dune e le oasi, sulle alture o sugli altopiani, la valle del Giordano, il mar Rosso di Mosè, i grandi laghi equatoriali, la savana, i fiumi lunghi, la foresta equatoriale, le rapide , le cascate, i temporali, sulle palme da dattero. E’ il canto del leopardo, la pantera, il leone, le antilopi, le gazzelle, le zebre, le giraffe, gli elefanti, e di tutta la tua amata Africa Bea. Tutto un immenso e frastagliato triangolo di terre, abbicate nella tua pingue valigia viola, striata dall’ocra della sabbia sudata.
A quel punto Bea si innamorò e il ragazzo di cui si innamorò, non pensò alla Diagnosi.
Lui pensò che la amava e la sposò. Questo fece quel ragazzo dallo sguardo che sapeva varcare le cortine e i muri dei treni, delle attese, delle file, degli odori acri. Il ragazzo che aveva un fiuto speciale e sentiva il profumo della terra rossa, quella che Bea mi portò al naso più di una volta senza io ne avvertissi il minimo odore.
Li trovo insieme, stretti sul divano, le pareti di arazzi dai colori vivaci, le donne nere in fila, la sabbia ambrata in piccoli contenitori di vetro, le minuscole tazze acquistate per aiutare, la giraffa gigante, il tamburo. I masai in legno e la loro arma accanto. E le foto. Migliaia di foto libere attaccate alla parete più grande. Lì Bea balla sotto avide gocce. Ho imparato che la pioggia è un bene e quando piove si fa festa, si esce, si balla. Nelle foto Bea ha lunghe treccioline bionde che scendono come stelle sulla notte dei visi dei bimbi kenioti. Le foto di mia figlia sono fuochi d’artificio, liberi di apparire e scomparire ma possiedono bagliori che illuminano il mondo.
Nessuna Diagnosi avrebbe mai potuto cancellare ciò che era già avvenuto.
Questo racconto è apparso sull’inserto culturale, diretto da Simone Gambacorta che ringraziamo, de La Città Quoditiano, sabato 19 maggio 2018