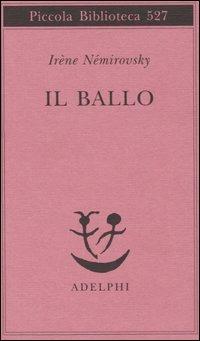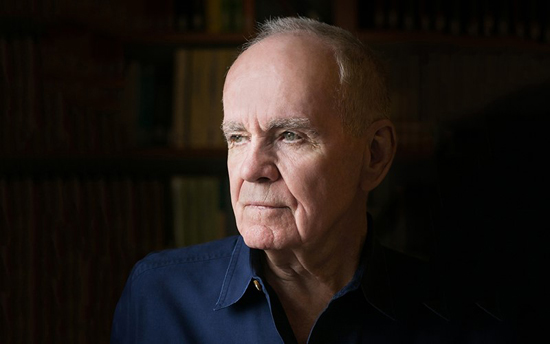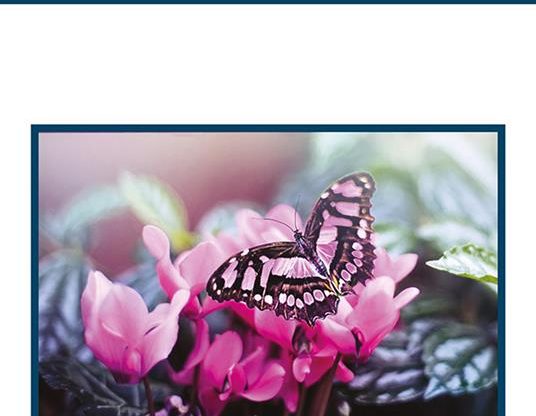Cose d’infanzia
Di Rossella Pretto
Capita di leggere dei libri, uno di seguito all’altro, per una casualità in cui la vita si impernia, senza pensare che si chiamino e si rispondano. Si assomigliano, in qualche modo.
Direte: in che modo?
Per una certa descrizione della fanciullezza trascurata, per quelle piccole crudeltà che fanno amara la carne non ancora ispessita. Una pelle morbida che viene ripetutamente battuta e che deve cedere al colpo, come fosse normale. Eppure sai che Auden diceva che il trauma è quella cosa che il bambino aspettava per fare della sua esistenza qualcosa di importante.
Sì, certo, epperò vai a dirlo a chi si trova di fronte alla brutalità, inerme e con occhi ancora puliti, così puliti e onesti che puoi vedervi in diretta il crollo di ogni candore e la domanda, quella domanda inevasa che chiede – perché?
Ecco allora i due libri di Tove Ditlevsen e Irène Némirovsky, e i loro due piccoli mondi distanti. Copenhagen e Parigi. Il primo capitolo della Trilogia di Copenhagen, ‘Infanzia’, e Il ballo, letti, appunto, uno dopo l’altro.
Il ballo è stato un dono ricevuto dopo la visione della mostra sul tempo, in Basilica Palladiana, dove campeggia l’opera di Arcangelo Sassolino e i quadri di Caravaggio e Van Dick, il San Girolamo e Le età dell’uomo. Solo tre capolavori, ma una bella operazione, lo ammetti, concentrata e d’impatto. Sassolino presenta un gigantesco disco rotante di metallo spalmato con una spessa passata di olio industriale altamente vischioso. Il movimento impedisce al colore di crollare velocemente a terra facendo resistenza. Si intitola No memory whitout Loss. E ha a che fare con la sostanza della vita, che non è solo sogno o miraggio di un povero attore che si pavoneggia la sua ora sulla scena, ma anche moto incessante che tiene in piedi, ancorati qui ancora per un po’, e che prevede a ogni istante una piccola morte, una perdita connaturata al senso del restare. Parla del mutamento, della metamorfosi che si compie a ogni respiro. Ma quelle gocce a terra, quel rosso che fatalmente cade dal disco… ecco lo scotto che si deve pagare, rosso appunto come il fluido che scorre nelle vene e che simboleggia anche la sofferenza del sangue versato, quella violenza. Lì, a terra. Senza alcuna possibilità di tornare in circolo.
La vita è così.
E così è fin dall’infanzia, molto spesso. O comunque è quello che raccontano i due libri che hai sottomano. Il racconto della Némirovsky descrive il primo ballo organizzato da una famiglia di parvenu proveniente da un piccolo appartamento buio dietro l’Opéra-Comique e la volgarità della signora Kampf che già dal suo ingresso in scena, nelle primissime pagine, fa sbatacchiare le gocce di cristallo del lampadario tale è la furia con cui si fa richiudere la porta alle spalle. Entra dunque nello studio dove la figlia quattordicenne è intenta a leggere, concentrata, e la giovane istitutrice inglese (anche lei poco più di una bambina) si confeziona un abito con la macchina da cucire intonando qualche strofa di una canzone. Ma la maniera della madre di rivolgersi ad Antoinette, di sgridarla sempre, riprendendola, l’irritazione perenne nella voce… è solo una ragazzina goffa che subisce la pressione della madre, il suo arrivismo e la grossolanità dei modi. L’ipocrisia di chi è venuto su dal nulla e tenta di colmare di bugie un passato inesistente, il pettegolezzo, la malignità. E la bimba vuole solo essere sé stessa, provare l’amore, vivere i suoi anni senza quella commedia, quel ridicolo atteggiarsi e quell’imbarazzo che nasconde il vuoto su cui si vuole costruire un’apparenza, solo quella. Così Antoinette attua la sua piccola vendetta. Una vendetta che diventa uno smacco straordinario per la madre: non spedisce gli inviti al ballo! E allora si tocca e si sperimenta, denso e acre, il risentimento di una ragazza che piange per le umiliazioni, il sangue amaro che si fa, il capriccio rivoltoso di chi si indurisce alla scuola dell’esistenza e vorrebbe dar pugni a chi la intralcia! Maligna anche lei, calcolatrice. Et voilà, la grande casa sfavillante e agghindata a festa, l’orchestra, il trionfo del cibo, lo sfolgorio dei gioielli della madre… e nessuno si presenta. Un’occasione, dunque, per strappare un abbraccio a quella donna, con un sorriso perfido che nasconde la vittoria del buio.
Eccole lì, le gocce rosse a terra che stanno a indicare che bisogna mutare seguendo il corso degli eventi e perdendo in… in cosa? Dignità, umanità? Ingenuità e autenticità, di certo.
Ma è così, e il disco gira ancora.
E arriva a Tove Ditlevsen, scrittrice novecentesca riscoperta da pochi anni, nata nel 1917 e legata alle vicende autobiografiche che narra in diversi romanzi, vicende che indaga molto anche nelle raccolte poetiche tentando di non farsi investire dal modernismo ma venendone a patti. Vita difficile, la sua, con periodi di narcomania e alcolismo, e che termina con il suicidio. In questo primo capitolo della Trilogia, Infanzia, va a comporre un affresco dei suoi primi anni in un quartiere operaio di Copenhagen – l’ambientazione è quindi molto diversa da quella della Némirovsky che faceva interagire i suoi personaggi sullo sfondo di una Parigi-bene (ma la provenienza dei parvenu non era quella, abbiamo detto). Qui, nella cornice della Istedgade, l’arteria che corre dalla stazione centrale a Vesterbro, la strada dell’infanzia, la piccola Tove vive con i genitori e il fratello. Il ritmo di quella via le pulserà sempre nel cuore, con i suoi negozi dove la madre tira sul prezzo con «copenaghissima sfrontatezza» e dove gli ubriaconi agli angoli delle strade non si contano più. Il padre è una figura debole e la madre altro modello di donna insoddisfatta e ingrugnita. Ma il romanzo si apre su una nota buona, una speranza: «Al mattino la speranza c’era. Si posava come un effimero bagliore sui capelli neri e lisci di mia madre, che io non ho mai osato toccare». Vi è subito una distanza, e anche la luce che balena appare effimera. La speranza si infrange subito: «Ora che la speranza era infranta, mia madre si vestì con movimenti bruschi e rabbiosi, come se ogni capo d’abbigliamento fosse stato un’offesa alla sua persona. Dovevo vestirmi anch’io – il mondo era freddo, pericoloso e inquietante – perché la cupa ira di mia madre sfociava sempre in un ceffone o in uno spintone verso la stufa di maiolica». E allora, a quella bambina tocca rifugiarsi in un mondo dove strani paroloni fungono da membrana protettiva, ritmica, poetica, tanto che il male sembra lontano e niente può più toccarla, neanche la madre che diventa ostile ma non alza più le mani. Al di fuori c’è tutto un universo fatto di case popolari e di famiglie zoppicanti e malconce, un sobborgo urlante e controverso che sa di Parise, o a volte di Ortese, per tutto quel pullulare di figurette sboccate e con le toppe della miseria che trascorrono nei cortili o si fermano a chiacchierare vicino ai bidoni dell’immondizia. Ma c’è anche la scuola, in Infanzia, e un mesto senso di pietà – sempre per la madre e le difficoltà degli ultimi: «Alzo lo sguardo su di lei e mi rendo conto di diverse cose simultaneamente: è più piccola delle altre donne adulte, più giovane delle altre madri, e al di fuori della via in cui abitiamo c’è un mondo che la spaventa. E quando ci spaventa entrambe, lei mi pugnala alla schiena. Ora che siamo lì, davanti alla strega, noto anche che le mani di mia madre sanno di bucato. Lo detesto, quell’odore, e mentre in perfetto silenzio usciamo dalla scuola, il mio cuore si riempie di quel caos di rabbia, dolore e compassione che da oggi in poi, per tutta la vita, mia madre desterà sempre in me».
Una madre da tirare in piedi, una madre in difficoltà non è cosa da poco per una bambina che proverà sempre quel coacervo di sentimento tra la rabbia e la compassione, come scrive la Ditlevsen.
E anche qui, poi, e per un senso di circolarità, c’è una porta che si chiude e sbatte: è la madre arrabbiata con lei, solo che qui non tintinnano le gocce di cristallo del lampadario ma piovono pezzi di intonaco.
È così che si cresce, frutti storti di un ambiente che non si riconosce ma animati da aspirazioni altre, provenienti da chissà quale angelo che viene a toccare la spalla perché la vita si apra e il respiro diventi parola che viaggia.
Così passa l’infanzia, i cui ultimi residui cadono di dosso a Tove «come scaglie di pelle ustionata dal sole, sotto la quale traspare un’adulta sbagliata e impossibile».