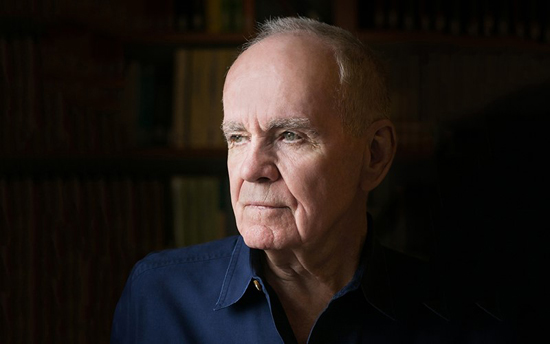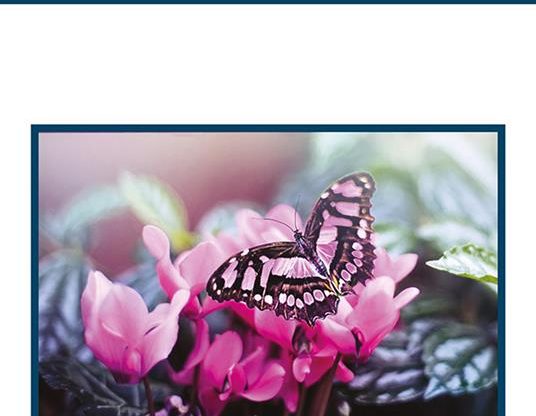La scrittura necessaria
Di Giovanna Dal Bon
Postfazione al libro di Michele Toniolo

Affidarsi alla scrittura nel tentativo di dire l’indicibile: il mistero insondato del congedo definitivo, quello che non può e non deve farsi racconto, che non conosce il balsamo consolatorio del narrare letterario. Nessuno spazio concesso al comunicabile, nessuna indulgenza possibile. Solo l’inesorabilità del senza accesso, del senza appello: l’inviolabile assoluto della morte. Michele Toniolo si affida all’unico strumento che gli è urgente e necessario: la parola. Quella nuda, scarna, la sempre inadeguata ad esprimere il senza ritorno. Parola che non cerca conforto, né può offrire asilo, “non diventerà ciò che è stato”. Non va incontro a nessuno. La sua scrittura abita questa radicalità esposta alle intemperie, al tormento dell’inadeguatezza: “solo la verticalità, solo lacune e spazi vuoti”. Non ha bisogno di intermediari. L’imminenza della perdita scuote alla radice la parola, la ammutolisce. Argina l’erompere del grido perché si fa grido; imponendo distanza e misura. Scrittura che si accorda al battito e non tracima; resta verticale in attitudine di ascolto frontale, nell’ob-oedere: “Non racconterai di tua madre, Berg, non inventerai un’altra madre”. Qui Toniolo convoca un nome proprio che rievoca paraggi nordici, quelli che gli sono affini, nei quali si identifica e trova asilo. Anche il titolo, “Gli affetti del giovane Berg”, è diretta filiazione di quella latitudine mitteleuropea di tanti Bildungsroman iniziatici, dal Werther a Walser ai Törless musiliani. Un depistaggio comunque, ci si accorge sin da subito che qui siamo in altri ambiti, quelli forse più estremi dell’ananke ellenica; quella necessità da cui non esiste scampo, che impone la sua legge di natura, che costringe in limiti ben precisi e non arrischia sconfinamenti nell’hybris. Il sostantivo “affetto” nei dizionari viene indicato come “stato interiore di tipo emozionale”; risalendo a voce più arcaica troviamo “incline, disposto ad essere raggiunto, attraversato da intensità”.
I brevi “paragrafi” in successione numerata che cadenzano questo passo d’addio non offrono tregua; ogni frase è inciampo, fatica nel procedere su una parete liscia con il supporto di un solo puntello ad agganciare la roccia: “ad ogni frase temi di perdere l’equilibrio”. Sono sorretti da “un tempo di tosse; un quaderno nero riempito di caratteri giganteschi da una mano malferma, terremotata dai polmoni”. Così le sillabe, i segni d’interpunzione, gli iati silenziosi. Le figure hanno l’assoluto dell’archetipo madre/figlio nel corpo a corpo dell’ultimo congedo. Ed è il corpo il luogo di questo estremo sentire. Nel corpo si invera il dolore e l’impensabile del distacco; la schiena si immobilizza, l’angoscia piega, la fatica di scendere dal letto, e poi sempre più feroce quel “solco che si apre tra i polmoni e scende”. I movimenti di tutti i giorni, quelli famigliari, nelle ore che scorrono e agganciano il reale. Dati precisi: “tua madre appoggia il giornale sul tavolo esterno della malga e alza gli occhi verso il Cimon della Pala”. Per abbassare poi lo sguardo al figlio: “ti guarda con i suoi occhi di madre”. Gli oggetti, le cose, i gesti nella loro funzione immediata sorreggono il quotidiano: il caffè, le tazze, i bicchieri, pastiglie, vitamine, il tavolo in marmo basso e pesante, le risate, gli sguardi, i tappeti, inchiodano all’adesso, al qui ed ora di un sentire che non obbedisce più al conteggio delle ore, al prosastico del kronos. Un tempo immobile e sospeso, che non ha più relazione con la vita umana, dice un estremo e intimo accadere; consegnato all’assoluto trascendente dell’aiòn. Le parole pronunciate una volta e mai più, rimandano a quella dimora del tempo sospeso che è la nona Elegia duinese di Rainer Maria Rilke: “(…) ma questo essere stati una volta, anche una volta sola / quest’essere stati terreni / pare irrevocabile”.
Quando la morsa della vita, carica di un futuro sempre prossimo allenta, ecco che irrompe il tempo dell’infanzia, ghermisce i ricordi, prende in ostaggio la memoria recente: “ti domanda della casa, non dove abitate, ma della corte di Via Carducci (….) ti domanda di un mondo che non ti ha mai conosciuto, come se ora volesse liberarsi di te e tornare bambina a giocare nei giardini dedicati a Virgilio”. Mantova è il suo infinito presente, i giochi con le amichette, la vita da sfollati a Ospedaletto Euganeo, gli animali, “il nonno le vuole bene”. Nulla ha a che fare con la memoria retrospettiva, con il ricordo consapevole di accadimenti remoti; si tratta di un tempo ritrovato come d’incanto, come se tutta la vita di mezzo fosse cancellata. Un ritorno all’origine che in medicina viene spiegato come uno slittare dei neuroni tale da sovrapporre piani temporali, forse ha a che fare con un istintivo ritrarsi nei luoghi incontaminati dei primi passi, quelli che la vita non ha ancora costretto ad obblighi e ruoli, in un allontanamento progressivo e inesorabile da quel se stesso primigenio che è il noumeno di un’identità. Lo scultore rumeno Brancusi negli ultimi tempi della sua vita, nell’atelier bianco abbacinante di sculture parlava solo la sua lingua madre a chi non poteva comprenderlo; come se tutto il vissuto non fosse che un lungo viatico verso l’origine.
Un bicchiere e una tazza da tè non riposti nella credenza bastano per mandare in frantumi il suo fragile equilibrio. La madre urla come se si trattasse di un’irreparabile tragedia. Il suo ordine è stato sovvertito “perché anche un bicchiere fuori posto, per lei, è presagio della fine”. è tempo di lasciare spazio solo alla preghiera: bisbigliata nella stanza accanto, indizio di presenza, di intimo accordo; sola ad offrire asilo e conforto: è tempo di affidarsi. La madre sa: “che inizia il suo Venerdì Santo”. Guida le azioni fino alla chiamata all’ambulanza: ”fai quello che devi”. Nelle steli d’età periclea nel V secolo a.C., i congedi ultimi vengono impressi in marmorea bidimensione; figure longilinee pronunciano l’addio con un lieve sfiorarsi di mani, occhi negli occhi. Non c’è spazio per l’erompere emotivo. Quello e solo quello è concesso all’effimera durata di una vita umana, nel più puro e intenso degli intendimenti come le mani che “stringono il suo volto” prima di essere portata via. E qualsiasi parola risulta superflua e non necessaria: “quando la dottoressa ti avvicina fuori del reparto, capisci che non hai bisogno delle sue parole”. Negli istanti che approssimano la fine, la sola cosa che pronuncia con netta assertività va oltre un desiderata: “quando non ci sarò più mi dovete cremare e mettere assieme al papà”.
Quella casa che ha visto gli anni trascorrere, le stagioni avvicendarsi, vite di esseri intimamente legati, intreccio di sangue e destini; vive il suo ultimo giorno. Lei riesce ad alzarsi dal letto, da sola, senza bisogno di venire sorretta. Anche qui la precisione è di gesti che vengono compiuti e decritti per l’ultima volta. Nitidi ed esatti come impone la radicalità del distacco: “La mano destra appoggiata al comò, il letto alle spalle, le coperte che sfiorano le caviglie, il sole illumina i suoi piedi scalzi”. Viene convocata la formula con cui Omero prefigura l’estrema dipartita; il cedere delle giunture che assicurano la postura verticale dicono che la forza di gravità ha preso il sopravvento, costringono l’essere umano all’inginocchiamento: “e non importa se poi, fra qualche passo, magari lì, all’inizio del corridoio, le mie ginocchia cederanno, come nell’Iliade”.
Per la prima volta il figlio si trova solo, circondato da mobili, vestiti, oggetti, ricordi, appartenuti ad una quotidianità che da pochi istanti non è più: “(…) ora sono le tue parole a imporsi, le loro immagini, la loro forza, in te non c’è nessun desiderio di raccontare né di inventare”. La parola soccorre, combacia con l’assenza, dà corpo e voce muta alla perdita. Non c’è spazio per altro, null’altro può essere detto che allontani o dis-tragga. Si sceglie di restare, di farsi attraversare e trafiggere dal gelo dell’abbandono: trarne nutrimento. Sentire solo l’emergenza della scrittura nel suo inverare il distacco: “sono le sillabe, lasciate sole sulla pagina, a gridare”. Chi resta sulla soglia mette in discussione e interroga il senso di un’intera vita; rivolge alla scrittura stessa: “scrivere non serve a comprendere, ma a creare distanza”. Siamo all’attimo dopo, al nessun conforto possibile nell’inviolabile assoluto di una sparizione. Il corpo della scrittura progressivamente assottiglia, inizia a rarefarsi, cede allo spazio bianco della pagina: “il silenzio s’impone presto contro le tue parole”. La domanda emerge, quasi a sovvertire un estremo brandello di senso: “ti hanno dato la vita e tu, Berg, non l’hai data a nessuno. Il tuo è stato un vivere scorsoio?”. La risposta tranchant cortocircuita tutto in un’apnea di respiro che si fa anche violento vuoto di senso: “lo sai bene, Berg, avresti dovuto scrivere d’altro”. Brusca chiusura che apre in realtà all’imminenza di un orizzonte nuovo: la scrittura che verrà.