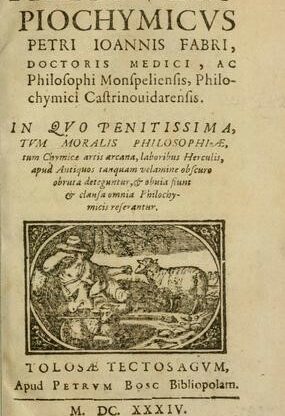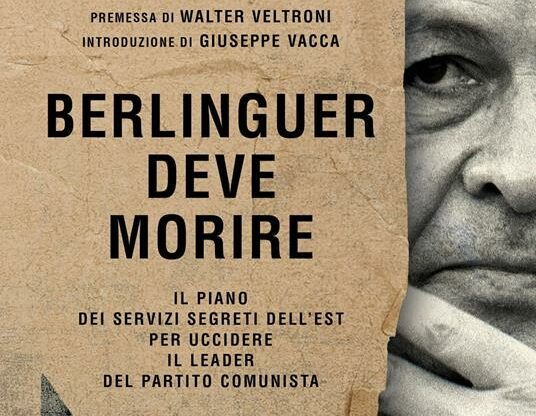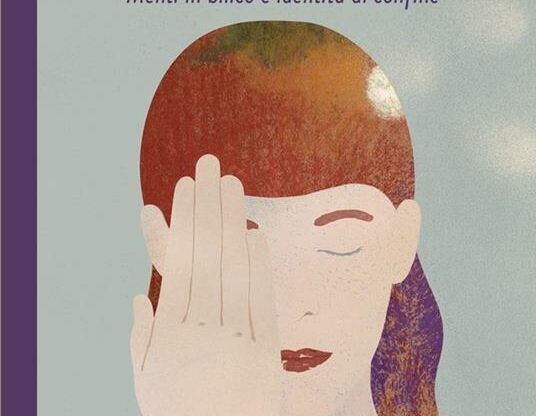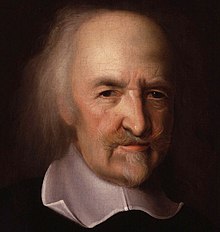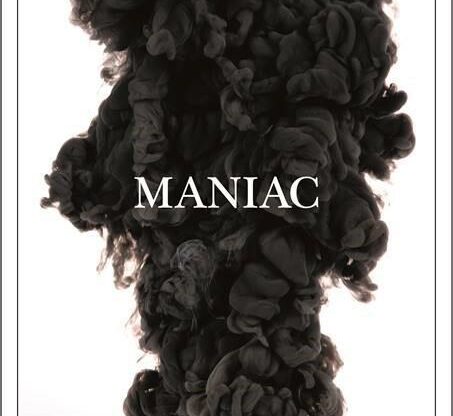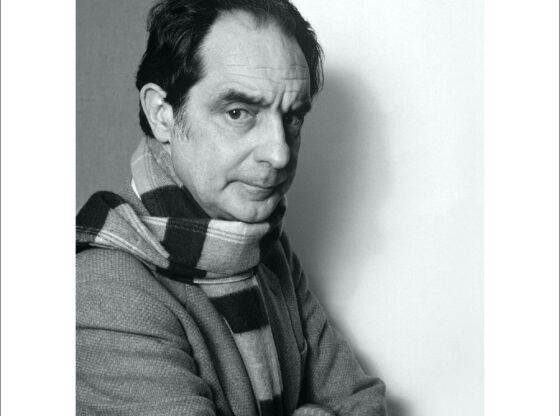“Questo mondo è impossibile”
di Nane Cantatore e Arianna Bonino
Ogni riga di Karl Kraus produce una sorta di oscillazione, un senso di contraccolpo, di vertigine, che dà quasi la nausea. Come se non fosse costruita secondo la classica architettura semantica e sintattica, per cui la sequenza dei vocaboli costruisce una progressione di senso: si deve sempre tornare indietro, ricominciare daccapo. Chi volesse fare bella figura potrebbe citare qui un passaggio hegeliano, quel paragrafo 60 della Fenomenologia dello Spirito in cui si parla della proposizione speculativa e che noi, ansiosi per l’appunto di ben figurare, infatti riportiamo:
In effetto quindi il contenuto non è più predicato del soggetto, ma è la sostanza, l’essenza e il concetto di ciò intorno a cui verte il discorso. […] Subisce esso, per raffigurarselo così, un contraccolpo (Gegenstoß): comincia dal soggetto, come se questo stesse a fondamento; ma poi, dato che predicato è anzitutto la sostanza, trova che il soggetto è passato a predicato e che, con ciò, è tolto; e dacché ciò che sembra sia il predicato è divenuto una massa totale e indipendente, il pensiero non può più errare liberamente qua e là; anzi è trattenuto in una tal pesantezza.
Pesantezza è una parola chiave per capire il testo di Kraus: in questa predominanza del contenuto, che non è solo l’urgenza del presente ma soprattutto l’acribia di andare a fondo, ogni frase viene ritorta verso il centro, schiacciata dalla forza gravitazionale della necessità, innanzitutto morale, del prestare attenzione. L’effetto grottesco, comico, satirico, è collaterale, quasi un equivoco, la via d’uscita per questo disagio che si esprime con il sorriso storto provocato, quasi per abitudine, dall’effetto di rovesciamento.
E c’è ancora dell’altro: perché questo contraccolpo di senso è raddoppiato da un effetto temporale. Kraus scrive, furiosamente, affannosamente del (proprio) presente, annota trascrive ricopia in modo forsennato, si dimena ovunque per cogliere ogni dettaglio, e poi scrivendolo lo ha già storicizzato, messo in prospettiva, sezionato per l’ispezione patologico-forense. Si fa storia del presente, lo si consegna a un passato virtuale per comprenderlo (ancora una volta, viene in mente Hegel: la filosofia è il proprio tempo compreso nel pensiero, diceva). Questa oscillazione continua, questa sospensione nel ritmo, che nasce da una necessità di analisi e comprensione, di critica, diventa appunto finissimo stile. It don’t mean a thing if it ain’t got that swing: per significare, deve ondeggiare.
Un dramma in cinque atti che per mole e frastaglio si dichiara irrappresentabile in partenza, quantomeno se l’impresa fosse tentata con mezzi e “misure terrestri”, perché scandaglia, seziona, dilata la lente su quello che pare grottesca caricatura, ma che altro non è se non resoconto schietto del reale, tanto meno credibile quanto più vergognosamente autentico: anni in cui sulla scena campeggiano e si dibattono personaggi da operetta a cui è affidato fatalmente il ruolo di recitare la tragedia immane dell’umanità. E se viene da ridere – perché questo accade -, l’avvertimento dello stesso Kraus è chiaro fin dalla premessa: “I contemporanei, i quali hanno permesso che le cose qui descritte accadessero, pospongano il diritto di vivere al dovere di piangere”. Non c’è da credere che, a distanza di oltre un secolo, ci si possa ritenere posteri esenti da tale ammonimento: i posteri non esistono, Kraus si legge da contemporanei di Kraus, si scopre di esserlo appena si comincia a scorrere.
Come una bibbia si apre talvolta affidandosi al caso, in cerca di una risposta, “Gli ultimi giorni dell’umanità” è un magma circolare che si presta e si esprime vigorosamente nella lettura a stralci, di singoli atti, e che porta a pronunciare ad alta voce quelle frasi, ritrovandone la genesi di voci realmente udite da Kraus, che si fa in quest’opera monstre testimone lucidissimo del “muro di fuoco” che vedeva alzando gli occhi dalla sua scrivania e che già figurava puntualmente sulle pagine del “Fackel”, la rivista che per venticinque anni, fino alla morte di Kraus (1936), fu popolata proprio dai suoi scritti.
Kraus annota il reale: per tanto che appaia grottesco fino all’assurdo, quello che leggiamo nelle sue pagine non è frutto di un’esasperazione espressionista del macabro: è il reale che coincide con l’assurdo della tragedia bellica e si fa paradossalmente caricatura di se stesso, nell’eccesso di coincidenza con la storia: gran parte del testo è formato da citazioni e stralci di giornali, ordinanze militari, sentenze di tribunali, decreti, bollettini di guerra. Più la realtà è reale, più ha la faccia di un mostro truccato da mostro, un mostro nudo e osceno.
Gli ultimi giorni dell’umanità è programmaticamente fuori scala: si passa continuamente dal triviale al grandioso, dal quotidiano alla storia, dall’individuo alla massa. Questo uso continuo dello zoom, del montaggio, che è tanto più cinematografico che teatrale, al punto da prefigurare le avanguardie cinematografiche, non è (solo) una cifra stilistica ma (soprattutto) una necessità morale, un’opzione politica. Nello sconvolgimento di ogni prospettiva, molto più radicale delle fanciullaggini futuriste e assimilabile a certe scabre arditezze espressioniste, Kraus mette in scena una dialettica deviata, che produce una sintesi perversa. Gli individui hanno la semplicità bestiale delle masse, le masse la piccineria degli individui; ogni gesto quotidiano proietta la sua banale trascuratezza nella storia, la storia rende sinistro e irreparabile ogni atto di tutti i giorni; ciò che è triviale contribuisce a costruire un evento grandioso, che si trivializza e si rende, con orgoglio morboso, meschino. Volendo, nel testo impossibile di Kraus si rintraccia la messa in scena del populismo, nella sua pretesa di superare ogni mediazione, ogni istanza di cultura, ogni pietra d’inciampo della critica, per finire con la riduzione del discorso pubblico a borborigma, e farsene vanto. Lo si vede anche nella didascalia più frequente, quel si formano capannelli che denota l’inizio della fusione dell’individuo in massa (e Canetti è esplicito nella sua profonda riconoscenza a Kraus), la deresponsabilizzazione conformista contrabbandata per libero scambio di opinioni. I capannelli di Kraus sono la rete sociale in cui ognuno può dire la sua, ma finisce per ribadire l’opinione corrente e per rafforzarla con la convinzione dell’adesione spontanea. La tronfiaggine del piccoloborghese che diventa soggetto egemone è il bersaglio perenne di Kraus, che rileva nella famosa stampa libera viennese il punto in cui si celebra questa osmosi oscena che è il movimento permanente dell’opera. Una libertà di stampa che, nella sua vocazione al conformismo, è già pronta a diventare propaganda – e l’osservazione puntigliosa di questa trasformazione è uno dei tanti motivi che rendono Gli ultimi giorni un’opera fondamentale del Novecento, anzi, di oggi. Ma non finisce qui: perché non è certo difficile vedere, nel tratto che dalla letteratura porta al giornalismo e dal giornalismo alla pubblicità, che la tappa ulteriore va dalla pubblicità alla propaganda, ammesso che vi sia differenza. Anzi, questa differenza non c’è, almeno oggi: perché se la pubblicità stava all’impresa come la propaganda allo stato, allora l’abdicazione di questo a quella porta con sé, come ogni abdicazione, i crismi del potere dismesso, donando alla pubblicità il tono di comando della propaganda.
Leggere questo libro all’epoca dei social, proseguendo il meritorio lavoro di Franzen (il Progetto Kraus, Einaudi 2014, ma il testo raccoglie lavori ed esperienze precedenti), è utile ma fuorviante, e forse tanto più utile quanto più fuorviante. Negli Ultimi giorni troviamo, rappresentate con precisione chirurgica, le stesse dinamiche che vediamo nei commenti ai post, la perentorietà con cui i contenuti delle bacheche richiamano la nostra attenzione, l’urgenza di dire la nostra sulla qualsiasi; ma questo è solo un elemento di un panorama molto più grande. La trasformazione dei media in discorso personale, potrei dire l’individualizzazione social dei temi generali, è un caso particolare di quel più generale processo di sussunzione reciproca e abietta tra individuo e società che costituisce la società moderna (e post, e post-post).
Insomma, diciamolo: qui si parla, in ultima analisi, di industrializzazione. Industrializzazione delle coscienze che è legata a quella dei processi produttivi esattamente come il giornalismo lo è alla pubblicità. Industrializzazione della guerra e della morte, non solo al livello elementare del tritacarne di trincea, ma a quello più complicato della mobilitazione generale di esistenze e coscienze, che ottengono il viatico alle loro meschinità attraverso il consenso entusiastico al massacro generale. Industriale, perché a trionfare qui è l’operazione preliminare di ogni industria, la standardizzazione dell’esistente e la sua riduzione a elemento calcolabile, a item sostituibile. E proprio a questo punto, nel nucleo della sua elaborazione, Kraus se ne mostra all’altezza. L’esito di tutto questo non è l’appello nostalgico a una società più arcaica e più vera, ma un’ecpirosi in cui Dio agisce attraverso i marziani, la distruzione finale di un’umanità incapace di redimersi dalla propria piccineria, dalla propria minorità. Qui si indica la possibile via d’uscita, mostrandola senza nominarla – il che, per inciso, è una strategia da messa in scena, da allestimento teatrale o cinematografico, cui la pagina scritta va stretta: la critica, il pessimismo della ragione, il disincanto che mettono a nudo la banalità menzognera, sono la possibilità di pensare in altro modo. Di trovare possibilità diverse dall’impossibile attuale, di costruire una logica all’altezza dei tempi. La macchina, di suo, non è colpevole di nulla; lo è, e qui Kraus si rivela in ultima analisi goethiano, la pretesa di dominarla per fini desideri pensieri che non ne sono all’altezza.
La macchina, protesi suprema dell’umano, ne amplifica la meschinità: gli aerei e i sottomarini, strumenti per andare oltre i limiti fisici della nostra esistenza e realizzare il sogno di ogni epoca, non trovano altra applicazione che nella turpe banalità della guerra. L’umanità ha giocato la sua possibilità universale, e l’ha giocata male; capace di trasformare se stessa e il mondo, ha saputo realizzare soltanto la trasformazione più banale, l’accrescimento di ciò che era già. Per questo, alla fine dell’opera, entrano in gioco i marziani: l’umanità è finita, perché si è finita da sola consegnando la propria grandezza al servizio della propria meschinità [han di sé fatto scrigni di mondano vantaggio/ lordato la lingua col loro linguaggio,/ e mente, parola, pensier, sensazione/ aldilà, messo in mostra per l’esportazione,/ e Dio, il demonio, il mondo, il morire/ e l’arte, al mercante han saputo asservire/ ai viveri il vivere sottoponendo/ col corpo il prodotto finito coprendo/ e, servi dei propri bisogni, la vita/ si son ridotti a comprar con la vita – Epilogo]. La pioggia di meteore è solo il suggello finale, quasi l’eutanasia a un malato terminale che, pure, continua a far danno. L’umanità è finita, restano – finalmente – i marziani.
La degenerazione autodistruttiva della macchina infrange il sogno dell’umanità e, a scanso di equivoci, non è (un brutto) sogno nemmeno questa anti-epopea, o meglio epopea dell’estinzione, tanto che il titolo dell’opera, originariamente formulato come “Da una tragedia: gli ultimi giorni dell’umanità. Sogno angoscioso” sarà modificato da Kraus: il “sogno angoscioso” scompare dal titolo nell’edizione definitiva, quasi a voler escludere totalmente una lettura simbolista o allegorica del lavoro, che invece è il calco autentico di tragedia reale. Un reale la cui tragicità è data dai fatti e dal fatto che i fatti diventano altro dal reale nel corso della narrazione dei fatti stessi da parte dei media: fake news realmente false e falsamente verosimili, costruite ad arte, adibite all’invenzione di una storia diversa che diventa vera perché raccontata da fonti presumibilmente fidate, affidabili e autorevoli e invece dolosamente fantasiosa, deformata e deformante. La stampa smascherata da Kraus ha il suo corrispettivo emblematico nell’intero appartato dell’informazione, paradigma del falso, rinominata da Kraus “Teufelswerk”, “macchina infernale” (o meglio, come rileva sempre Franzen, “macchina del demonio”) dell’umanità, altro paradosso marcatamente krausiano e perfetta sintesi della sostituzione della propaganda all’informazione e con ciò feroce emblema di quel “tecnoconsumismo” Frenzeniano i cui tratti sono quelli di un sistema autofagocintantesi e gonfio di un ingombrante nulla in espansione, negoziato al più caro prezzo e al continuo rilancio, l’odierna e non diversamente dicibile “conta dei morti”. La quantità di cose corpi armi carni kilometri pagine – e post e blog e commenti e scatti – è misura di sostanza e verità, un’indelebile piena di nausea che si autoalimenta e si vomita, una nausea del consumo e dell’abuso del consumo di tutto. L’asservimento allo strumento sancisce il destino dell’umanità, che dissangua se stessa nel mattatoio che ha costruito, pur di vedere girare la giostra mortale delle lame. Questa carambola di coriandoli variopinti su un verso e neri al rovescio piovono addosso come un collage di frammenti ciascuno significativo in sé, ma anche parte essenziale del quadro d’insieme: se questo dramma umano ma non terrestre quanto a dimensione, tanto che Kraus stesso lo dice “concepito per un teatro di Marte” per significarsi non avesse scelto parole, avrebbe avuto la forma di un enorme e feroce collage di fotomontaggi alla John Heartfield, avanguardista militante braccato dai nazisti in mezzo mondo per la sua aggressiva opposizione al nazismo, operata attraverso le poliedriche forme del dadaismo e in alleanza artistica con personaggi del calibro di Grosz, Brecht, Dix; nel 1933 riuscì a sfuggire alle SS, allontanandosi da Berlino per rifugiarsi a Praga, per rientrare in Germania e stabilirsi nella DDR solo una volta finita la guerra, indigesto anche al nuovo regime, ma tollerato in virtù del suo passato antinazista.
Se Heartfield è l’avanguardista per eccellenza nel figurativo, in una Berlino dove inventa la tecnica del fotomontaggio e lo applica allo scopo di aggredire dell’aggressore, di frustare con caustica durezza l’ipocrisia della propaganda hitleriana, il Kraus de “Gli ultimi giorni dell’umanità” è l’avanguardia di qualsiasi avanguardia, in quel caleidoscopio di quadri e scene dall’effetto tridimensionale, quasi un libro animato che esplode figure informi e oscure ad ogni pagina, giullari, bestie e rumori di obici e combustioni, alternati all’assordante silenzio dello stucco di cui si rimane scoprendo il proprio volto ridente riflesso nella foto di una catastrofe.
Non c’è un solo istante di silenzio ne “Gli ultimi giorni dell’umanità”: le voci di tutti, fitte e vacue, riempiono ogni spazio, ogni riga del pentagramma, si sovrappongono e si accavallano, a briglia sciolta ma non fuori controllo: se un silenzio ci fu (e c’è, all’occorrenza) è proprio quello della censura, che lascia lenza a quel “cristallo di massa” come lo chiamò Canetti (“Massa e potere”, Rizzoli, 1972) che è il capannello, l’orrido collante degli individui sull’orlo del compiersi dell’Apocalissi, intenti a guardare in quel cerchio chi sia il prossimo a farsi cadavere: “Si sono formati capannelli. E non solo per essere presenti ad una delle più bestiali esecuzioni, ma anche per rimanerci; e tutti hanno fatto una faccia allegra”, allegra come quella dello stesso carnefice “ultimo, unico e vero baluardo del potere centrale”, sgomitando per vedere lo spettacolo, ma altrettanto per rimanere nella foto che ritrarrà la scena, in una sorta di enorme selfie finale col botto in cui comparire ad ogni costo.
E adesso tu che stai leggendo e hai avuto la pazienza di arrivare fin qui, rispondi: che senso ha parlare di questo libro, proprio oggi?
Karl Kraus
“Gli ultimi giorni dell’umanità”
Adelphi 2016
Jonathan Franzen
“Il progetto Kraus”
Einaudi 2014
Elias Canetti
“Massa e potere”
Rizzoli 1972
Nane Cantatore ha studiato filosofia alla Sapienza con una tesi su Hegel, dottorato su Husserl. Lavora nella comunicazione