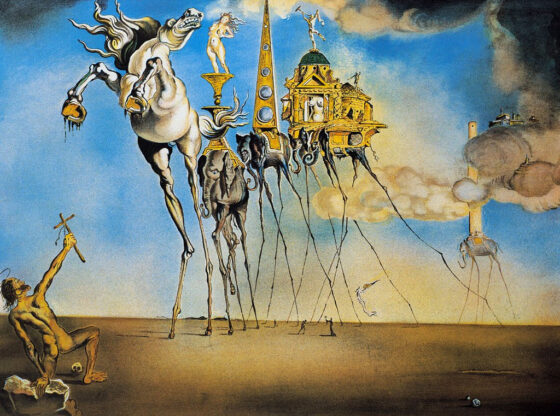Nel nome del padre
Di Teodoro Lorenzo
Il racconto è tratto dal libro di racconti sportivi Le formiche rosse
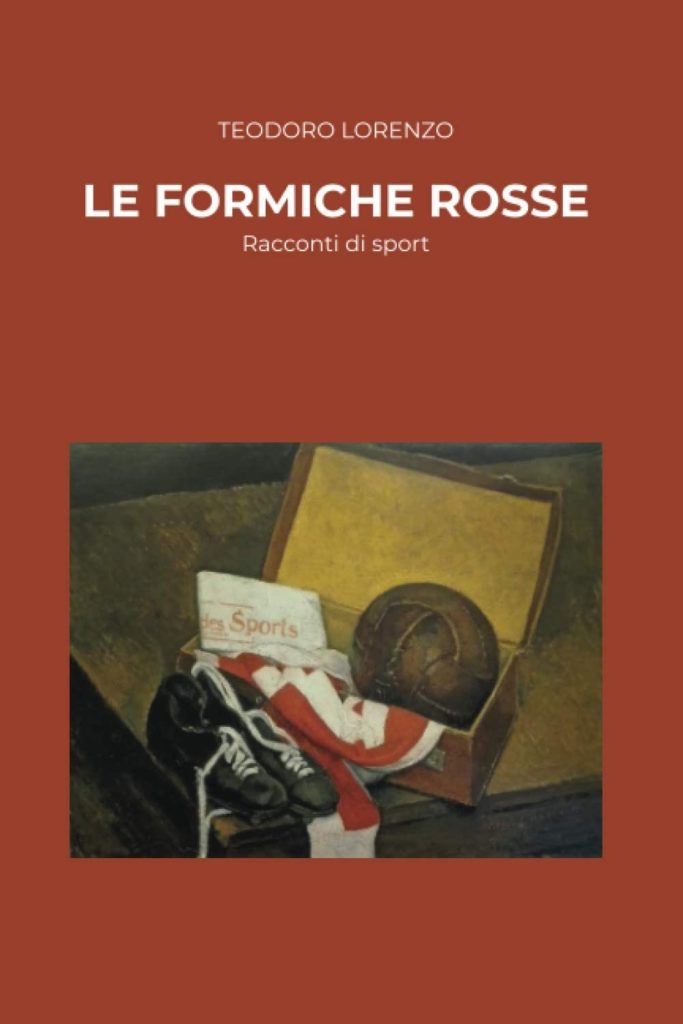
Mio padre è morto l’altroieri. Domani c’è la gara di Coppa Europa ed io non la correrò. Perché non correrò più, la mia carriera finisce qui.
È un giorno intero che sto chiuso qui dentro, nella mia camera d’albergo, a pensare a quello che è successo, a indagare sulla sua vita, e sulla mia.
L’allenatore e i compagni non mi cercano, mi lasciano solo. Rispettano il mio dolore ma loro non sanno che di dolore non ne provo affatto. Lo cerco, lo aspetto ma niente; non ho versato nemmeno una lacrima.
Non era più giovane ma non era malato; è successo tutto all’improvviso. Stava cucendo l’imbastitura di una giacca; lo immagino con la testa china, le gambe accavallate e il solito lungo centimetro giallo e blu pendergli dal collo come una cravatta slacciata. Poi è caduto a terra, la faccia in giù e le mani premute sul petto. Un infarto gli ha spaccato il cuore, come un terremoto che apre fenditure sulla terra e crepe sui muri. Così è successo a lui; una scossa gli ha tagliato il cuore lasciandogli lembi frastagliati, aperti per l’eternità.
Ho sempre pensato alla morte come una sveglia al contrario. Nessuno la vede ma tutti abbiamo un tempo biologico fissato dalla nascita, un tempo prestabilito che segue la nostra permanenza su questa terra, una sveglia interiore puntata sulla nostra ora.
Il Padreterno la carica al momento della nascita e poi la nasconde in qualche angolo dei nostri cromosomi.
Il primo respiro, il primo vagito; le lancette sono già partite. E poi corrono, corrono veloci e inesorabili, non si fermano, non si fermano mai fino a quando non raggiungono quell’ultimo istante fatale, per tutti diverso ma per tutti uguale. A quel punto suona la sveglia, che invece di destarti e affidarti al giorno che nasce, ti addormenta e ti consegna alla notte eterna.
Aveva imparato l’arte della sartoria da ragazzo, quando girava ancora con i pantaloni corti e i sandali ai piedi tra i rovi dell’Aspromonte, dove era nato.
San Roberto, provincia di Reggio Calabria; poche case, basse e calcinate, allineate lungo i bordi dell’unica strada asfaltata che lo attraversa, attaccate una all’altra come a darsi sostegno per non cadere: un negozio di alimentari, un bar senza insegna e il cimitero in cima alla salita. Come se la vita non fosse faticosa di suo e ai morti di San Roberto si richiedesse un sovrappiù di sudore per raggiungere l’ultima dimora e poter finalmente riposare.
Poi altre case, storte e ugualmente basse, sparpagliate alla rinfusa dietro la strada, in mezzo alla campagna, lungo tratturi stretti e terrosi, percorsi da asini sonnolenti.
Forse era il ricordo di questa immagine, di queste case bianche sparse fuori dal corto nastro d’asfalto, che di quando in quando, così, all’improvviso, impostando la voce come credeva dovessero fare gli attori di teatro, nel silenzio della casa lo sentivo erompere nella sua declamazione: “Addio monti sorgenti dalle acque, ed elevati al cielo, case biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti”. Faceva una pausa e cambiava tono sul “come branco di pecore pascenti”; scandiva bene le parole e le faceva morire in una sorta di eco divinatoria; I promessi sposi, l’addio di Renzo al suo paese.
Chissà attraverso quali imperscrutabili canali quei brandelli smozzicati di poesia erano arrivati fino a lui, che aveva fatto solo la quinta elementare.
Ma quelle frasi gli piacevano e lo rappresentavano. In fondo aveva sempre conservato l’anima dell’esule, di chi è stato costretto a fuggire dal suo paese da persecuzioni e miseria e porta sempre con sé il ricordo struggente del luogo natio.
È l’unica dolcezza che in tanti anni gli ho visto manifestare. Come tutti, anche lui, per ritrovare il sorriso dell’anima riandava con la mente alla luce dell’infanzia. Solo quel raggio di sole riusciva a farsi strada, con fatica, nell’ammasso di piombo dei suoi pensieri, sempre così cupi, densi, pesanti.
Quella declamazione estemporanea e solitaria era però la prova che anche lui aveva un’anima, anche se nascosta chissà dove, sepolta sotto strati di cenere come una Pompei dimenticata da secoli e invisibile.
Ma io la sua anima non l’ho mai vista, nessuno l’ha mai fatto.
Forse pensava che far vedere a chi stava fuori i riflessi di un’anima fosse una debolezza, una distrazione pericolosa nella guerra quotidiana contro la vita, un lusso che quelli come lui non si potevano concedere.
A San Roberto era d’obbligo andarci ogni anno; lo facevamo durante le vacanze estive.
Mio padre ritornava laggiù, alle radici del suo essere, per incontrare e rendere visita ai vivi e ai morti.
Era il suo pellegrinaggio e noi, la sua famiglia, gli facevamo da corteo.
Il primo tabernacolo davanti al quale inginocchiarsi doveva essere quello del sarto, sempre; era stato lui ad insegnargli l’arte e per lui provava quella riconoscenza affettuosa che si prova verso colui che ti ha concesso una grazia. In fondo la sua non era una visita ma un ex voto.
La casa del sarto si trovava al termine della strada asfaltata. Entravamo in paese e parcheggiavamo l’auto in quei pressi.
Era una sola stanza, male illuminata. Entravo in quell’antro e alla paura del buio si aggiungeva ogni volta lo sgomento alla vista di quell’uomo e della sua macchia rossa sulla faccia. Non avevo mai visto una cosa del genere. Quando gli occhi si abituavano all’oscurità rendendo più evidenti contorni e colori, la macchia appariva nella sua nitidezza.
Mi accorgevo allora che non era proprio rossa ma piuttosto violacea, con i bordi frastagliati, ed occupava quasi interamente la guancia sinistra. Mi sembrava la carta geografica di un qualche pianeta sconosciuto.
Realizzai molto tempo dopo, da adulto, che si trattava di una voglia di vino; il che se assolveva l’uomo condannava la donna, sua madre, che impudicamente aveva pensato al godimento del vino durante la gestazione. In questo modo un segreto inconfessabile, il desiderio del bere, stampato sulla faccia del figlio, diventava di pubblico dominio. E la esponeva al generale ludibrio, rendendo inversamente vero il principio secondo il quale le colpe dei genitori non devono mai ricadere sui figli. Il sarto di San Roberto con la faccia deturpata ha al contrario pagato per tutta la vita la colpa di sua madre.
Il discepolo tornava dalla grande città e come per il ritorno del figliol prodigo bisognava fare festa. Il sarto tirava fuori la tovaglia di pizzo e i bicchieri di cristallo, che sistemava sopra il tavolo insieme al latte di mandorla. Io comunque non riuscivo a distogliere lo sguardo dalla macchia ma lo facevo di sottecchi, preso dal timore di essere sorpreso dal sarto con chissà quali orribili conseguenze. Tremavo all’idea che potesse entrare di notte nella mia stanza, mentre dormivo, e trascinarmi con lui sul pianeta delle facce rosse.
Il resto della visita ai vivi si svolgeva frettolosamente. Si tornava indietro, a piedi, sino all’inizio della strada asfaltata e da lì si cominciava; ogni casa una sosta, ogni casa una visita.
Ma si capiva che si trattava di soste senza importanza; erano tappe d’obbligo, stazioni prefissate ma senza raccoglimento. Lo si faceva solo per evitare di dare pretesti alle maldicenze: che non si dicesse che Giuseppe Labate, gran maleducato, tornato in paese non aveva fatto visita a tizio caio e sempronio. Ma il tabernacolo del santo era già stato omaggiato e l’ex voto consegnato; gli altri personaggi facevano da contorno, erano meri comprimari della processione.
Il paese si era svuotato dei giovani, partiti in ogni direzione alla ricerca del loro destino. Erano rimasti solo gli anziani, tutti più o meno legati da vincoli di sangue; padrini, madrine, lontani cugini, vecchie zie. Mio padre conosceva tutti e tutti conoscevano lui.
Le case erano tutte uguali, buie come quella del sarto. Credenze di legno, sopra cui poggiavano scolorite foto in bianco e nero: gli uomini in divisa da soldato e le donne con la veletta della sposa. Davanti alle cornici porcellane di Capodimonte riproducenti pastori e contadini e sulle pareti un quadro con il cuore di Gesù.
I bicchieri di vetro del pasto quotidiano, non il cristallo delle grandi occasioni, erano già pronti sulla tavola; l’arrivo della famiglia Labate aveva già fatto il giro del paese. Labate chi? Giuseppe, il figlioccio del sarto, quello che è salito a Torino. Due baci di saluto, due baci di commiato, in mezzo il latte di mandorla e via, alla stazione successiva. Così per tutte le case dei vivi prima di affrontare la salita ed entrare nelle case dei morti.
Lì riposavano sua madre e suo padre, i miei nonni paterni, in tombe vicine, sottoterra.
Mio nonno era piccolo, talmente piccolo che seduto sulla sedia, non arrivava a toccare con gli scarponi per terra. E questa è l’unica cosa che ricordo di lui.
Un soffio di uomo, così leggero e sottile che doveva faticare a mettere uno davanti all’altro, per camminare, quegli enormi scarponi da contadino che non si toglieva mai.
Come un omino di quella fatta abbia potuto accoppiarsi ad un donnone come mia nonna si spiega solo con gli accordi che era uso prendere tra cerchie familiari per combinare matrimoni.
Mia nonna l’ho vista sempre vestita di nero, con i capelli raccolti in una crocchia. Non l’ho mai vista sorridere.
Stare con quella donna così rigida e spettrale gli avrà sicuramente reso più greve il vivere quotidiano che la provvidenza gli aveva già complicato ritagliandogli addosso quel fisichino inadeguato.
Troppa fatica per un uomo, insopportabile per lui; se era un soffio meglio tornare nel suo elemento e cioè le nuvole. Morì giovane.
Mia nonna trovò una ragione in più per giustificare i suoi vestiti neri e per continuare a non sorridere; andò avanti così per parecchi anni ancora.
L’ultima sosta si faceva davanti alla casa di Domenico Azzarà 1924-1939.
Un ciuffo di capelli neri riempie la foto smaltata, attaccata alla pietra. Era un amico di mio padre, quando ancora facevano correre sulla strada la camera d’aria delle biciclette, costruivano capanne di canne e si arrampicavano sugli alberi a mangiare fichi verdi, gonfi e succosi con la goccia di latte che colava dalla buccia e rigava il mento.
Una settimana di febbre. Nessun dottore ci ha capito niente e Domenico se ne è andato, salendo anche lui la salita del cimitero. Con la grazia di una farfalla.
Anche mio padre a quel tempo era una farfalla.
La trasformazione, io credo, cominciò ad avvenire sul treno che l’avrebbe portato a Torino. Aveva appena diciannove anni.
Di Torino ne aveva solo sentito parlare. C’erano fabbriche, un lavoro, un futuro. Doveva andare, doveva muoversi. Mise nella valigia due stracci e due soldi, e partì.
Fin dal momento in cui pose il piede sulla predella del treno, a Reggio, cominciò a perdere la leggerezza e i colori della farfalla.
L’involuzione biologica aveva preso il suo avvio. Ci vollero anni ma quando nacqui io il terribile percorso a ritroso era giunto al suo compimento. Da farfalla mio padre era prima regrediti a crisalide e poi in bozzolo: chiuso, ostico, impenetrabile.
Sigillato dentro se stesso non vedeva e non sentiva più nulla. Il mondo terminava al di là della sua larva. Speranza, ottimismo, progetti, affetti; tutto era stato divorato. Dentro quel bozzolo non c’era posto per nessuno; non c’era posto per sua moglie, non c’era posto nemmeno per i suoi figli. Era uno spazio troppo angusto per contenere qualcuno o qualcosa che non fosse lui stesso. E troppo buio per far entrare la luce; se non ogni tanto attraverso la miracolosa declamazione di quei versi manzoniani.
Ancora oggi non so se questa involuzione fosse già inscritta nei suoi cromosomi e quindi abbia rappresentato null’altro che il biologico sviluppo di caratteri ereditari oppure sia stata la naturale conseguenza di circostanze esterne, una estrema difesa nei confronti delle aggressioni della vita.
Se penso a sua madre, mia nonna, alla sua rigidezza quaresimale, alle sue labbra perennemente incollate direi che la prima ipotesi può trovare una sua logica.
È pero certo che Torino ci ha messo parecchio del suo.
Ai tempi in cui ci arrivò mio padre, alla fine degli anni cinquanta del secolo passato, Torino era una città spietata.
Dietro lo schermo apparente dell’eleganza dei suoi palazzi, delle sue piazze, dei suoi cortili, dietro la gentile geometria dei suoi viali alberati nascondeva la lama che faceva a brandelli la tua carne. Nello scorrere poetico del suo fiume, nella dolcezza delle sue colline si nascondeva l’infezione letale pronta a divorare il tuo organismo.
La realtà era fatta di un freddo glaciale, climatico e sociale, che ti entrava nelle ossa e nell’anima.
Il freddo era una presenza costante, ti accompagnava dovunque. Il sole era un ricordo di altre ere, a volte la nebbia era così fitta che si confondevano le strade, si sbagliavano gli incroci. La pioggia durava giorni, non smetteva mai, e quando nevicava, la neve ghiacciava subito e veniva accumulata ai bordi delle strade dove rimaneva per mesi. Coprirsi non bastava, rintanarsi in casa non serviva, ammesso di avercela, una casa. Mio padre una casa non ce l’aveva, aveva una soffitta; senza riscaldamento, senza acqua calda, il cesso fuori, sul ballatoio.
Il buio arrivava in fretta, Come una tagliola, all’improvviso scendeva a tagliare il giorno, spegneva ogni luce. E si rimaneva soli, soli con i propri pensieri, pensieri senza luce.
Torino non era una città che accoglieva, era una città che respingeva. Non c’era calore, da nessuna parte.
I meridionali erano odiati: i mandarini, così chiamati da quelli che volevano scherzare oppure i terun, se di scherzare non ne avevano voglia, erano tutti mafiosi, neri e puzzolenti. Non si affittano case ai meridionali si leggeva sui cartelli dei palazzi.
Difficile fare amicizia: c’era solo il lavoro. E dopo il lavoro, il buio, il freddo, la stanchezza; non c’era spazio per altro.
Come bestie abbrutite ci si rifugiava in case che erano tane.
In queste condizioni forse chiunque si sarebbe barricato dentro se stesso. Come si poteva rimanere farfalla, bella di colori e di sentimenti, in quella miseria buia e ghiacciata.
Era necessario diventare bozzolo se si voleva sopravvivere, semplicemente sopravvivere. Chiudersi in se stessi per non disperdere nemmeno un’oncia di calore e di energia vitale. Rinchiudersi dentro un involucro per lasciarsi scivolare addosso le cattiverie quotidiane, le delusioni, le sconfitte; mandarino, terun, torna al tuo paese. Pensare solo a sé e lasciare il mondo al di fuori della propria minuscola circonferenza. Lavorare e basta. Caricarsi la mattina il proprio basto, abbassare la testa e cominciare la salita come facevano i morti di San Roberto, perché in fondo anche lui era un morto. Non guardarsi intorno, non pensare ad altro che a se stessi. Guardare il mondo, emozionarsi, perfino amare erano lussi che i morti non potevano permettersi perchè richiedevano energie di cui non disponevano. Mio padre ne aveva a malapena per tirare avanti fino al buio improvviso della sera.
Il mondo intanto cambiava rapidamente. Ad un certo punto fu costretto ad accorgersene anche lui e fu quando non ebbe più clienti.
Era cominciata l’era della produzione industriale. I vestiti non si facevano più uno alla volta ma si producevano in serie e li vendevano i negozi. Era finita l’epoca dei sarti. Un grande e nobile lavoro, fatto di attenta sapienza artigianale, era sparito. Come tanti altri, soppiantati dal boom industriale che aveva investito l’Italia di quegli anni. Prima si vendeva il ghiaccio, ora non aveva più senso: il ghiaccio era bell’e che pronto in casa, dentro il frigorifero. Si lavavano i panni sul greto del Po ma anche le lavandaie ormai non servivano più: era arrivata la lavatrice. Si riparavano biciclette, uomini e cose si spostavano con i carri ma già le strade cominciavano a brulicare di automobili.
Così i vestiti. Non c’era più bisogno del sarto. Perché farsi fare un vestito su misura quando si poteva entrare in un negozio: si entrava, si provava, si pagava.
Bisognava cambiare strada, ed in fretta. Tra i clienti che gli erano rimasti vi era un politico locale, in piena corsa per il salto verso la capitale e la politica nazionale. Mio padre gli parlò delle sue ambasce, lui gli trovò una occupazione alle Poste.
Ma i negozi comunque avevano bisogno di sarti, non più per la confezione dei vestiti ma per le riparazioni e gli accomodamenti; accorciare o allungare le maniche della giacca, accorciare o allungare le gambe dei pantaloni. Oppure rifare il fondo o spostare bottoni per accontentare i pochi dandy rimasti. Le misure standard delle fabbriche non tengono conto delle imperfezioni che dissemina la natura sui corpi umani; una spalla un po’ più alta, un braccio un po’ più lungo, una gamba un po’ più corta. Ed anche nel grigio di Torino rimaneva pur sempre un eccentrico che, anche nel vestire, si voleva distinguere.
Mio padre trovò un negozio di abbigliamento vicino a casa per il quale lavorare al termine delle sue ore di smistamento pacchi.
Ora i soldi entravano con frequenza sicura e garantivano non solo il pane ma anche un po’ di companatico.
Si cambiò casa; una casa con l’acqua calda, i termosifoni, un bagno interno, una vasca. Lussi che non si era mai potuto sognare.
La casa si trovava in una zona nuova, che presto venne inglobata dalla crescita impetuosa della città. Oggi viene considerata una zona semicentrale e di pregio, molto ambita da coloro che cercano una nuova abitazione.
All’epoca invece si vedevano solo cantieri edili e vaste praterie di campi, dove passavano mucche in transumanza.
Giunto a quel punto della sua vita, mio padre avrebbe potuto finalmente tirare il fiato, lasciar passare un po’ di luce nel suo bozzolo nero, far entrare un po’ di speranza nel futuro e di ottimismo. Accogliere un po’ di calore, disperdere nell’aria i suoi soliti pensieri truci, lasciare evaporare un po’ del suo pessimismo. Liberarsi di qualche paura e prestare un po’ di attenzione a ciò che gli girava intorno, dare un po’ di affetto alla sua famiglia. Sarebbe bastato solo un po’ di tutto questo per renderci una famiglia normale e un po’ felice. Solo un po’. Ci sarebbe bastato.
In fondo poteva dire di avercela fatta. La miseria era un ricordo, erano finite le ristrettezze economiche, i soldi non erano tanti ma erano sicuri. Era riuscito a comprarsi una casa nuova, con un mutuo da pagare, d’accordo, ma pur sempre una casa e non una tana.
Perfino Torino sembrava più sorridente, le giornate sembravano miracolosamente essersi allungate, la nebbia gelatinosa sparita e la neve, quando cadeva, si scioglieva quasi subito al contatto dell’asfalto. Sembrava non facesse più così freddo e di mandarini e di terun non se ne sentiva più parlare, almeno non così spesso e non più con la stessa acredine.
Eppure per mio padre non cambiò nulla.
Lo sentivo alzarsi presto la mattina, scatarrare in bagno e ciabattare per qualche minuto in cucina. Poi la porta si chiudeva alle sue spalle. Ricompariva la sera, più o meno per l’ora di cena, dopo i pacchi e gli orli. Tuffava affamato la testa nel piatto e non la rialzava fino a che non aveva finito. Poi si alzava e andava in salotto per un’ora di televisione, sprofondato in poltrona.
Sempre in silenzio. Continuava a nutrire il suo bozzolo, continuava a stare lì dentro, pago soltanto delle sue soddisfazioni primordiali: mangiare respirare dormire evacuare.
Non si preoccupava di come stava la moglie, che pure aveva lasciato in Calabria genitori affetti e ricordi per venire a vivere in posti alieni.
Non si preoccupava dei figli: se andassero bene o no a scuola o come trascorressero i loro pomeriggi.
Fatti i compiti in fretta e furia, uscivo da casa, con qualsiasi tempo, e stavo fuori fino a sera. Sono cresciuto come le erbe della prateria che mi circondava. Potevo diventare un fiore colorato oppure un’erba velenosa, secondo la casualità della natura. Non ho mai avuto una guida, né una direzione. Non ho conosciuto la mano paterna, salda nella mia, a darmi conforto e sicurezza.
Nel buio del suo bozzolo ogni pensiero continuava a colorarsi di nero. Lo spettro della miseria aleggiava di continuo nella sua testa; la paura si era impadronita per sempre di lui. Ogni cambiamento non poteva che ridurci sul lastrico. Per lui nessuna iniziativa poteva portare qualcosa di buono, tutto prima o poi sarebbe finito male.
Il bozzolo non si apriva nemmeno nelle feste comandate, nemmeno a Natale, quando ogni famiglia si raccoglie in serenità.
Un pomeriggio, uscito come sempre molto presto da casa, invece di fermarmi ad aspettare i miei amici cominciai a correre, a correre, a correre. Presi una strada a caso e ricordo questa precisa sensazione: non mi sarei più voluto fermare.
Oggi capisco che non stavo correndo: stavo scappando.
Un grumo denso mi si era rappreso nell’anima. In esso tutto si mescolava senza che riuscissi a darne un ordine. Era rabbia sorda per quello che poteva essere e non era stato: una vita serena, con quel poco che ci potevamo permettere. Era invidia per le famiglie normali, una normalità che non era la nostra. Era paura di me stesso, delle mie reazioni, del mio futuro. Era il mio senso di colpa, un veleno che era diventato parte di me e che dovevo eliminare con il sudore, per evitare che si impadronisse della mia anima.
A volte pensavo che forse era colpa mia se mio padre non si interessava a me, se non mi teneva per mano. Dovevo impegnarmi di più. Ma cosa potevo fare di più.
Sono sempre stato il secondo migliore della classe. Mai il primo, e solo perché non mi andava. Mi sapeva troppo di secchione, di occhiali spessi e di scodinzolamenti vicino al maestro o al professore. Io mi sono sempre seduto all’ultimo banco, coltivando una sorda diffidenza verso ogni forma di potere e una sotterranea ribellione verso ogni regola imposta, vivendo la mia innocua anarchia, orgoglioso del mio essere contro quella ripugnante piaggeria.
Dopo l’esame di quinta elementare, nel salutarci, la maestra Marietti mi chiese di regalarle i miei due quaderni, quello di italiano con la copertina azzurra e quello di aritmetica con la copertina rossa. Erano talmente ben fatti, mi disse, che le sarebbero serviti per istruire le sue classi negli anni a venire. Andai a casa e tornai in un baleno. Le consegnai i quaderni, non tolsi nemmeno le copertine. No, non ero diventato una pianta velenosa.
All’esame di terza media presi ottimo, il massimo dei voti. Adatto ad ogni tipo di scuola fu la valutazione finale. Feci anche l’esame di latino, che era facoltativo. Presi ottimo anche in quello.
Mi iscrissi al Liceo Scientifico. Per i primi tre anni presi la borsa di studio che il benemerito Ministero delle Poste e Telegrafi elargiva agli studenti più meritevoli, figli dei loro dipendenti. Poi non più. Ma non perché fossi diventato meno bravo; è che il Ministero non aveva più stanziato i fondi e le borse di studio erano finite. Anche qui mi dovetti rassegnare all’amara conclusione: mio padre non si interessava della scuola ma i soldi delle mie borse di studio, quelli se li intascava.
Non so quando misi termine alla corsa, quel pomeriggio.
So solo che ci tornai anche l’indomani e l’indomani e l’indomani ancora. Mi accorsi che mi faceva stare bene. Macinavo chilometri, sempre di più ogni giorno e il grumo denso sembrava sciogliersi e diluirsi nel mio corpo, trascinato dal mio stesso sangue. Alla fine della corsa, al termine della giornata, mi sentivo più leggero, quasi pacificato. Dico quasi perché rimaneva sempre dentro di me il nucleo incandescente di quel grumo. Quello che bruciava di più, che non si spegneva mai e alimentava tutto il resto. Ne potevo quasi sentire la consistenza, seguirne la circonferenza, proprio lì, in mezzo al petto. Non riuscivo a decifrarlo, cercavo di arrivare alla sua origine, di coglierne l’essenza; lo interrogavo, lo studiavo ma continuava a sfuggirmi. Eppure sentivo che lì dentro, in quel nucleo, erano nascoste tutte le risposte, quelle necessarie se desideravo continuare a vivere.
Alle gare non ci pensavo affatto.
La colpa fu di Pasini, il professore di ginnastica. Lui era un fissato della corsa e delle competizioni.
Aveva avuto un passato mediocre come atleta e del resto quella punta di poliomielite che l’aveva toccato nell’infanzia come una bacchetta malefica lasciandogli una gamba impercettibilmente più sottile e una leggerissima zoppìa, avevano messo il sigillo nero su ogni sua ambizione.
Della gamba più sottile nessuno se ne accorgeva e la zoppìa, nella vita di tutti i giorni, gli conferiva un leggerissimo beccheggio che produceva nell’andatura perfino un che di elegante. Ma nello sport, durante le gare, quei problemi emergevano in tutta lo loro spietatezza e lo obbligavano ad una fatica supplementare che pagava sempre nei finali, confinando il suo destino di corridore in quello di un onesto comprimario e nulla più.
Pasini, col beneplacito del preside, aveva organizzato una corsa campestre a ridosso delle vacanze di Pasqua, aperta a tutti gli studenti maschi della scuola.
Arrivai da solo al traguardo, staccando il secondo di venti minuti e con un tempo da record. Pasinipensò che si fosse rotto il cronometro.
Da quel giorno non ebbi più pace. Mi fermava nei corridoi, mi aspettava davanti all’ingresso della scuola, all’inizio e al termine delle lezioni. Era diventata la sua fissazione: dovevo assolutamente iscrivermi alla Sisport Fiat, diventare un vero atleta, allenarmi con metodo e impegno, naturalmente sotto la sua lungimirante supervisione.
La corsa campestre gli aveva rivelato un talento, un diamante prezioso e lucentissimo ma ancora grezzo; impurità e imperfezioni che sotto la sua guida sarebbero sparite dando all’Italia la possibilità di ammirare un gioiello del fondo. Era da anni, diceva, che la nazione sportiva non scopriva un talento nelle gare lunghe, fin dai tempi di Alberto Cova.
Io non sapevo nemmeno chi fosse Alberto Cova, ed anche sul resto lo seguivo poco, zoppicando come lui. Della Sisport sapevo vagamente qualcosa; era il gruppo sportivo della Fiat, e la cosa mi lasciava abbastanza indifferente; in fondo a Torino tutto in quegli anni apparteneva alla Fiat. Quello che mi impediva di accontentare Pasini era piuttosto questo: di correre ne avevo bisogno per la mia salute psichica, per tenere a bada quel grumo di sofferenza ma di gare e confronti non sapevo che farmene; vincere o perdere non me ne fregava nulla.
Pasinitanto stressò anche il Preside che riuscì a farsi dare il numero telefonico di casa, così da poter continuare la sera il bombardamento che mi faceva subire di giorno.
A quel punto cedetti, per sfinimento.
Pasini, euforico, mi iscrisse subito al Meeting Giovanile della Valsugana, a Trento: 5.000 e 10.000 metri. Vinsi entrambe le gare.
Pasini gongolava. Era talmente felice e soddisfatto (di sé) che sembrava camminare su un cuscinetto d’aria. Non zoppicava nemmeno più, o almeno così mi sembrava.
Si prendeva tutti i meriti, come scopritore del talento e come allenatore dell’atleta. Io lo lasciavo fare, per quel che mi importava…
Secondo lui era riuscito a migliorare la gestione della gara e aumentato la mia velocità di base.
In verità il povero Pasini non lo stavo nemmeno a sentire, anzi facevo volutamente il contrario di quello che mi suggeriva di fare. Lui per me era pur sempre il potere, qualcuno che voleva impormi regole e comportamenti ed io, secondo la mia natura, intimamente mi ribellavo.
Pasini mi diceva, durante gli allenamenti, di mantenere l’intensità dello sforzo ad un livello più basso rispetto alla gara e di moderare la velocità quando si cominciava ad avvertire la fatica. Io invece la fatica la cercavo, la imploravo come grazia divina e quando arrivava la ringraziavo come si fa con una buona amica, e a quel punto raddoppiavo il mio sforzo. Da quel momento in poi, mentre per gli altri la gara finiva, per me iniziava.
Per farla arrivare prima mi appesantivo volutamente, Pasini non l’ha mai saputo. Agli allenamenti mi presentavo ogni volta con due chili in più addosso. Due cavigliere chiuse strettamente con il velcro, che nascondevo sotto la tuta e i calzettoni. Tolte quelle, nelle gare volavo come il dio Mercurio.
Quando mio padre venne a sapere dei miei allenamenti e delle mie gare disse solo questo, prima di alzarsi da tavola e andare in salotto per la sua solita ora di televisione: “Se avevi ancora energie da spendere dopo la scuola e i compiti potevi trovarti un lavoro”.
Non ascoltavo quello che mi diceva Pasini neanche durante le gare.
La sua strategia abituale era quella di moderare l’andatura, rimanere incollato ai primi per tutta la gara e scattare solo all’ultima curva.Io invece scattavo in testa allo sparo dello starter. Per me non esistevano avversari, non mi guardavo attorno. Mettevo la testa bassa e cominciavo a mulinare le gambe. Del resto io non ho mai corso contro gli altri, io ho sempre corso sempre e solo contro me stesso. Piegavo la testa, macinavo chilometri e aspettavo la fatica. A quel punto strappavo. Sentivo il dolore invadermi il corpo, e strappavo. Ciondolavo la testa, cercavo aria con la bocca, e strappavo. Annaspavo con le braccia spingendole in avanti, e strappavo ancora.
A quel punto si faceva il vuoto. Non c’era più nessuno dietro di me e niente dentro di me, se non quel nucleo incandescente, che continuava a bruciare e dove, come in una centrale nucleare, avveniva la fissione di tutte le mie infelicità. Era da lì, me ne rendevo conto io stesso, che nasceva quella spaventosa energia che dava forza alle mie gambe.
Quando fui convocato in nazionale mio padre aggiunse questo al suo primo commento, sempre dopo aver finito di mangiare: “Se volevi continuare a perdere tempo con lo sport invece di trovarti un lavoro potevi almeno scegliere il calcio”
Ma ormai tutto appartiene al passato, lui è morto. Ed io sono qui a fare confusamente i conti con quel passato e ad immaginarmi un futuro.
Ho trovato comunque le risposte che cercavo. Sono riuscito ad affondare la mano dentro il mio petto e ad estrarre quel nucleo incandescente.
L’ho preso con due dita e l’ho osservato da vicino. Avevo paura di ustionarmi la pelle ma mi sono accorto che sollevato in aria e tenuto lontano non bruciava più. Senza il mio sangue a irrorarlo di dolore era diventata una minuscola pietra grigiastra.
L’ho guardata in controluce davanti alla finestra e ho capito, ho capito cos’era a darmi tutta quella potenza, a spingermi verso la vittoria, a costringermi a tagliare per primo la linea del traguardo: era la speranza.
In quella profondità, nei precordi del mio essere si nascondeva quello che ho desiderato per una vita intera. Ed era una sola cosa: che una volta, almeno una volta nella vita mio padre, tenendomi per mano, mi dicesse: “Bravo”
Non l’ha mai fatto, non potrà più farlo. Ed io l’ho sperato, sempre, in ogni momento. E l’ho pure sognato; mio padre ad aspettarmi dopo la linea del traguardo, sorridente, a braccia aperte, e orgoglioso di me.
Ho acquisito chiara la consapevolezza che in realtà io non correvo per la vittoria, non mi interessava la gloria sportiva, non volevo soldi né premi, complimenti o articoli di giornale: correvo per una sola parola e che quella parola fosse mio padre a dirmela.Adesso continuare a correre sarebbe inutile perchè ho perso per sempre il mio premio.
Non ho più stimoli né motivazioni. E comunque non ne avrei più nemmeno la forza; il nucleo incandescente, adesso che l’ho estratto dal petto, non brucia più; è finita l’energia, la centrale nucleare si è spenta.
Sento all’improvviso le lacrime salirmi agli occhi e mi invade una pena infinita; pena per me, per noi. Pena per lui.
Ha vissuto lavorando come una bestia, arrampicandosi a mani nude sulla vita; come una bestia è morto, lavorando, con addosso il peso del suo basto.
No, non era un angelo mio padre. Ma era mio padre.