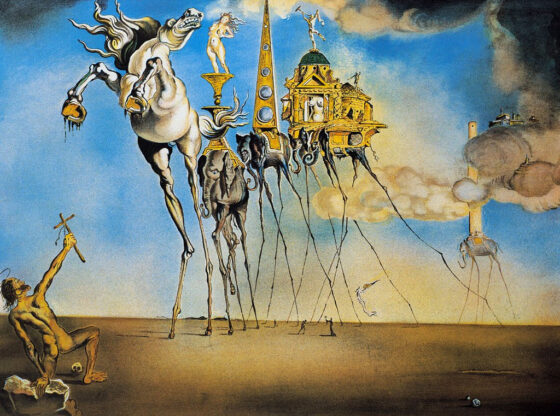UN RING IN PARADISO
Di Teodoro Lorenzo
Racconto tratto dal libro Le formiche rosse. Racconti di sport
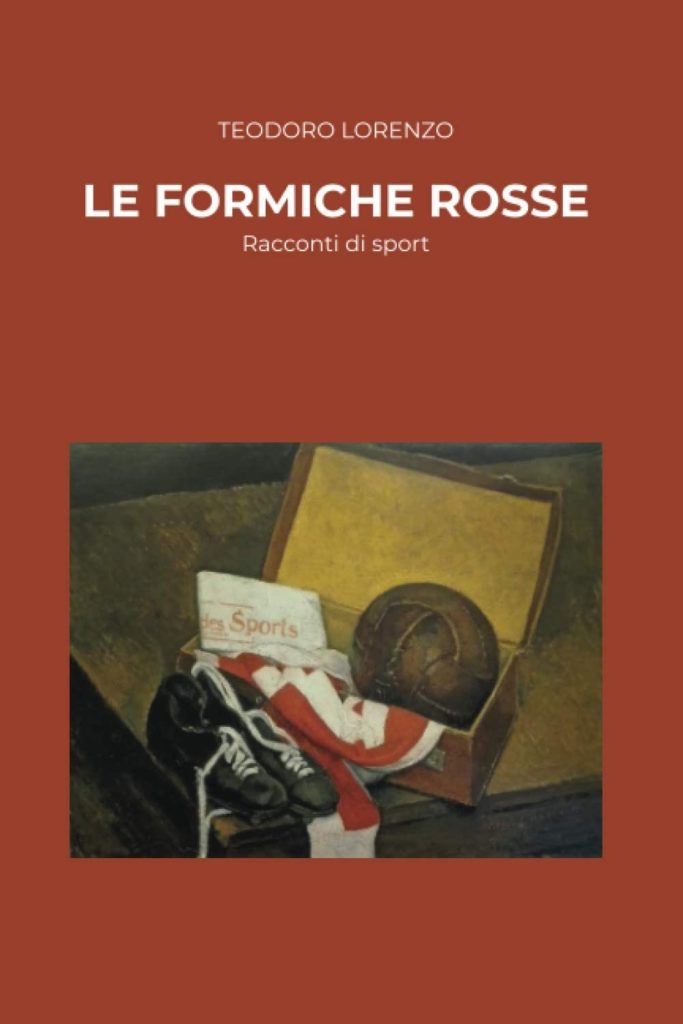
Continuano a ripetermi che sono vecchio, vecchio e malato, e che un uomo nelle mie condizioni dovrebbe riguardarsi e conservare con ingordigia nelle vene più profonde del suo corpo le ultime preziose stille di vita invece di spargerle così miseramente all’intorno.
La mattina me lo dice Adelina, la mia vicina di casa, quando mi incontra sul pianerottolo in attesa dell’ascensore e si accorge della sigaretta che pende dalle mie labbra: “Mi raccomando signor Bastiani…la salute…la salute innanzi tutto. E la smetta di fumare!”
La sera me lo sento strillare alle spalle da Michele, il portinaio, dopo che mi ha visto passare lentamente davanti al suo bugigattolo: “Achille attento che stasera l’aria è fredda. E non andare al bar, un atleta non deve bere”
Un atleta, dice, ed io soffoco dentro il bavero del cappotto un sorriso malinconico.
Ha la mia stessa età ed è uno dei pochi che ricorda chi sono stato. Tutti mi vogliono bene, anzi sembra che facciano a gara a chi me ne vuole di più: la vicina di casa, il portinaio, gli amici del bar Cavour, i ragazzi della palestra.
Mi trovano simpatico, dicono. In realtà è solo la pena che suscita osservare lo scempio che la malattia e la vecchiaia hanno provocato nel mio corpo un tempo perfetto come un bronzo di Donatello ad infondere in loro questi commendevoli sentimenti di affetto. Poi sanno che sono solo e ciò aggiunge altra compassione.
Sono stato sposato dieci anni con Giulia. Dieci anni che sono stati un unico, lungo istante di felicità. Poi un giorno, all’improvviso, se ne è andata. Dopo dieci anni. Si era innamorata di un altro; l’aveva conosciuto nel laboratorio di analisi dove lavorava. Succede, mi disse, e nient’altro. Neanche un “mi dispiace” e forse è stato meglio così. L’ipocrisia non l’avrei tollerata. Meglio un pugno in faccia, così, diretto, che ti spacca il naso e fa finire l’incontro, tutti a casa e buona notte piuttosto che una lunga sequela di colpi ai fianchi che ti fiaccano un po’ alla volta e ti mortificano fino all’ultimo gong.
Del dottore neo assunto Giulia una sera, a tavola, mi aveva decantato la gentilezza dei modi. Ed io quella sera non l’avevo nemmeno ascoltata, eppure avrei dovuto farlo, perché quelle parole erano i rintocchi di una campana che suonava a morto. Ed il morto ero io.
Col tempo mi sono convinto che se anche le avessi prestato attenzione non sarebbe cambiato nulla. Il motore ormai si era acceso e non si sarebbe più fermato. Perché l’amore è una macchina che parte piano ma poi accelera e arriva in fretta alla massima velocità. A quel punto non c’è più nulla che possa fermarla,travolge ogni cosa e le difficoltà invece di bloccarla la alimentano.
Così era successo anche a noi quando i genitori di Giulia avevano tentato in tutti i modi di opporsi alla nostra unione. Che la figlia dei Ramella, ricca famiglia di commercianti, un avviatissimo negozio di tessuti in piazza Unità d’Italia, potesse frequentare un pugile, per giunta spiantato e senza futuro, era al di là di ogni umana comprensione.
Ma anche quella volta la macchina era partita e non si fermò.
Certo, il dottorino aveva modi fini e usava parole eleganti, indossava il camice bianco e quando terminava il suo lavoro profumava ancora di lavanda e non aveva un capello fuori posto.
Io ero un pugile, non sono andato a scuola e conosco poche parole, solo quelle che mi servono per comunicare le cose che penso e quelle che sento, non le altre, e sono tante, utili per rubare la fiducia della gente; i miei modi sono franchi e diretti, e a qualcuno possono sembrare rozzi; il mio pane lo guadagnavo soffrendo sul ring e piangendo da solo nello spogliatoio per tutti i colpi che avevo preso e cominciavano a far male. Al termine del mio lavoro non profumavo di lavanda ma puzzavo, di sudore e di paura, la mia e quella dell’avversario, mischiate assieme; perché anche la paura puzza, la paura fa lavorare le ghiandole. E quando finivo erano fuori posto non solo i capelli ma la faccia intera, tanto era storta e tumefatta; ci volevano giorni perché si riquadrasse e riprendesse forme umane.
Forse le avrei risposto così, se lei mi avesse detto qualcosa; ma non disse nulla. Così rimasi solo con il mio dolore e con in testa il curioso pensiero di come una persona possa essere attratta a distanza di tempo, ma a volte nello stesso tempo, da persone così diverse. Come ci si possa innamorare di un angelo e poi, o anche, di un diavolo; e nel mio caso concediamo pure che il diavolo fossi io.
Il dolore non è mai passato, il curioso pensiero è invece sparito in fretta dalla mia testa, archiviato senza seguito insieme alle tante altre cose della vita che non ho mai capito e che a questo punto non ho più tempo per capire.
Forse un figlio avrebbe reso più lieve il dolore di quella separazione, ma pur desiderandolo, nei nostri anni di amore non riuscimmo a concepirlo e così quando Giulia se ne andò io mi sentii come un tronco tagliato, senza rami e senza foglie: un mezzo uomo, monco d’amore.
Ma ora basta, mi sono dilungato abbastanza e poi…adesso che ci penso…non mi sono neanche presentato.
Eccomi qua dunque. Achille Bastiani, anni 29 – chilogrammi 67,300 – altezza 1,73- categoria superwelter – guardia sinistra – 59 incontri, 50 vinti 6 pareggiati 3 persi.
Ecco…vedete… ho scantonato di nuovo… vi ho riportato il mio tabellino di pugile. No, non è un’antica deformazione professionale; piuttosto ho l’impressione che il mio cervello non mi abbia voluto seguire e sia rimasto per sempre laggiù, ai miei anni felici con Giulia. O forse è la malattia che mi ricorda ogni giorno che le appartengo. Sta di fatto che di anni oggi ne ho sessantacinque e del pugile che sono stato mi sono rimasti solo i ricordi. Rispetto a quel tempo sono aumentati anni e solitudine. Solo il peso è diminuito, rendendomi più simile ad un insetto che ad un uomo. Un ragnetto solitario la cui misera tela si è ridotta a due esilissimi fili che lo uniscono al bar e alla palestra.
Su entrambi corre la mia memoria ma in direzioni opposte; sul filo che porta al bar, e alla mia vita con Giulia, mi inoltro per dimenticare tutto, e per questo mi aiuto con l’alcol, è vero, non posso negarlo; Michele lo sa, per questo mi ammonisce ogni sera, ma ho già sofferto abbastanza e dimenticare è l’unico modo per smettere di soffrire. Su quello che porta alla palestra, e alla mia vita da pugile, mi incammino perché voglio invece ricordare ogni momento, e trattenere dentro di me ogni dettaglio.
È solo una piccola palestra, ricavata da un vecchio garage alla periferia di Rieti. I muri macchiati di nafta ne ricordano la vecchia destinazione, negli angoli ristagna ancora l’odore di olio e di benzina. Gli hanno dato un nome moderno e altisonante, Alma Sporting Club, come se il nuovo nome potesse far dimenticare le sue origini plebee.
Ci vado ogni pomeriggio con l’autobus. Arrivo e mi sistemo contro la parete di fondo, per non dare fastidio. Una solitaria sedia impagliata mi aspetta, nessuno la tocca, i ragazzi della palestra non la mettono neanche a posto quando la sera spengono le luci; la lasciano lì, per me.
Mi siedo e mi spingo indietro, contro la parete, poi chiudo gli occhi; a quel punto i ricordi, senza sforzo, mi allagano la mente, come se avessi aperto la chiusa di una diga.
Mi rivedo allora bambino macilento in una Trieste ancora spaventata, accucciata davanti al mare a leccarsi le ferite di una guerra terribile e maledetta.
Ero magro e irrequieto, sempre affamato, come un gatto selvatico mi aggiravo tra le macerie annusando l’aria alla ricerca di una zuffa.
Non passava giorno che non ce le dessimo di santa ragione, noi del rione San Giacomo e la banda di Mario il Tricheco,così chiamato per quei denti enormi che gli sporgevano davanti.
Quando non eravamo in mezzo all’ennesima rissa io, Vittorio, Raimondo e gli altri muli del gruppo andavamo a rubare le maniglie delle porte. Suonavamo ai campanelli delle case e se non rispondeva nessuno smontavamo in fretta e furia le maniglie di ottone per poi rivenderle ai robivecchi.
Quando mio padre morì per una polmonite fulminante le autorità, che già mi tenevano d’occhio in quanto ragazzo “difficile”, mi rinchiusero nel collegio Nazario Sauro per inculcarmi a forza quella disciplina di fronte alla quale mi mostravo così riottoso.
Faceva freddo in quei cameroni militari, avevamo la testa rasata e si mangiava ogni giorno zuppa di verdura. Ogni scusa era buona per metterci in punizione. L’unica cosa buona del collegio fu quella di conoscere Otello Fontana; fu lui a vedere in me la classe del boxeur e ad iniziarmi ai rudimenti di quell’ arte.
Lì dentro non resistetti a lungo. I muri erano alti ma non quanto la mia voglia di libertà. Così una notte mi calai dal cornicione e scivolai lungo la grondaia lasciandomi per sempre alle spalle Trieste, gli amici e la gioventù.
Mi nascosi nella stiva di una nave e sbarcai a Civitavecchia. Da lì arrivai a Roma dentro il cassone di un camion, con l’intenzione di mettere a frutto i consigli di Otello e fare della boxe la mia professione.
C’erano ancora truppe americane in città e tutti, dopo quegli anni di paure, lutti e sofferenze non avevano che un solo desiderio: divertirsi e recuperare il tempo perduto.
Cominciai con le esibizioni, affrontando militari di colore nelle piazze e nei teatri: si disputava l’incontro e poi si ballava attorno alle corde del ring. Una sera mi venne a vedere un certo Ercole Mancini, organizzatore di incontri nonché proprietario della palestra Audace, a Trastevere. Mi disse che dovevo smetterla con le esibizioni da circo e che era ora di pensare seriamente alla boxe. Avevo vent’anni, mi portò nella sua palestra. Da lì cominciò tutto.
Appoggiato alla parete, sempre ad occhi chiusi, passo in rassegna anche i miei avversari. Di loro porto scolpita nella mente ogni piega del viso.
Enea Lorusso, di Bari, è sempre il primo ad arrivare. Lui è il soldato che piantò i chiodi sulla mia croce privandomi del titolo italiano e mettendo fine alla mia carriera.
Quel gancio che aggira la mia guardia e si abbatte sull’occhio destro aprendomi il sopracciglio l’avrò rivisto mille volte nella mia mente. Mi sembra ancora di sentire il sangue che striscia lungo la guancia e si infila nell’angolo della bocca. Sospensione, intervento del medico, stop. Fine dell’incontro, fine della carriera.
L’arbitro decretò il K.O. tecnico, ma non gliela diedi al pugliese la soddisfazione di vedermi cadere al tappeto. Né a lui né a nessun altro. La vita, lei sì che mi ha sbattuto per terra come uno straccio vecchio, ma un uomo no, un uomo mai.
Dopo quell’incontro qualcuno di importante si interessò al mio destino, forse proprio Ercole Mancini, e la Esso mi fece avere in gestione una pompa di benzina a Rieti, tanto per sopravvivere in qualche modo e arrivare fino alla pensione.
Così mi sono ritrovato in questa città, un posto bello e tranquillo. A volte passeggio lungo l’argine del Velino oppure entro nella chiesa di San Francesco per starmene un po’ in raccoglimento.
A dire la verità a volte non lo faccio consapevolmente. Mi rendo conto all’improvviso di essere in un certo luogo ed è come risvegliarsi in piena notte. Non ricordo perché mi trovi in quel posto o abbia imboccato quella strada. È la malattia ormai che guida i miei passi.
Ma di lei ho imparato a fidarmi; mi sono convinto che sappia molte più cose di me. So che è acquattata nella profondità della mia psiche, là dove sono depositati i ricordi e i desideri più nascosti, e se allora mi conduce in qualche luogo avrà le sue ragioni, che io non conosco ma lei sì. In ogni caso so che capiterò in un posto gentile perché Rieti mi piace e anche di lei mi fido, benché adesso mi ritrovi sempre più spesso a pensare con nostalgia alla mia città e ai posti che mi hanno visto crescere, tanto che sono sicuro che prima o poi arriverà il giorno in cui saluterò Rieti e farò ritorno a Trieste, per chiudere il cerchio.
Quando riapro gli occhi, mi alzo e faccio qualche passo tra gli attrezzi. Mi avvicino al sacco e lo faccio dondolare un po’, spingendolo dolcemente, come se dovessi addormentare un neonato nella culla; poi do un buffetto a mano aperta al punching ball e seguo le sue molli vibrazioni. È il mio modo affettuoso per salutare vecchi amici.
Mi sposto con lentezza da un lato all’altro della palestra. I miei passi da quando è cominciata la malattia si sono fatti incerti. Dell’antica elasticità non è rimasta alcuna traccia. Al suo posto è subentrata una rigidità che ha colpito tutte le membra seguendo una linea verticale che dai piedi sta salendo fino al collo. Un’onda di ghiaccio si sta lentamente impadronendo del mio corpo. Alla rigidità ha fatto seguito il tremore, prima soltanto delle mani, poi delle gambe ed ora anche delle mascelle, che mi ballano frolle come quelle di un cane. La malattia è incurabile, lo so bene, non ho alcuna speranza di guarire. I dottori me l’hanno detto e ripetuto: “Mi dispiace signor Bastiani, si tratta di una degenerazione dei nuclei nervosi della base del cervello. Irreversibile. Si chiama morbo di Parkinson. Lei ha preso troppi colpi sulla faccia, sulla testa e queste purtroppo sono le conseguenze”.
Così non mi rimane che aspettare il compiersi del mio destino e intanto imbottirmi di compresse per sciogliere almeno un po’ la crosta di ghiaccio che ricopre il mio corpo. Me le porto sempre in tasca: atropina, scopolamina, stramonio. Servono a poco ma hanno bei colori. Mi piace metterle in fila e disporle in bell’ordine sul comodino della mia camera, una dietro l’altra, come tanti piccoli soldatini in parata. Le tengo tutte, ed ogni volta che mi ordinano nuove pastiglie, pergolide, lisuride – “Vedrà, sono portentose! “- io sono felice; nonperché pensi di poter guarire o stare meglio maperché la mia collezione si fa più ricca.
Non posso nascondere la malattia. È lì davanti a tutti, ben visibile, ma non me ne vergogno. L’unica cosa che mi ripugna è il tremore del pollice e dell’indice che si sfregano continuamente tra loro.
Gli amici del bar Cavour ci scherzano sopra: “Achille, ma dove li prendi tutti ‘sti soldi. Stai sempre a contarli”. Ridono, loro, ma per me è una pena vedere queste maledette dita continuare ad accarezzarsi. È come se la malattia mi avesse marchiato di un contrappasso dantesco. Proprio io che di soldi nella vita ne ho sempre avuti pochi mi trovo oggi condannato, ad un passo dalla morte, a contarne tanti, a contarne sempre.
È l’ultimo scherzo del mio destino infame.
Per il resto mi lascio vivere. Trascino i miei piccoli passi di automa stanco e a volte mi fermo accanto a qualche ragazzo. Mi permetto di correggere una posizione sbagliata, sussurro qualche consiglio.
Per tutti cerco di avere una parola di affetto perché tutti mi sono ugualmente cari e quando qualcuno smette di frequentare la palestra perché non sopporta più la fatica o perché semplicemente si è reso conto di non amare abbastanza questo sport, io ci soffro, perché mi sembra che sia sparito un altro pezzo di ombra che ristorava la mia camminata solitaria nel deserto.
Mi sono tutti ugualmente cari ho detto, ma è una bugia. Ad essere sinceri ce n’è uno per il quale sento di avere un affetto particolare. Anche lui mingherlino e non troppo alto, un fascio di nervi come ero io quando avevo i suoi anni.
Anche lui superwelter, anche lui guardia sinistra.
Mi rivedo in lui. Si getta con impeto sul sacco, si lancia con coraggio contro l‘avversario, anche se è più grande, non conosce la paura.
Io lo guardo come fa il sommelier quando, con il bicchiere di vino sollevato a mezz’aria, ne vuole valutare la trasparenza e sorrido compiaciuto perché Stefano è di una trasparenza cristallina. La sua classe è pura.
Ogni pomeriggio lo vedo ammazzarsi di lavoro. La fatica non lo spaventa, anzi sembra quasi che lo rallegri. Non gli sembra mai abbastanza, la va a cercare e se la infligge come se volesse punirsi di qualche colpa.
Esegue con foga i suoi esercizi; flessioni sulle gambe, sulle braccia, balzi, saltelli. Soffre ma non molla. Vedo i suoi lineamenti deformarsi in una smorfia di dolore e i denti stringersi in un ghigno spasmodico. Ma non molla.
Lo attende un appuntamento decisivo. Tra poco più di una settimana, qui a Rieti, combatterà l’incontro che attende da anni, quello che gli permetterà, in caso di vittoria, di passare al professionismo.
Anch’io sto aspettando quest’incontro e mi sto preparando. Come se dovessi salire io sul ring e non Stefano, come se toccasse a me e non a lui infilare i guantoni.
E se fosse veramente così in fondo? L’ho seguito con tale partecipazione questo ragazzo fin dal primo giorno in cui è entrato in palestra, mi sono talmente identificato nella sua rabbia, nella sua onesta e pulita sofferenza che anch’io quel giorno scavalcherò con lui le corde del ring.
E potrò finalmente riscattare la mia sconfitta con Lorusso, mi prenderò la mia rivincita: ricombatterò oggi, a sessantacinque anni, quell’incontro disgraziato così da pareggiare i conti con la boxe e con la vita.
Il giorno è arrivato.
Sono seduto vicino alle corde, la gente continua ad affluire.
Il ring è lì, davanti a me, inondato di luce, freddo, impassibile, pronto ad accogliere i passi della danza, la danza dei lupi.
Dalla mia postazione punto lo sguardo su Stefano che esce dal sottopassaggio.
Mi sento bene, non mi sono mai sentito meglio. Ècome se improvvisamente mi fossero tornare le forze, di nuovo sento tendersi i muscoli delle braccia sotto il vestito, le mie gambe hanno ritrovato l’antica agilità e lo stomaco, non più flaccido e gonfio, è diventato un blocco di pietra capace di incassare qualsiasi colpo.
Distendo le mani davanti a me e vedo che non tremano più. E le mie maledette dita, anche quelle hanno smesso di accarezzarsi.
Stefano è salito sul quadrato. Sento nelle mie vene il martellare del suo cuore ed anche il mio comincia a battere più forte, si unisce al ritmo del suo fino a pulsare all’unisono. Ed è già il primo gong.
Le persone accanto a me mi scrutano preoccupati di sottecchi, osservano spaventati il mio sguardo. Lo osservo anch’io in quello di Stefano ma non mi spavento, anzi. Quel bagliore metallico che guizza nei suoi occhi come il riflesso di una baionetta mi riempie di una gioia animale.
Vedo il suo corpo diventare lucido, la luce dei riflettori rimbalza e scintilla sul suo torace. Il sudore mi inzuppa il vestito e le gocce che gli colano dalle tempie e gli rigano le guance me le sento ballare sulla fronte.
Stefano colpisce, arretra e torna all’attacco ma l’avversario non mostra di accusare i colpi. È chiuso a testuggine, i colpi sembrano scivolargli addosso come acqua su uno specchio.
Stefano non riesce a chiudere l’incontro e le energie lo stanno lentamente abbandonando.
Mi accorgo che la tensione che aveva gonfiato i muscoli e aveva dato forza alle mie braccia sta lentamente scemando.
I colpi di Stefano si fanno fiacchi e lenti. Bruciano i polmoni e dalle narici entra solo un filo d’aria ad ogni respiro: troppo poco per placare l’arsura che sento dentro. Allungo il collo e cerco ossigeno.
Il suo respiro si fa sempre più affannoso. Aria, aria! non ce la fa…non ce la faccio!
Un gancio aggira la mia guardia e si abbatte sull’occhio destro aprendogli il sopracciglio. Di nuovo. Come quella volta. Il sangue comincia a colare lungo la mia guancia in un rivolo sottile.
Lo vedo barcollare sulle mie gambe malferme e all’improvviso un urlo esce dalla mia gola strozzata lacerando la tranquilla imperturbabilità della folla: “Nooo… al tappeto no…”. Poi un altro colpo, un diretto in piena faccia…
Come una marionetta a cui hanno tagliato i fili, Stefano piega le gambe e si accascia sul tappeto.
L’ultimo pensiero cosciente di Achille Bastiani fu che era arrivato il giorno, quello che stava aspettando. Era tempo di ritornare a Trieste, di ritornare a casa; suo padre lo stava aspettando ed anche i muli della banda. Per vivere qualcosa avrebbe fatto ma rubare le maniglie no, quello non più. Glielo avrebbe detto a Vittorio, a Raimondo, avrebbero capito. Quanto al Tricheco gli avrebbe dato una lezione, questo era certo, ma bisognava stare attenti perché non voleva tornare di nuovo in collegio, farsi rasare la testa e mangiare ogni giorno zuppa di verdura.
Uscendo dal palazzetto dello sport si incamminò con passo deciso verso la stazione.
Era il 12 febbraio 1996. Fu quello l’ultimo giorno di vita di Achille Bastiani.
Alcuni operai rinvennero il corpo di un uomo anziano sulla massicciata della ferrovia, a cinque chilometri dalla stazione di Rieti, direzione nord.
Il macchinista del treno locale Terni-Sulmona riferì alla polizia di aver visto dopo una curva un uomo camminare lungo i binari. Aggiunse che doveva trovarsi in stato confusionale perché all’arrivo del treno non si è nemmeno girato né ha mostrato di avvertire il suono della sirena continuando la sua ostinata camminata a testa bassa.
Achille Bastiani invece la sirena l’aveva sentita bene. Solo che era stanco di prendere colpi e non si spostò. Doveva salire su quell’ultimo treno, lo stava aspettando. La sua ultima stazioneera un ring pieno di luce, dove finalmente i colpi non gli avrebbero più fatto male. Voleva scendere lì.