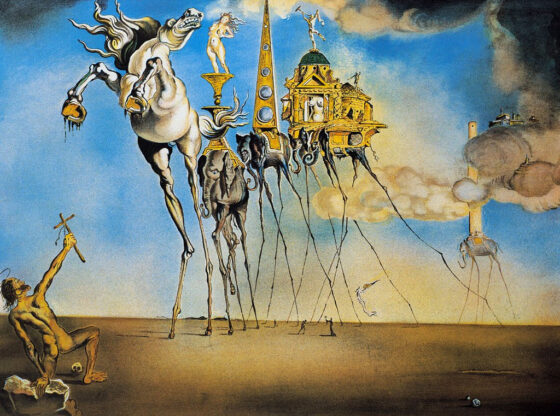Di Gennaro Lento
La strada in mezzo
La strada in mezzo era secca e polverosa, scavata al centro da un binario di rughe profonde laddove abitualmente si trascinavano i pesanti carri dei contadini diretti alle campagne. Come ferita aperta, lacerava per lungo quella pianura assetata, riarsa dalla violenza oscena del caldo estivo. Stoppie ingiallite ai bordi ne incorniciavano l’incedere stanco e lento di fiume antico, incessante eppure immobile. Nel crepuscolo i colori tendevano a fondersi in un grumo dapprima giallastro, poi ocra e poi grigio. Tutto era rivestito da un fitto strato di polvere che, come sudario, velava ogni cosa sotto un mantello opaco.
Da un lato della strada vi era una fila di edifici bassi, sulla quale sbocciava una serie di porte e finestre simili a bocche chiuse. Accanto a ogni porta, appesa a un chiodo come sanguinoso rosario, pendeva la collana del peperoncino lasciato a essiccare. Lungo i muri, una magra platea di sedie impagliate sembrava attendere l’arrivo del pubblico per l’apertura di un qualche sipario. Al centro, solitario torrione, svettava una costruzione più alta e squadrata, che dominava incontrastata la scarna geometria del paesaggio. Sul muro bianco di gesso, corrosa dalla polvere e dal tempo, si leggeva la scritta in vernice rossa EMPORIO SARRO in caratteri maiuscoli e irregolari. Dall’altro lato della strada il nulla. Un rado filare di pioppi ingialliti, qualche paracarro in pietra e cemento e dietro il nulla fino a che poteva arrivare l’occhio.
In mezzo, la strada.
L’uomo dietro la finestra non aveva più di ventidue anni, anche se ne dimostrava quasi il doppio. L’ombra scura di una barba mal rasata ne incupiva i lineamenti disegnandogli delle rughe che non possedeva. Secco come un chiodo, come la miseria, diceva sua madre. Da bambino non era stato altro che quattro ossa attaccate per miracolo e sembrava sgusciare fuori da ogni vestito, tanto era gracile. In pochi pensavano che avrebbe campato a lungo, U’ lientu, il magro. Aveva capelli chiari e corti, radi sulla sommità del capo a suggerire una prossima calvizie. Gocce di sudore gli scendevano dalla fronte fino sul colletto della camicia bianca, rigata da un filo più scuro di umidore proprio alla base del collo. Gli occhi spiavano febbrilmente dalle fessure della finestra chiusa. Da destra a sinistra, da sinistra a destra. Guardavano oltre la strada, di là dagli alberi, attenti a ogni minimo movimento. Tutto sembrava quieto e posato in quel momento, ma lui sapeva che presto, in mezzo alla strada, ci sarebbe stata una gran confusione. La mano destra stringeva il calcio di un lungo fucile, ogni tanto ne avvicinava la fredda canna al volto per darsi coraggio. Con l’altra mano carezzava il capo di sua moglie, seduta per terra. Lui guardava fuori e lei cercava risposte nei suoi occhi. Era poco più che una bambina.
L’altro uomo era più vecchio, ma non di tanto, piuttosto sembrava provenire da un altro mondo. Tozzo e robusto, portava in testa un cappellaccio nero dalla larga tesa che gli copriva lo sguardo. Scuro di carnagione, cotto dal sole e secco come una corteccia d’albero. Lo chiamavano Canazzu. Cagnaccio. Il soprannome se lo era guadagnato sul campo, grazie alle scorrerie ai danni dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Coperto dalla notte e dall’ampio mantello, sbucava all’improvviso negli accampamenti dei soldati, sgozzando le sentinelle e rubando tutto quello su cui riusciva a mettere le mani. Armi, vestiti, cibo. Soprattutto cibo per i suoi che pativano la fame nera sulle montagne. Non lo presero mai. Una volta organizzarono una caccia all’uomo con un’intera guarnigione di soldati tedeschi, accompagnati da un gruppo di fascisti del posto. Perlustrarono le montagne metro dopo metro, ma lui e i suoi erano come svaniti nel nulla, evaporati nella notte. La gente diceva che erano gli spiriti dei morti a proteggerli e che tra i suoi ci fossero donne zingare capaci di fare le magarìe, i sortilegi. La gente ne diceva tante di cose. Comunque, i tedeschi ci rinunciarono e continuarono a contare le vittime e i furti. Dopo la guerra rimase solo la miseria e i tempi divennero ancora più duri. Canazzu iniziò a depredare i contadini della vallata, guadagnandosi la fama di bandito violento e crudele e attirandosi le attenzioni della legge. Accompagnato da qualche compare della sua stessa risma, saccheggiava i casolari più isolati, facendo razzia di animali, formaggio e scorte di grano. Spesso agiva indisturbato, preceduto dalla paura che incuteva il suo nome e che piegava di terrore le vittime prima ancora di vederlo comparire. Rare volte era stato costretto allo scontro e in un paio di occasioni c’era scappato il morto. La legge ci poteva fare poco, vista la distanza dal più vicino comando dei carabinieri e la carenza di militari. Di solito arrivavano un paio di giorni dopo le rapine, avvertiti da qualche contadino di passaggio, si limitavano a registrare l’elenco della roba trafugata e ad accumulare denunce a carico di Rosario Trabucco detto Canazzu. Ma a catturarlo neanche ci avevano provato. Non c’erano riusciti tedeschi e fascisti, figuriamoci un paio di carabinieri sovrappeso e padri di famiglia. Non era cosa loro.Canazzu aveva una moglie, sposata a tredici anni tra le montagne, che lui aveva fretta di farsi una famiglia e non c’era tempo da perdere. Aveva anche una figlia, l’unica persona al mondo che riuscisse a sciogliere un poco quel grumo di durezza che aveva dentro il petto. E che all’indomani si sarebbe sposata. Con un ragazzo come si deve, sissignore, che Canazzu non dava l’unica figlia al primo che passava e anche se si sentiva incendiare le viscere al solo pensiero di non averla più in casa, gli avrebbe fatto lo stesso una festa che se la dovevano ricordare finché campavano. La figlia di Canazzu che si sposava.
Oltre la finestra ormai la notte era arrivata. La strada in mezzo era illuminata dalla luna, piena come un disco d’argento. E d’argento erano i riflessi che dava alle cose, alle pietre, alle stoppie, alle foglie degli alberi rilucenti come scaglie d’acciaio.
– La Madonna ci vuole bene, – disse U’ lientu guardando ancora una volta fuori dalla finestra chiusa. La luce della luna l’avrebbe aiutato a vedere quello che doveva vedere. Sua moglie masticava lentamente un pezzo di pane accompagnato da formaggio duro, di quello che facevano nelle campagne. Brava ragazza, pensava U’ lientu, sarà una brava madre, come sua madre e come la mia. Gente abituata alla fatica come a respirare, senza lamentarsi mai e senza grilli per la testa, che già si campava a fatica. Donne silenziose e affidabili fin da bambine, che imparavano presto a reggere le redini della casa con giudizio e parsimonia, compagne di uomini ombrosi e irrequieti come quel paesaggio, un po’ pianura, un po’ collina, un po’ montagna. Stavano bene insieme, U’ lientu e sua moglie, e altro non avrebbero immaginato di desiderare, pensavano di essere nel posto giusto e di esserci nel modo giusto. Appena sposati, e contro il parere delle famiglie, decisero di aprire l’emporio sulla strada provinciale, che tutti chiamavano‘A strata i mmìenzu, la strada in mezzo, perché attraversava il loro mondo tagliandolo a metà. A quella gente, abituata da sempre a vivere dentro lo spazio angusto di una fattoria, sembrava una pazzia bella e buona. Cchì savìanu misu ‘ncapa, cosa si erano messi in testa quei due, così giovani e digiuni delle cose del mondo, di andare a vivere da soli e senza aiuto, lontani da loro, dalla famiglia e dalla sicurezza, chissà che si pensavano, forse che erano più intelligenti degli altri, tiègnunu ancora l’uocchi chiusi cumu i gattarielli, hanno ancora gli occhi chiusi come i gattini appena nati, Santa Teresa aiutali tu, che non c’è peccato più grande della superbia, aiutali, facci cangiàri a capa, fagli cambiare idea. Santa Teresa non fece il miracolo e i ragazzi continuarono a non curarsi troppo delle parole e delle preghiere dei vecchi. Condividevano l’idea che quella strada fosse una promessa di novità, l’unico modo per stabilire un contatto con il resto del mondo e uscire dalle pareti ristrette di una vita già segnata prima ancora che nascessero. Riconoscevano quella sensazione l’uno nello sguardo dell’altra ed era davvero difficile per loro spiegarsi a parole. Così, semplicemente ci rinunciarono. Rimisero a posto una vecchia costruzione a due piani appartenuta a un parente morto in guerra e ne fecero casa e bottega.
La scelta si era rivelata molto saggia, visto che non c’erano altri posti di approvvigionamento per molti chilometri intorno. I contadini di passaggio venivano a rifornirsi di attrezzi, sementi e altri generi che non riuscivano a produrre in proprio, pagando spesso con i frutti delle loro attività, a loro volta messi a disposizione degli abitanti del piccolo borgo. In poco tempo U’ lientu era riuscito a crearsi una posizione solida e un emporio sempre più fornito. Non per questo aveva dimenticato come si stava al mondo e quando c’era da fare credito a un poveraccio con cinque o sei bocche da sfamare non si tirava indietro, spesso dimenticandosi di sollecitare il pagamento. Per questo era benvoluto e rispettato in quella striscia di paese, quattro case e quella bottega cresciuti in fretta come gramigna ai bordi di quella strada butterata. Poco alla volta altri si erano aggiunti a quella specie di convoglio statico, aggrappati tenacemente a quella strada come a una fune di salvataggio.
Strinse le palpebre per vedere meglio, gli era sembrato di notare un movimento tra le stoppie dietro agli alberi, un baluginare di metallo sotto la luna. Non si era sbagliato, stavano arrivando. Strinse il fucile e guardò sua moglie per darsi coraggio.
Nascosti dall’erba alta dietro ai pioppi, Canazzu e i suoi avanzavano lentamente e con molta attenzione, avendo cura di non esporre alla luna le canne dei fucili e le lame dei coltellacci per evitare che qualche luccichio potesse essere notato dalle case oltre la strada. Anni di abitudine a quelle sortite avevano affinato i sensi di quegli uomini che si muovevano come gatti anche sui ripidi sentieri di montagna. Non per questo Canazzu tollerava disattenzione e superficialità. Una volta aveva quasi ammazzato uno dei suoi perché si era messo a fumare mentre andavano a rapinare una fattoria a valle. Mentre lo colpiva furiosamente, continuava a ripetergli urlando A’ vrascj! A’ vrascj!, la brace, che nel nero della notte avrebbe potuto farli scoprire. Lo dovettero bloccare in tre, che altrimenti non si sarebbe fermato. Dopo quell’episodio nessun altro aveva avuto bisogno di spiegazioni. Anche quella notte, mentre avanzavano ai lati di Canazzu, gli uomini scelti per accompagnarlo misuravano attentamente i propri passi come se fosse stata la prima volta, con un occhio al terreno e un altro al capobranco.
Maliritta, maledetta, pensava intanto Canazzu guardando in alto, quella luce rischiava di mandare tutto a monte e non se lo poteva permettere. Per la festa di sua figlia aveva bisogno di roba, tanta. Salame, carne e pane, vino e olio. E tutto quel bendiddio era nell’emporio, lo sapeva perché aveva mandato una delle donne a guardare con i propri occhi qualche giorno prima e sapeva anche che il proprietario era poco più che un ragazzo, con una moglie bambina incinta di sette mesi. Se fossero arrivati allo scontro non gli avrebbe dato troppo fastidio, il ragazzo si sarebbe squagliato come grasso al sole. La paura, prima di ogni altra cosa, l’avrebbe vinto. Così pensava Canazzu, bisognava solo arrivare laggiù, attraversare la strada e prendere quello che gli serviva.
U’ lientu li vide arrivare e nascondersi dietro agli alberi, a poca distanza l’uno dall’altro. Adesso riusciva a distinguere perfettamente le loro figure e quello che non vedeva se lo immaginava. Quando venne a sapere di quel matrimonio, che con tutto il traffico che passava per quella strada le notizie facevano presto ad arrivare, una brutta sensazione gli prese l’anima, come un’ombra maligna che faticava a scacciare. Il giorno che vide quella donna nera aggirarsi come una lupa per il magazzino ebbe la certezza che i guai stavano per arrivare. Sapeva chi era quella donna, sapeva chi l’aveva mandata e, come tutti, capiva cosa significava. Sapeva che niente li avrebbe fermati, avrebbero agito con accortezza e ferocia. Niente li avrebbe fermati tranne una cosa. Uguale accortezza e uguale ferocia. Si trattava di difendere tutto quello che erano e tutto quello che sarebbero diventati. Non aveva bisogno di altre motivazioni.
Sentiva le mani che gli tremavano e un bruciore come di febbre sul collo fino alle orecchie. Un conato di vomito risalì veloce lungo l’esofago. Chiuse gli occhi, fece un respiro profondo e mise la punta del fucile in una fessura della finestra.
– Mettiti dietro la credenza, Antonia, e non tirare fuori la testa per niente al mondo, neanche se mi vedi morto, – disse in un soffio alla moglie, – state al riparo voi due, – aggiunse guardando con tenerezza quel viso piccolo e quegli occhi così fermi. E quella rotondità quasi incongrua in quel corpo di ragazzina.
Strada in mezzo, notte di luna piena.
Canazzu con la mano fa un segno all’uomo alla sua destra, che subito scivola dietro uno dei paracarri.
L’altro uomo, immobile nella notte, aspetta l’ordine.
U’ lientu vede tutto dalla finestra, il dito sul grilletto.
L’uomo immobile si muove, fa un passo verso la strada.
La fucilata riecheggia nella notte come un colpo di cannone, il riverbero del suono rimane nell’aria per parecchi secondi, prima di risalire piano verso la luna.
Il bersaglio si ritrae velocemente. Non è ferito, il colpo l’ha solo sfiorato.
U’ lientu ricarica con calma il fucile. Sua moglie ha le mani a coppa sopra le orecchie. Nei suoi occhi non c’è paura. Si guardano.
Canazzu arma il suo fucile e lo punta verso la finestra. Spara.
L’impatto del proiettile contro il muro solleva uno sbuffo di polvere bianca.
U’ lientu abbassa istintivamente la testa, la polvere entra dalla finestra e gli pizzica le narici.
L’uomo nascosto dietro al paracarro guarda Canazzu che, con un gesto della mano, gli fa segno di aspettare.
– Cosa fanno, – chiese Antonia.
– Niente, aspettano. Stanno cercando di capire come attraversare la strada, – rispose U’ lientu.
– Hai paura?
– No, – mentì. – E tu?
– Se non ce l’hai tu non ce l’ho neanche io.
– E lei? – indicò con il mento il ventre di Antonia.
– Non ha paura di niente, lei, – rispose Antonia, scoprendo un filare di denti bianchissimi.
– Brava bambina.
I due uomini sono pronti a scattare, gli occhi fissi su Canazzu.
Sono tesi, i muscoli pronti all’azione. Canazzu fa un segno deciso con la testa. Partono insieme, uno a destra e l’altro a sinistra.
U’ lientu non si fa cogliere impreparato, prende calmo la mira e spara a quello più vicino, che già è in mezzo alla strada illuminata d’argento.
La detonazione è seguita da un tonfo più sordo, quasi attutito.
L’uomo ruota su se stesso con una piroetta e crolla a terra con un lamento. Poi comincia a strisciare verso il bordo della strada.
Con prontezza U’ lientu punta il fucile verso l’altro uomo e spara ancora.
Il cappello vola a terra, l’uomo si fa cogliere dalla sorpresa e per un attimo resta come inebetito.
Poi, velocemente, torna indietro.
– Sangu i Gesucristo! – esclamò Canazzu, – chissu spara cumu nu riavulu, questo spara come un diavolo. – Ammucciàtivi! nascondetevi, urlò ai suoi.
Non se lo aspettava Canazzu, era disorientato. Non si aspettava di trovare una simile resistenza, credeva di avere a che fare con un ragazzo impaurito e invece si trovava di fronte un uomo armato. E che sapeva usare il fucile.
Chiese al ferito come si sentisse. – M’ha grupatu na spalla, ‘stu canu arraggiatu! Mi ha bucato la spalla, questo cane rabbioso, sibilò a fatica.
– Statti fermo, un ti mòviri ca ci pinzamu nua, stai fermo, non muoverti che ci pensiamo noi.
La situazione stava prendendo una piega imprevista. Canazzu ragionò rapidamente sulle cose da fare e si rivolse all’altro uomo.
– O’, t’ha sienti? ehi, te la senti?
– Sempri, Canà. C’amu fari? come sempre. Che dobbiamo fare?
– Iu cumìnciu a ci sparari n’cuollu ccu tutti l’armi e tu passi a strata e rumpi a porta iru magazzinu, io comincio a sparargli addosso con tutte le armi e tu attraversi la strada e forzi la porta dell’emporio.
– Sugnu prontu, fammi signu, sono pronto, fammi un segno.
Canazzu caricò rapidamente il fucile e la pistola che aveva addosso, poi impugnò il fucile del ferito e fece lo stesso, mettendoselo vicino.
– Vai mò!
Il primo colpo centra la parte alta della finestra, frantumando le stecche di legno. U’ lientu mette un braccio sopra la testa per coprirsi dalla pioggia di schegge. Un attimo dopo striscia verso la finestra di fianco.
Il secondo colpo prende il muro sotto la prima finestra, senza fare danni.
Intanto l’uomo si è portato a bordo strada, pronto a lanciarsi verso l’emporio. Canazzu imbraccia l’altro fucile e spara ancora verso la finestra, distruggendone la metà superstite. Al suo posto adesso c’è un buco nero, mentre la stanza s’illumina di luna. Senza farsi distrarre dai colpi alla sua sinistra U’ lientu infila la canna del fucile in una fessura della seconda finestra e prende la mira.
L’uomo è quasi dall’altra parte della strada quando un proiettile sibila appena sopra il suo orecchio destro, provocandogli una lacerazione della pelle. Il sangue comincia a scorrergli sul collo.
Il secondo colpo lo raggiunge sul braccio sinistro, frantumandogli il polso. Urla. Si butta a terra e rotola verso il bordo strada.
Canazzu continua a vomitare proiettili dalla sua pistola e vuota il tamburo prima di accorgersi che il suo uomo è stato respinto.
Un silenzio irreale cala sulla strada, si sente solo il riverbero fragoroso delle detonazioni, come un’eco sovrapposta più volte.
Nell’aria il puzzo acre della polvere da sparo si mischia a quello del pulviscolo sollevato dall’impatto dei proiettili con le cose. Alla luce della luna sembra una pioggia d’argento.
La strada in mezzo è vuota.
– Chissu n’ammazza a tutti, – sibilò tra i denti l’uomo, tenendosi stretto il polso.
Canazzu lo guardò di sbieco, seduto con le spalle appoggiato a un paracarro. Pensò che se quel diavolo con il fucile avesse avuto davvero l’intenzione di ammazzarli niente avrebbe potuto impedirglierlo, con quella mira non poteva sbagliare. No, non voleva ucciderli, stava solo difendendo la sua casa e la sua famiglia, come avrebbe fatto lui se fosse stato al suo posto, solo con più rispetto. Lo rispettava, il diavolo lo rispettava.
– Chi facìmu? – che facciamo, chiese l’altro uomo. Canazzu distese il fucile accanto alla gamba, tolse il cappello e iniziò a lisciarsi la testa.
– Nenti. Aspettàmu ca fa jùornu, – niente, aspettiamo che faccia giorno.
La luce dell’alba sbiadisce l’argento della luna. Dietro la finestra U’ lientu aspira piano l’umidità della notte che sale verso l’alto. Un profumo di erba umida gli entra nelle narici. Chiude gli occhi. Lontano sente il canto ostinato di un gallo. Antonia si è addormentata, rannicchiata dietro la credenza. Non si è mossa di un millimetro, le mani a tenersi quel ventre rotondo. Com’è bella, pensa U’ lientu, come sono belle. Pensa che questa bellezza non viene mai per caso, bisogna sapersela meritare, per tutto il tempo che c’è. Pensa a come sarà un giorno la loro vita, se saranno capaci di guadagnarsela ancora questa bellezza. Pensa di sì.
Dall’altra parte della strada i tre uomini respirano lenti, persi ognuno dentro le proprie cose. Canazzu guarda assorto verso il nulla, verso le donne che stanno preparando la cerimonia, verso la figlia che va incontro alla sua vita. Pensa al diavolo dietro la finestra e comprende che è tutto giusto, tutto al suo posto, come dovrebbe essere. Come è.
Osserva la luce del sole nascente che bagna d’oro il nulla. L’argento e l’oro. Pensa che è una fortuna vivere in una terra come quella. Pensa che è una condanna vivere in una terra come quella. Si gira, guarda la strada.
Adesso posso attraversarla, pensa.
– Dove vai, ti ammazzeranno, – disse piano Antonia, – ti ammazzeranno, – soffiò di nuovo a voce ancora più bassa. Si era appena svegliata.
– Non posso restarmene qui, devo aprire l’emporio. Se non lo faccio adesso resterà chiuso ogni volta che avremo paura.
La guardò negli occhi un’altra volta, prese le chiavi appese al chiodo e aprì la cataratta che portava al piano di sotto. Nel buio del locale poteva distinguere perfettamente l’odore forte delle spezie e delle sementi, mischiato a quello più pungente del formaggio stagionato. Piccoli fasci di luce filtravano attraverso le fessure delle finestre, illuminando vorticosi pulviscoli di polvere impazzita. Raccolse le forze e aprì il pesante battente della porta. La luce del mattino penetrò con violenza nell’emporio, riversando sopra ogni cosa un biancore accecante. Scese i tre gradini dell’ingresso e fissò la porta alla catena appesa al muro. Adesso mi sparano alle spalle, pensava e pensava anche che non avrebbe mai visto la faccia di sua figlia, perché nella pancia di Antonia c’era una bambina e anche se la vecchia levatrice aveva vaticinato un maschio lui era sicuro che fosse una femmina, forse solo perché era la cosa che più desiderava al mondo e lui non l’avrebbe vista nascere, crescere e diventare una donna come si deve, farsi strada nel mondo, sposarsi, avere dei figli. Pensava che non era giusto ma senza rabbia, quasi con dolcezza. Sentiva già il calore del sole sulla schiena, sarebbe stata un’altra giornata di fuoco. Con lentezza sciolse il laccetto che teneva raccolta la tenda scacciamosche, tornò nel locale e come ogni mattina iniziò a rimettere a posto le cose. Quasi che la liturgia dei gesti quotidiani potesse cambiare il corso degli eventi.
Fu in quel momento che il sole si oscurò e un’ombra nera si allungò sull’impiantito sconnesso del negozio. Canazzu e i suoi scostarono la tenda ed entrarono. Uno degli uomini teneva la mano premuta forte sulla spalla, la faccia bianchissima e gli occhi piccoli. L’altro lo guardava con ferocia, la fascia stretta intorno al suo polso sinistro era rossa di sangue. Canazzu sembrava imperturbabile. U’ lientu girò calmo dietro al bancone. Finalmente, uno di fronte all’altro, i loro occhi s’incrociarono. Immobile U’ lientu, con le palme delle mani rivolte verso il basso, appoggiate al bancone, le braccia dritte. Immobile Canazzu, scolpito nella roccia, il braccio sinistro lungo il corpo e la mano destra agganciata alla cintura dei calzoni. Si guardarono a lungo, dicendosi cose che non avrebbero potuto a parole. Poi Canazzu emise un grugnito che significava buongiorno. U’ lientu rispose al saluto.
– Buongiorno a voi. Vi posso servire qualcosa? – chiese come se avesse avuto di fronte un qualsiasi cliente.
– Si spusa fìgljiama, – si sposa mia figlia, disse con voce bassa Canazzu levandosi il cappellaccio e lasciando scoperta una testa di capelli ispidi, – m’abbisogna na zica i rrobba, – ho bisogno di un po’ di roba, aggiunse immediatamente.
– Siti u patrùne, – siete il benvenuto.
Iniziò un lento rituale, una messa quieta fatta di poche parole essenziali e di gesti misurati e lunghi. A ogni richiesta di Canazzu, U’ lientu rispondeva con piccoli cenni del capo e poi andava per il locale a preparare la merce che lasciava impacchettata sul banco. Il ticchettio della grande pendola dietro al banco contrappuntava ogni movimento. Dopo qualche minuto, Antonia scese con attenzione dalla cateratta, mettendosi di fianco al marito e senza dire una parola iniziò ad aiutarlo. Lui la guardò di lato, sorridendo appena. Quando finirono Canazzu fece un cenno ai suoi che tirarono fuori dalle tracolle di cuoio alcuni grossi sacchi di tela grezza nei quali iniziarono a mettere la roba. Poi, con un rapido gesto della mano, sfilò la piccola borsa che portava attaccata alla cintura e ne estrasse tre grosse pietre opache e informi.
Erano tre pezzi d’argento.
– Avàstanu? – bastano? chiese.
– Avàstanu, – rispose U’ lientu.
– Pace?
– Pace.
Allungò la mano destra oltre al bancone. U’ lientu la strinse forte, senza muoverla, come facevano gli uomini.
– Tanti auguri a vostra figlia e centanni i bona saluta, – disse Antonia guardandolo negli occhi.
– Aguri a vua ppì r’a criatùra ca purtàte, – auguri a voi per la creatura che portate in grembo, disse indicando con la testa la pancia di Antonia. – E’ na fimmina.
E sorrise. Una cosa più incongrua non si poteva immaginarla, un sorriso in mezzo a quella faccia nera. Raro e inaspettato, bello come una pietra preziosa, sembrava uno squarcio nella notte. Un lampo rapido che rapido scomparve. Si girò, voltando l’ampio mantello.
– Iamunìnne, – andiamo, esortò.
Con i sacchi in spalla li videro attraversare la strada in mezzo e sparire verso il nulla.
Antonia si strinse forte al braccio del marito.