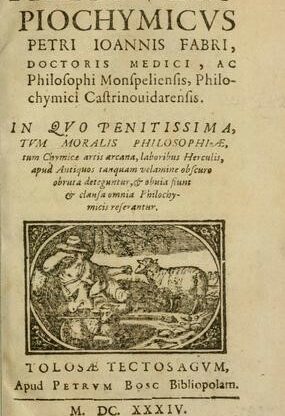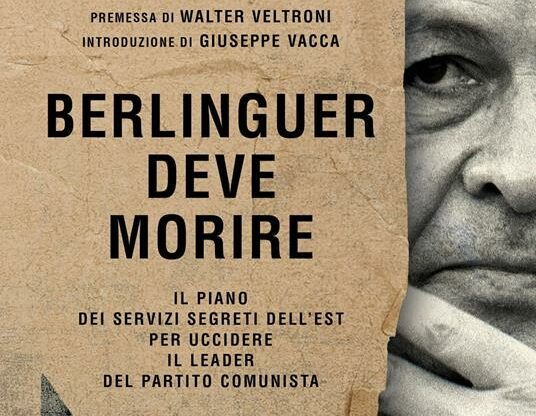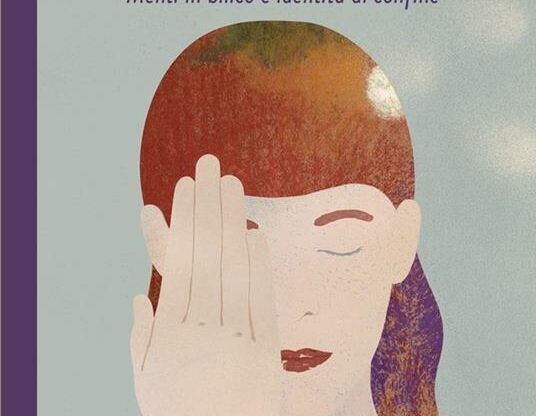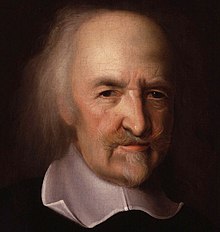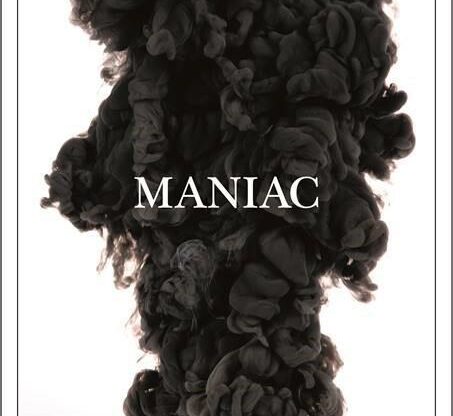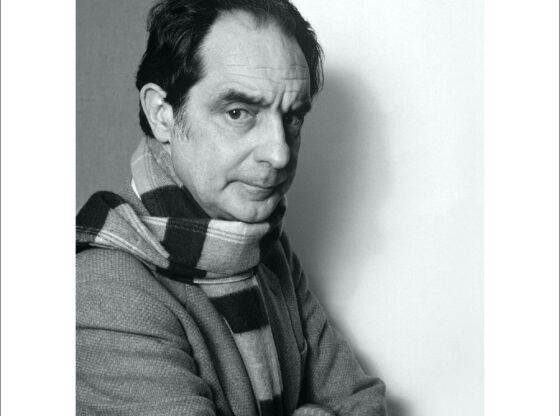Questo articolo è apparso sul n 30 della rivista Euterpe
Il paradiso perduto: alcune interpretazioni e variazioni del topos dell’età dell’oro dal periodo classico al Cinquecento.
Di Graziella Enna
Esiodo è stato l’inventor dell’età dell’oro e ha cercato nel mito le cause della decadenza della società, allontanatasi gradualmente dallo stato di grazia concesso all’uomo dagli dei, con la degenerazione delle varie epoche della civiltà umana: da quella rappresentata dal più nobile e inattaccabile dei metalli, l’oro, fino a giungere a una simboleggiata dal metallo più vile, il ferro. In seguito il mito è stato riutilizzato in molti contesti letterari: spesso alcuni autori, in veste di laudatores temporis acti, l’hanno preso in esame per rimpiangere la decadenza del periodo a loro attuale rispetto a quell’età perfetta; altri, interpretando in maniera originale il motivo con una poetica allusiva, l’hanno adattato alla loro ideologia. Il primo esempio che si può addurre è Virgilio, che, pur scrivendo l’Eneide, il suo capolavoro encomiastico, in età augustea, vive anche la realtà delle guerre civili con uno stato d’animo pervaso da una cupa apprensione da cui scaturisce l’aspirazione, più che legittima, alla fine di un’epoca nefasta e alla nascita di una nuova era. Perciò nella IV ecloga profetizza la nascita di un puer che avrebbe inaugurato un periodo di prosperità e pace riportando la terra in una condizione di perfezione di esiodea memoria. Nella cultura cristiana medievale Virgilio assumerà, grazie a quest’ecloga, i connotati di un profeta che ha prefigurato la figura di Cristo. Per testimoniare la fama di Virgilio, basti pensare all’episodio, presente nel XXII canto del Purgatorio, che riguarda il poeta Stazio: Dante accoglie la leggenda di una sua conversione al cristianesimo e nella finzione letteraria quando narra, su richiesta di Virgilio, l’approdo alla nuova fede, cita come elemento propulsore proprio la lettura dei versi virgiliani tratti dalla quarta ecloga.
Purgatorio XXII vv.64-72
Ed elli a lui: “Tu prima m’invïasti
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
e prima appresso Dio m’alluminasti.66
Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte,69
quando dicesti: ’Secol si rinova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenïe scende da ciel nova’.
Questa è una delle innumerevoli prove del successo di Virgilio come mago e profeta, comunque il puer virgiliano, rimasto nei secoli una figura emblematica e misteriosa, aveva lo scopo, secondo le teorie critiche più accreditate, di simboleggiare una palingenesi del mondo con l’avvento dei Saturnia regna, che avrebbero riportato l’uomo a una vita in armonia con la natura dopo i drammatici avvenimenti delle guerre civili. (Virgilio IV ecloga vv.18-30).
Per te, o fanciullo, la terra senza che nessuno la coltivi,
effonderà i primi piccoli doni, l’ edera errante
qua e là con l’elicriso e la colocasia con il gaio acanto,
Le capre da sole riporteranno gli uberi colmi
di latte, e gli armenti non temeranno i grandi leoni.
La stessa culla spargerà per te soavi fiori.
Svanirà anche il serpente, svanirà l’erba insidiosa;
ovunque nascerà amomo di Assiria.
Ma quando potrai leggere le lodi degli eroi
e le imprese del padre, e conoscere cosa sia la virtù,
a poco a poco la campagna imbiondirà di ondeggianti spighe,
dagli incolti roveti penderanno rossi grappoli d’uva,
e le dure querce stilleranno una rugiada di miele.
Si può fare riferimento ad altri passi di Virgilio: nel II libro delle Georgiche, (vv.458-542), tesse le lodi della vita degli agricoltori e idealizza il mondo dei campi ritenendolo un retaggio dell’originaria età dell’oro; nell’VIII libro dell’Eneide, Enea si reca da Evandro, (vv.310-368), il quale descrive la vita agreste e felice del suo regno caratterizzato da ameni scenari incontaminati. In entrambi i casi Virgilio dimostra la nostalgia per gli ambienti naturali di un mondo antico e genuino che costituiscono una proiezione del passato mitico. Nel primo libro delle Georgiche, (vv.121-159), introduce però la cosiddetta “teodicea del lavoro”, una forma di superamento dell’indolenza che affliggeva gli uomini nell’età dell’oro che indusse Giove a introdurre le fatiche per stimolarne l’operosità e l’ingegno: sembrerebbe quasi una nota polemica e discordante, unita alla volontà di smitizzare il paradiso aureo. Da ciò si evince che Virgilio rielabori il mito classico in maniera critica adattandolo di volta in volta alla propria concezione della vita e del mondo che lo circonda.
| Fiorì per prima l’età dell’oro; spontaneamente senza bisogno di giustizieri o leggi onorava lealtà e rettitudine. Non c’erano pene a incutere paura, né incise su tavole di bronzo si leggevano parole minacciose, né gente implorante clemenza temeva le labbra del giudice, ma tutti vivevano sicuri senza che alcuno li tutelasse. Non ancora reciso dai suoi monti, il pino era calato in limpide onde per visitare terre straniere e ogni mortale non conosceva altri lidi se non i propri. Ancora non cingevano le città fossati scoscesi, non c’era la tromba di bronzo, non c’erano corni ricurvi di bronzo, né elmi o spade: senza bisogno di soldati, la gente viveva tranquilla in molli ozi. E la terra, non obbligata,non toccata dal rastrello, non squarciata da vomeri, produceva ogni cosa da sé e gli uomini si accontentavano dei cibi nati spontaneamente, raccoglievano corbezzoli, fragole di monte, corniole, more attaccate alle spine dei rovi e ghiande che cadevano dal vasto albero sacro a Giove. Era primavera eterna: con soffi tiepidi gli Zefiri accarezzavano tranquilli i fiori nati senza seme, e prontamente il suolo produceva, non arato, le messi, e i campi senza dover restare a riposo erano gialli di grosse spighe; e fiumi di latte, fiumi di nettare scorrevano, mentre giù dal leccio verde stillava il miele biondo. |
Sempre in età augustea, Ovidio nell’incipit delle Metamorfosi riprende il mito esiodeo per indicarne la fine e il passaggio alle epoche successive di decadenza, fatto che riflette in maniera significativa l’umanità e i suoi continui mutamenti, spesso negativi. L’età dell’oro rappresenta pertanto l’inizio della storia, un mondo ideale primigenio cui probabilmente anche Ovidio, pur consapevole che si tratti di un mito utopico, vorrebbe ritornare. Sembra discordante e quasi di dissenso la sua posizione ideologica nei confronti di Augusto che aveva inaugurato ufficialmente un’epoca di pace e prosperità attraverso però una politica di stampo militare in cui emergono la volontà di potenza e di affermazione dell’imperialismo da parte dei Romani. Forse proprio per questa ragione Ovidio avverte l’esigenza di un ritorno a un’armonia perfetta che non esiste più nonostante l’impero di Augusto in apparenza si qualifichi come età di pace, ma ne è la negazione assoluta come emerge da questa descrizione caratterizzata da un incalzare di proposizioni coordinate negative. (Metamorfosi I, vv. 89-112)
Sicuramente un altro aspetto che colpisce in questa descrizione è la rappresentazione della natura intatta: la metonimia del pino non ancora reciso per indicare l’arte della navigazione che turba le distese pelagiche, lo scavo di fossati difensivi, la costruzione di armi per le guerre, di strumenti agricoli che violano il terreno. Tutto ciò ha provocato un processo di profanazione della verginità della natura: la guerra ha richiesto la lavorazione dei metalli per forgiare le armi, l’edificazione di mura e opere difensive hanno mutato la fisionomia del territorio, il lavoro dei campi ha stravolto la natura generosa che spontaneamente offriva i propri frutti. Perciò Ovidio, in maniera forse malcelata agli occhi di Augusto, assume le vesti di un rigoroso pacifista, contrapponendo l’epoca in cui vive a una che non esiste più. Parecchi suoi temi, la navigazione come arte funesta volta ad alimentare commerci in lidi lontani, le armi, le guerre e le contese, sono ripresi da Tibullo (I, 3) che nei vv. 35-48 deplora la fine di quella condizione di perfetta felicità.
Come bene viveva sotto il regno di Saturno l’umana specie, prima che la terra si aprisse a lunghi viaggi! Sfidato ancora non aveva il pino le cerulee onde e non aveva offerto al vento vele spiegate, né il navigante per ignote terre vagando in cerca di guadagni aveva colmo la nave di merci straniere. Mai in quel tempo il toro robusto si piegò al giogo, e non mordeva con la bocca domata il freno il libero cavallo; nessuna casa aveva porte pietre non c’erano nei campi per segnare limiti certi al suolo. Da se stesse davan miele le querce, e le mammelle piene di latte offrivano le pecore spontaneamente agli uomini felici. Non odio,non esercito esisteva, né guerra. Il fabbro non aveva ancora spade con dispietata arte forgiato.
In realtà Tibullo rimpiange questo idilliaco rapporto con la natura per un motivo molto personale, auspica per se stesso la possibilità di ricreare un’atmosfera perfetta e tranquilla, immersa nei luoghi agresti, in cui predominino i valori di lavoro, parsimonia, rispetto del mos maiorum per vivere gioiosamente una relazione amorosa con la sua donna. Tibullo in ciò si dimostra perfettamente in linea con quell’ideale di restaurazione degli antiqui mores propugnato da Augusto, sebbene appunto, adatti quest’ideologia al suo sogno di vivere una storia d’amore stabile nel quadro però di una natura intatta e di una religiosità tradizionale.
Lucrezio, prima di Ovidio, Virgilio e Tibullo, nel suo celebre poema “De rerum natura”, in ottemperanza ai principi dell’epicureismo, ci presenta invece la negazione della mitica età aurea, offrendoci, in sua vece, una visione razionalistica e scientifica ante litteram della natura. Egli sicuramente assume una posizione quasi rivoluzionaria facendosi promotore e divulgatore dei principi epicurei, (seppur, a suo dire, addolciti dal miele delle Muse), che stravolgevano la religiosità tradizionale romana introducendo una visione totalmente nuova della natura del cosmo. Nei passi del V libro dell’opera tratta gli albori della civiltà umana di cui fornisce un quadro molto realistico con una concezione modernissima dello stato di ferinità dell’uomo immerso in una natura primordiale possente e costretto a fronteggiarne le insidie. Egli intende rovesciare la concezione dell’età dell’oro, rifiutata ovviamente dalla filosofia epicurea, tuttavia conserva qualche elemento di raccordo, poiché rappresenta, in alcuni punti, la natura come un’entità benevola che spontaneamente offre il sostentamento alle “umane belve”. Perciò, pur negando la terra miracolosa celebrata dai poeti antichi con i suoi fiumi di latte e miele, sostiene che la terra nella sua giovinezza sfamasse gli uomini con la sua natura ubertosa e ricca di frutti selvatici e li dissetasse con i suoi vorticosi e copiosi corsi d’acqua.
Lucrezio “De rerum natura”, (V, vv.937-945)
Quel che il sole e le piogge gli davano, quello che la terra produceva spontaneamente era un dono sufficiente per accontentare i cuori. La ghianda della quercia costituiva per lo più il loro cibo; e quei frutti che ai giorni nostri vedi maturare in inverno e colorarsi di porpora, le corbezzole, la terra le produceva allora più numerose e più grosse: Il mondo, nel fiore della sua novità, faceva crescere in abbondanza una grossolana pastura, sufficiente per i miserabili mortali. Per calmare la sete, si recavano al richiamo dei ruscelli e delle sorgenti.
Lucrezio accetta i dati oggettivi e scientifici della rappresentazione epicurea della natura con la finalità di offrire ai suoi contemporanei una conoscenza razionale scevra da elementi mitologici e favolistici legati alla presenza di un apparato divino, ritenuto colpevole di instillare terrore negli uomini, tuttavia prova una vena di nostalgia per quello stato d’innocenza di un’umanità istintiva immersa in una natura selvaggia, sebbene talvolta essa fosse destinata a soffrire a causa dei pericoli: belve feroci, intemperie, catastrofi, morti violente. Al contrari, ne rileva aspetti positivi dal momento che non si conoscevano le lotte fratricide, le guerre, gli intrighi della società civile. Lucrezio, sebbene in più passi la definisca madre benigna, nel corso del poema fa emergere il suo pessimismo perché sostiene che la natura sia ostile all’uomo: ci presenta la vita terrena come luogo di sofferenza in cui l’uomo è costretto a una lotta impari contro una natura onnipotente, indifferente e crudele, preannunciando così la concezione leopardiana della natura matrigna che in Lucrezio trova uno dei suoi fondamenti.
Ecco, infatti, una descrizione della potenza a volte indomabile della natura:
De rerum natura (V, vv. 197-221)
[…] la natura del mondo non è stata assolutamente generata per noi da una volontà divina: Tanto si presenta intaccata da difetti. Prima di tutto, le montagne e le foreste piene di belve hanno conquistato una enorme parte di questa terra coperta dall’immenso slancio del cielo; un’altra parte è occupata da rocce e da vaste paludi deserte; un’altra dal mare le cui larghe distese separano le rive dei continenti. Quasi due terzi del suolo vengono sottratti ai mortali o da un calore torrido o dalla caduta incessante della neve. Quel che resta di terreno coltivabile, poi, la natura, lasciata a se stessa lo farebbe sparire sotto i rovi, se lo sforzo dell’uomo non glielo disputasse, se il bisogno di vivere non lo avesse abituato a gemere sotto la pesante zappa, a fendere il suolo premendo sull’aratro. Se non rivoltassimo col vomere le glebe feconde, se non preparassimo il suolo per farli dischiudere, i germi non potrebbero sbocciare da soli e comparire all’aria luminosa. Ancora troppo spesso questi frutti guadagnati con tante pene, li vediamo, quando tutto sopra la terra si copre di foglie e di fiori, o bruciati dall’ardore eccessivo del sole etereo, o distrutti da piogge improvvise o dai bianchi ghiacci, o trascinati dai venti che soffiano in turbi distruttori. Le specie temibili degli animali feroci -nemici accaniti del genere umano- perché mai la natura si compiace di nutrirli e moltiplicarli in terra e in mare? Perché le stagioni dell’anno i portano malattie? Perché su vede vagare qua e là la morte prematura?
Nei versi 222-227 del libro V, segue l’apparizione del bambino-naufrago rappresentativa della condizione umana:
“E il bimbo, simile al marinaio che i flutti furiosi hanno rigettato sulla riva, giace, tutto nudo , per terra, incapace di di parlare, sprovvisto di tutto ciò che aiuta a vivere, dall’ora in cui, gettandolo sulle rive bagnate della luce, la natura lo strappa con sforzo dall’utero materno, riempie l’aria con vagiti lamentosi, com’è giusto per chi la vita riserva ancora tanti mali da sopportare”.
In Lucrezio è dunque presente una concezione antiprovvidenzialistica: la natura non è stata creata per volere divino a favore degli uomini, ai quali pertanto non resta che tentare di sottometterla con immani sforzi, per poterne ricavare il necessario sostentamento. E’ lontana dunque l’età dell’oro, mondo ancestrale in cui vigeva un rapporto idilliaco tra uomo e natura in una condizione di eterna armonia, luogo di perfetta pace e sintonia voluto da una divinità. Quest’elemento crea, a mio avviso, una sorta di legame tra mondo pagano e cristiano e ne è prova la rappresentazione dell’Eden biblico, che il sincretismo di Dante, sulla base dell’interpretazione figurale tipica della mentalità medievale, ci espone in una descrizione del Paradiso terrestre, (collocato sulla sommità del Purgatorio), che parte dalla Bibbia, ma s’ispira a quella dell’età dell’oro che, in tal modo, diviene la prefigurazione dell’Eden cristiano. Matelda, la donna che Dante, Virgilio e Stazio vi incontrano, è l’enigmatica figura simbolica che rappresenta l’innocenza originale, la condizione di perfetta felicità dell’uomo, immune dal peccato, nel momento in cui è collocato nel Paradiso terrestre. Ella si rivolge a Virgilio e Stazio dicendo loro che i poeti antichi, che cantarono la mitica età dell’oro e la felicità primordiale dell’uomo, forse la sognarono nelle loro fantasie poetiche e che i progenitori del genere umano conobbero l’innocenza, in un luogo dove era sempre primavera e crescevano frutti di ogni tipo. Dante si volta verso i due poeti che sorridono nell’udire l’ultima parte del discorso di Matelda, la loro gioia è dovuta al riconoscimento da parte di Matelda della loro grandezza poetica, in quanto avevano parlato dell’età dell’oro preannunciando il Paradiso terrestre, ma nello stesso tempo la loro poesia risulta limitata perché e’ assente la fede e l’illuminazione della grazia di divina.
Quelli ch’anticamente poetaro
l’età de l’oro e suo stato felice,
forse in Parnaso esto loco sognaro. 141
Nella successiva terzina sono evidenti i richiami alla descrizione ovidiana sopraccitata, ma rielaborati dalla straordinaria capacità di sintesi dantesca, che ne condensa il significato esprimendolo in una sola strofa.
Qui fu innocente l’umana radice;
qui primavera sempre e ogne frutto;
nettare è questo di che ciascun dice”. 144
Quest’età primigenia di perfezione è ripresa anche in età umanistica – rinascimentale e spesso rielaborata, reinterpretata e associata a paesaggi bucolici e idilliaci che divengono luoghi ideali per rappresentare la componente edonistica dell’epoca, (basti pensare a Poliziano, Sannazaro e altri), che però conosce la crisi verso la fine del Cinquecento con Tasso, che ne diventa portavoce e interprete. Nell’“Aminta”, dramma pastorale, egli inserisce la concezione dell’età dell’oro e, al contempo, la sua fine: la utilizza per dimostrare che, nella mitica età primordiale, gli uomini vivevano liberi e felici nella serenità della natura e l’amore era un sentimento puro, incontaminato e poteva essere vissuto liberamente senza falsi pudori o remore di natura morale. Perciò Tasso è convinto che la causa della fine di quest’atmosfera genuina e innocente sia stata causata dall’Onore (che egli personifica), che rappresenta il valore dominante nella vita delle corti ed è dettato dal clima oppressivo della controriforma che ingabbia la vita quotidiana in una serie di norme e convenzioni talvolta ipocrite che impediscono di vivere liberamente i sentimenti e gli impulsi erotici. Solo in apparenza, infatti, Tasso utilizza il modello ovidiano, evidente nella prima strofa, riprendendone molte immagini, ma subito ne sancisce il superamento nella seconda strofa, pertanto l’età dell’oro era bella non solo per il tripudio della natura che garantiva un’esistenza di libertà e serenità perfetta negli individui, ma perché non esisteva l’Onore, che ha distrutto definitivamente quell’aurea norma dettata dalla natura “S’ei piace, ei lice”. Pertanto Tasso supera la visione della tradizione classica e la sostituisce con una visione inquieta dell’esistenza: il tutto ha lo scopo di enfatizzare la sua estraneità alla cultura del tempo, caratterizzata appunto dalla cristallizzazione delle norme di comportamento e dal rigido conformismo che spegne ogni forma di spontaneità e costringe il poeta a vagheggiare atmosfere idilliache per evadere da una realtà angusta e mortificante.
|
ma sol perché quel vano nome senza soggetto, quell’idolo d’errori, idol d’inganno, quel che dal volgo insano onor poscia fu detto, che di nostra natura ‘l feo tiranno, non mischiava il suo affanno fra le liete dolcezze de l’amoroso gregge; né fu sua dura legge nota a quell’alme in libertate avvezze, ma legge aurea e felice che natura scolpì: «S’ei piace, ei lice». |
|
O bella età de l’oro,
non già perché di latte sen’ corse il fiume e stillò mele il bosco; non perché i frutti loro dier da l’aratro intatte le terre, e gli angui errar senz’ira o tosco; non perché nuvol fosco non spiegò allor suo velo, ma in primavera eterna, ch’ora s’accende e verna, rise di luce e di sereno il cielo; né portò peregrino o guerra o merce agli altrui lidi il pino; |
Tasso, Aminta, atto I, coro (vv.319-344)
;
ma sol perché quel vano
nome senza soggetto,
quell’idolo d’errori, idol d’inganno,
quel che dal volgo insano
onor poscia fu detto,
che di nostra natura ‘l feo tiranno,
non mischiava il suo affanno
fra le liete dolcezze
de l’amoroso gregge;
né fu sua dura legge
Battista Guarini, contemporaneo, rivale e allo stesso tempo emulo di Tasso, non è della sua stessa opinione e rovescia il mito di un’età dell’oro in cui ogni cosa piacevole era giusta, legittima e attuabile, sostituendone una il cui motto diventa “piaccia, se lice”: utilizza perciò il modello di descrizione del coro dell’Aminta, quasi parafrasandolo, ma esalta proprio quell’elemento cui Tasso attribuiva la fine dell’età dell’oro, cioè l’Onore e si uniforma pertanto all’ideologia dominante dell’età della controriforma. (Dal “Pastor fido” coro atto IV vv.15-26.)
15 Quel suon fastoso e
vano,/ quell’inutil soggetto/ di lusinghe, di titoli e d’inganno,/ ch’“onor”
dal volgo insano
indegnamente è detto,/non era ancor degli animi tiranno. Ma sostener affanno/per
le vere dolcezze;/ tra i boschi e tra le gregge/ la fede aver per legge,/ fu di
quell’alme, al ben oprar avvezze,/ cura d’onor felice,/ cui dettava Onestà: “Piaccia, se lice”.
Il Tasso tuttavia, non esaurisce nel suddetto coro dell’Aminta il rimpianto per un’età di perfetta armonia tra l’uomo e la natura di cui rimangono le ultime vestigia solo nell’ambiente semplice dei pastori e, in un meraviglioso passo del canto VII della “Gerusalemme Liberata”, ci presenta una comunità pastorale immersa in una natura mite e benevola, priva di ogni forma di violenza e di male: Erminia, in fuga e inseguita dai crociati, giunge presso una comunità di pastori e in un locus amoenus idilliaco, descritto secondo i canoni topici, stremata, si addormenta (canto VII, ottava V):
|
Non si destò finchè garrir gli augelli non sentí lieti e salutar gli albori, e mormorar il fiume e gli arboscelli, e con l’onda scherzar l’aura e co’ i fiori. Apre i languidi lumi e guarda quelli alberghi solitari de’ pastori, e parle voce udir tra l’acqua e i rami ch’a i sospiri ed al pianto la richiami |
.
Al suo risveglio, s’imbatte in un pastore che le descrive quella povertà da tutti negletta e aborrita come il punto di forza di una vita felice in perfetto accordo con la natura, in cui non ci sono bramosia di potere, necessità di guerre, cupidigia di beni materiali.
|
Ché poco
è il desiderio, e poco è il nostro bisogno onde la vita si conservi. Son figli miei questi ch’addito e mostro, custodi de la mandra, e non ho servi. Cosí me ‘n vivo in solitario chiostro, saltar veggendo i capri snelli e i cervi, ed i pesci guizzar di questo fiume e spiegar gli augelletti al ciel le piume. |
|
Altrui vile e negletta, a me sí cara che non bramo tesor né regal verga, né cura o voglia ambiziosa o avara mai nel tranquillo del mio petto alberga. Spengo la sete mia ne l’acqua chiara, che non tem’io che di venen s’asperga, e questa greggia e l’orticel dispensa cibi non compri a la mia parca mensa |
Canto VII (ottave IX-X)
Il Tasso dunque utilizza un motivo topico, (inserendosi nel solco della tradizione), conferendogli però significati differenti, come già accennato, in primis la polemica anticortigiana, il rifiuto dell’austerità controriformistica che hanno come conseguenza la necessità e l’impulso irrefrenabile di rifugiarsi in atmosfere bucoliche e pure, luoghi per eccellenza deputati a realizzare quella propensione al gioioso edonismo che purtroppo è divenuto un paradiso perduto proprio come la mitica epoca. Al poeta, animato da quest’amara consapevolezza, non resta che evadere vagheggiando il sogno di immergersi nel mondo pacifico e innocente dei pastori in un rapporto di armonia e simbiosi perfetta con la natura. Perciò attraverso il filtro dell’età classica, egli reinterpreta il mito e diviene epigono della primitiva e felice età dell’oro.
Bibliografia
Virgilio, Bucoliche, a cura di Luca Canali ,BUR ,Milano, 1988.
Lucrezio, La natura, a cura di A.Ronconi e O.Cescatti , Garzanti, Milano, 1983.
Ovidio, Metamorfosi ,a cura di P. Bernardini Marzolla, Einaudi, Torino, 1994.
Tibullo in Lirica Latina, a cura di E. Cetrangolo, Sansoni, Milano, 1993.
Per gli altri testi latini citati: “La letteratura latina” a cura di M. Bettini, La Nuova Italia, Firenze, 1999.
Dante, Purgatorio, a cura di Bosco-Reggio, Le Monnier, Firenze, 2002.
Tasso, Aminta, in “La letteratura”, vol.2 a cura di G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Paravia, Varese, 2006.
Guarini, Pastor fido in “Cuori intelligenti”, letteratura italiana vol.1, a cura di C.Giunta, De Agostini Scuola, Novara, 2016.
Tasso, Gerusalemme Liberata, a cura di E. Camerini, Sonzogno, Milano 1887.
L’immagine di copertina è L’età dell’oro di Pietro Da Cortona (Immagine presa da fammentiarte.it)