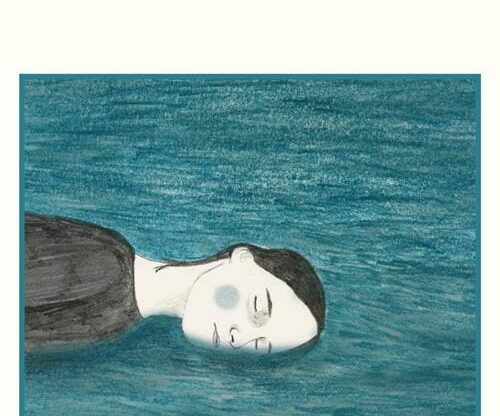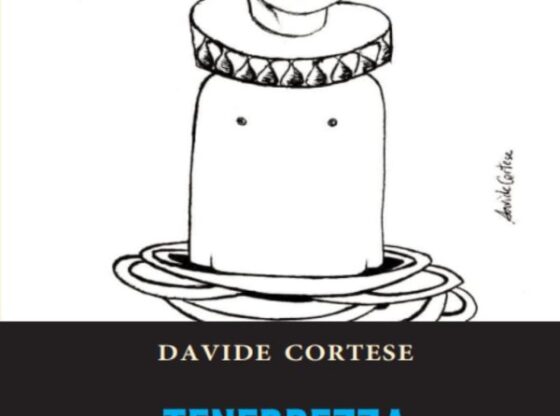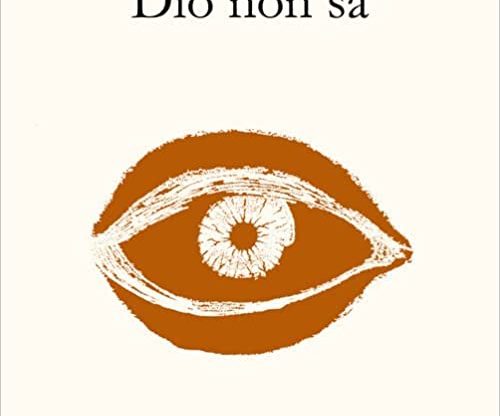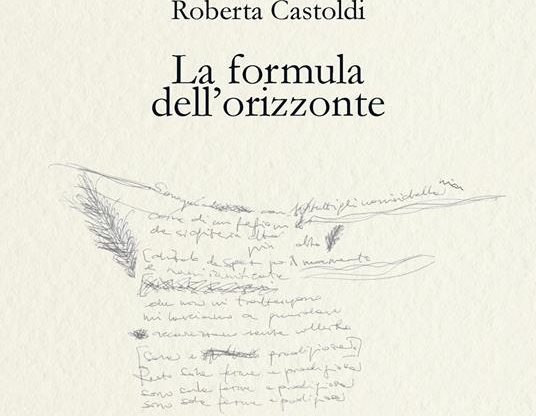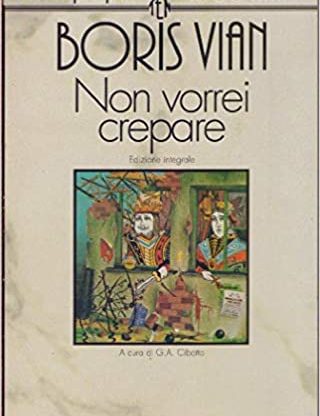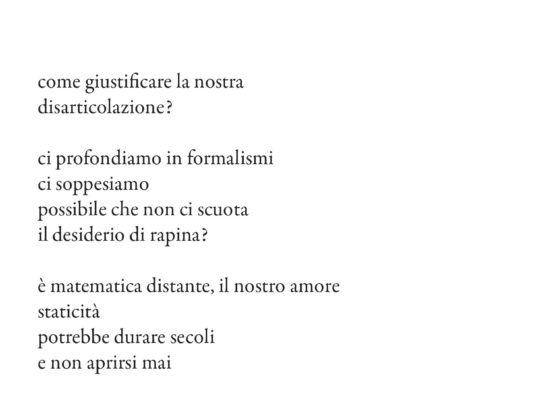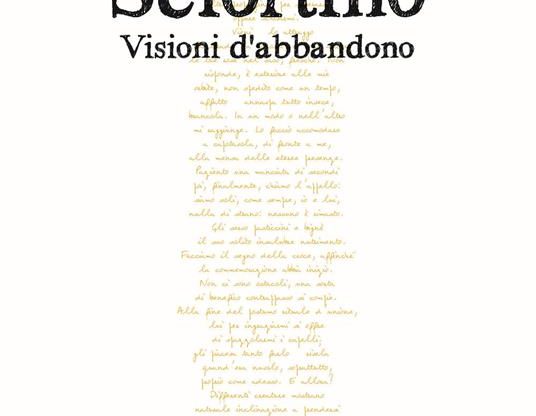Furibondiadi
Di sbieco
Un’altra volta ho portato a spasso
la mia sulfurea eccentricità
raminga, segretamente laboriosa,
ma a vista nuda e plateale, agli
occhi della gremita occhiuta e
perplessa tribuna, fannullona e
scioperata, per la strada di questa
metropoli catalana nella qualche
vivacchio a più non posso, senza
riconoscere né le strade nè le
case,
se non qualche davanzale fiorito,
se non qualche semaforo verde.
Fissavo, introflesso e di sbieco, la
mia interiorità assente, o
baluginante di inesistenze e vivide
presenze, lampeggianti piraña
dello spirito, chiedendomi se stavo
male o bene, la quale era forse,
e di prematuro ormai, l’unica
domanda che mi importava,
insieme a come
sarei finito. Male, mi sogghignava il
mio fatuo deragliamento di perso
in altri cieli d’esilio disvoluto;
sviandoti, incalzava il il caparbio
e occhiuto diavolo della
dispersione che scompigliava le
carte e
sbalestrava vari uccelli policromi
davanti agli occhi del fosco ed
ilare pènsiero.
Sono tornato, con minuscole
sapienze orientali, biascicate, nella
casa nella quale dormo, e respiro
a fatica (dirla mia, sarebbe
pretenzioso, e il mio friggere,
situazionista, di azzurra anarchia
sovversiva s’inarbolerebbe; lei
abita me, o mi disabita,
riempendosi
di tutti quei libri -che tolgono la mia
voce vera, o la rendono afona
e sbiadita; e invorticata, con fili
spessi di ragnatele altrui- nella
boccetta della lampadina a
sinistra: libri…. amici o nemici,
complici di un ritiro e di un
assopimento, scaltrissimo e
lesto…?).
Accompagnato dalla violacea
angustia del sarcasmo ho voluto
rimpiangere, appena istrionico
nell’esibizione del nervo del
sentimento, attimi di
sprofondamento infantile, quando
uno è tutto
dentro l’istante: il tempo è da un
bel po’ che è andato in frantumi,
e uno si chiede se prenderlo o
perderlo sia la filosofia migliore
(d’accordo, voi attenti, si potrebbe
chiosare distinguere: ma il
sofisma e il sofisticato meditare
tradirebbero la salutare
immediatezza magnanima; e
invischierebbero con le lamette
aguzze
dell’analisi crudele, il vivido
palpitare dentro il cosmo ruotante,
dall’essenza immobile).
Con diligenza impettita e irrigidita,
allora, sollecito al richiamo
dell’angelo custode, fredde le dita,
occupate dal gelo stesso della
morte, mi sono chinato al lavoro,
con il vestito buono, e le scarpe in
ghingheri. Ora scrivo e questo mi
separa da quello che vivo, ma mi
ridona pure alla vita, la quale è sì
sconosciuta, ma pure generosa,
infinita; o così mi dice la scala, di
traverso, appoggiata a quella
colonna, a due dita dal mare, nel
mondo rotondo, che trasecola,
assai
di soppiatto, compiaciuto di sé,
nella propria abbondanza di
mándala,
balzano e transitorio.
*******
… e la vita, ballerina
degnissima, se ne va, scorre
via. impercepita e frigida, mentre
lui, attorto di vacuo, pensa che il
passo che fa, non
sia il passo, e lo sguardo che
guarda, sia esso timido o timorato
o
audace o temerario, non sia lo
sguardo ma un’ipoteca di futuro,
che
si appaga di concatenazioni,
successioni immaginate, catene e
filamenti.
Si vive come se ci fosse tempo, o
se il tempo fosse tempo compatto,
mentre fiochi friabili minuti lo
attraversano invisibili, di spine e
chele, aghiformi trapassi
ammutoliti, e lui si affretta e tenta
con
ferita premura, zelante di ghermire,
con il vuoto nelle lastre delle
dita, nel respiro lieve di
spolverante gelo, con il braccio
veloce, di
dissolvenze aeree: e, applicato,
dilata e concentra e elude e
rimanda.
E addio gli dicono gli esperti dei
gufi, addio le nuvole in polvere e
le cerule titubanze della fermezza,
addio le impervie sonate delle
lontananze, e lo scroscio delle
aspirapolveri, e le felci e le
vacanze
dei presunti.
Si sa che l’attesa corrode la
presenza e depotenzia la realtà, la
sottrae e sfigura. Ed è crudele il
domani di chi non conosce l’oggi, e
ignora, o misconosce, il dominio.
Ma conoscere è tagliare, e non ci
vuole il taglio, ma il laccio e il
passo, quel passo, il respiro di
un fiato fioco, quel fiato di soffice
respiro e neve che asseconda le
pieghe del possibile e possiede
flessuosità che non inciampano,
ma
contano su una appartenenza
sfilacciata, che si svita
nell’abbraccio svagato che
interrompe; precisamente così,
proprio in
questo modo, davvero bene.
L’immagine di copertina è The shipwreck di William Turner, 1805
Presa da Artribune