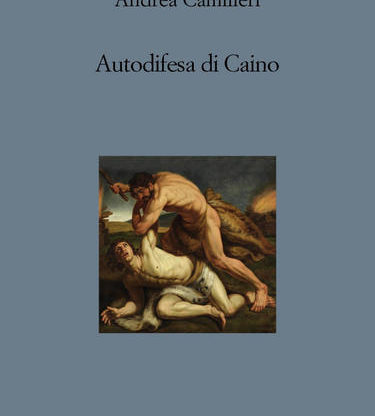Da questo testo, “Monologo della buona madre” con la sua compagnia Barletti/Waas (composta da Lea e dal suo compagno nella vita e sulla scena, Werner Waas) è stato tratto lo spettacolo omonimo che ha debuttato il 3 agosto nel Festival ” i Teatri della Cupa” a Novoli (Le).
Prima, a marzo sempre di quest’anno, ne era stata fatta una semplice lettura scenica al Teatro I di Milano.
MONOLOGO DELLA BUONA MADRE
testo: Lea Barletti
regia: Lea Barletti/Werner Waas
paesaggio sonoro: Maurizio Vierucci
con Lea Barletti
e con la partecipazione in scena di Werner Waas
“Monologo della buona madre” è una confessione, una confessione in pubblico. Una confessione e un’ammissione di incapacità. Incapacità di vivere tout court, forse, o comunque incapacità di vivere al di fuori dello sguardo dell’altro. Ed è l’ammissione di quanto proprio la ricerca, nello sguardo altrui (che sia lo sguardo degli spettatori o lo sguardo della comunità umana cui si appartiene), di una sorta di “permesso d‘esistere”, possa essere il motivo per cui si va in scena: “Guardami, ascoltami, amami; fa’ che io sia!” è la richiesta, più o meno esplicita, più o meno sottintesa. Dunque, non si tratta solo di una donna, di una madre, che ha sempre voluto essere amata, ma anche di un’attrice, e del motivo profondo del suo agire in scena.
“Monologo della buona madre” affronta uno degli ultimi Tabù della società occidentale: quello della maternità. Cosa vuol dire essere una “buona madre”? Quale madre non si è sentita, almeno una volta, inadeguata e insicura? E se un giorno si dovesse scoprire di non corrispondere, o di non voler corrispondere, al modello di “buona madre” vigente e richiesto? Di non essere adatta al ruolo così come è stato scritto? E da chi è stato scritto, questo ruolo, e per chi? E perché non è possibile riscriverlo? Essere “Madre” è un ruolo, ma un ruolo che non può essere assunto nella stessa maniera da ogni donna. Ci sono tanti modi di essere madri quante donne ci sono che lo diventano. E ci sono tanti modi per essere una buona madre. Ma questo non te lo dice nessuno, prima, e nemmeno durante: è una cosa che si scopre da sole, dopo, e dolorosamente, sulla propria pelle, a costo di enormi sensi di colpa, a costo di errori, passi falsi, dubbi, fallimenti. E a costo di sogni, tempo, energia, amore: a costo della vita.
Ma “Monologo della buona madre” è anche una storia di “vocazione”, la storia di una vocazione artistica e del faticoso percorso intrapreso per trovarle un posto nel mondo, la storia di qualcuno che, attraverso e nonostante mille inciampi, dubbi e insicurezze, sente la necessità forte e reale di trovare una propria lingua, e per suo mezzo compiere un atto che dia nascita e forma, a suo modo, ad un mondo: un atto di creazione artistica.
“Monologo della buona madre” è la storia di un corpo a corpo: un corpo a corpo di una donna e di un‘artista con se stessa ed il proprio corpo, appunto, con la propria coscienza, con il proprio ruolo di madre, con i figli, con l’immagine di sé, con il proprio essere artista, con i propri modelli, con le proprie aspettative, con la propria inadeguatezza, con la propria vocazione, con la propria fallibilità, con la propria creatività, con il tempo, con la vita, con la lingua, con l’amore.
Una donna, da sola in scena. Seduta su un piedistallo, come un oggetto da esposizione o un monumento: “Buona Madre / Tecniche e materiali misti”, recita la targa applicata sul piedistallo. Durante il suo monologo faranno la loro apparizione in scena, come altrettanti oggetti da esposizione/testimoni, il padre/marito, alcuni oggetti quotidiani, delle fotografie.
La donna inizia il suo discorso dichiarando la propria intenzione di andarsene. Non se ne andrà, perché non c’è vita, per lei, come persona e come attrice, al di fuori dello sguardo altrui. Perché non c’è mondo se non quello che si crea nel discorso tra simili, e il teatro è questo discorso, come bene avevano capito i greci. Il mondo, la vita, è quello che succede tra le persone mentre si parlano: quello che succede tra l’attore e lo spettatore. Il mondo è qui, è adesso, è il teatro.
Alcuni estratti del monologo
Pensavo. Pensavo: adesso smetto. Adesso smetto di sentirmi in colpa. Se chiudo gli occhi, adesso, e guardo nel buio qui dietro le palpebre dove mi trovo quando chiudo gli occhi, e se cerco in mezzo a tutti quei vermetti luminosi, se mi cerco lì in mezzo, io mi vedo: seduta su una sedia come in effetti sono, con le mani appoggiate sulle cosce come in effetti sono le mie mani, e anche se intorno continuano a svolazzare i vermetti fosforescenti luminosi, anche se intorno c’è tutta quella eterna confusione di domande, di voci, di presenze, io sorrido, ecco, proprio così, come in effetti sto facendo, e, sorridendo, smetto di voler sempre fare tutti contenti. (Breve pausa)
E poi, quando ho respirato per bene tutto questo silenzio che c’è dentro, tutto questo buio, quando ho respirato bene tutto questo fresco e vuoto che viene su, sempre continuando a sorridere, ma senza chiedere scusa, io adesso apro gli occhi, mi alzo e me ne vado. Mi alzo da qui e me ne vado, e lo ripeto: non chiedo neppure scusa. E non m’importa se non siete contenti. Non m’importa se vi dispiace. Io vado. E se uno di quei vermi luminosi, uno più grande degli altri, uno particolarmente ostinato, prende a scivolare, scivola, nel padiglione auricolare con la sua scia di bava trasparente, biascicando lungo il condotto che voi mi vorrete per questo meno bene, io non lo ascolto e no, non m’importa. E se lo sento spingersi più dentro, e suggerirmi che, peggio ancora, a voi non ve ne frega proprio niente, allora io ecco, io adesso lo stritolo, lo schiaccio all’interno del mio orecchio medio, tra gli ossicini della staffa, prima che strisci attraverso l’endolinfa del condotto cocleare e trasmetta il suo infame messaggio qui (Si tocca la fronte. Breve pausa). […]
Lei, alla guida sull’autostrada, un lungo viaggio, una delle rare volte senza il padre, i figli, dietro, dormono tranquilli. Traffico. Camion che superano, macchine che si incollano al culo dell’auto con prepotenza. Le mani strette sul volante, lo sguardo avanti, con un occhio allo specchietto retrovisore. Sorpassi, tensione, un po’ di stanchezza. Sente la presenza quieta dei bambini, il loro sonno pieno di fiducia. Ogni tanto, li guarda brevemente nello specchietto, le teste abbandonate nel sonno, le bocche socchiuse, i volti distesi. Ad un tratto, da un un punto oscuro e sconosciuto nel fondo di un’ancora più oscura e sconosciuta se stessa, avverte arrampicarsi su per la spina dorsale un ragno enorme di assoluta inadeguatezza, e, da lì, piantarsi nel centro del petto, premendo con la forza di un’invasione: la responsabilità tangibile e concreta di quelle due piccole vite tanto amate improvvisamente la sovrasta. Si scopre a mormorare: non sono capace, non fa per me, questa è una cosa da adulti veri, io non sono un’adulta vera. Le macchine le sfrecciano accanto ad una velocità inverosimile – Ho così tanta paura, bambini – vorrebbe confessare. – Mamma tra quanto arriviamo?- farfuglia poco dopo, svegliandosi, il più grande. – Ancora un paio d’ore – risponde la madre – hai fame?-
Perché un genitore, per un bambino, è… dovrebbe essere qualcuno che gli spiega il mondo e come funziona, un modello, un esempio, qualcuno che le cose le sa fare, che le conosce e le spiega. Saper fare le cose versus non saper fare le cose. (Pausa)
Lo vedete? No voi non potete vederlo, ma io sì, è come se ci fosse, ma dentro, proprio dentro di me, un altro di quei vermi fosforescenti, ma questo è uno grosso, grossissimo, lungo, tutto attorcigliato lungo… lungo la spina dorsale, aggrappato, proprio, e le sue vibrisse terminali mi si infilano nel tronco encefalico, e attraverso tutti quei peduncolini e terminazioni nervose sottilissime che ci sono da quelle parti, la sua voce mi arriva direttamente qui, alla base del cervelletto, dietro la nuca: BUONA A NULLA. Buona a nulla. Buona a nulla. (Pausa)
In effetti, l’elenco delle doti e delle incapacità sarebbe ancora lungo. Ma fermiamoci qui, per carità (esita) e poi, poi io so fare dei dolci buonissimi, torte e biscotti di vario tipo, ho un vero talento per i dolci, una passione, proprio… (pausa)
Ha… Ho iniziato da ragazzina, la notte, la notte quando non riuscivo a dormire. Non riuscivo a dormire ma non riuscivo neanche a leggere, anche se ci provavo, infatti dopo un po’ che me ne stavo lì a cercare di prendere sonno, accendevo la lucetta sul comodino, ma ecco, ero troppo stanca, e i caratteri del libro tremavano, si muovevano tutti sulla pagina, allora posavo di nuovo il libro sul comodino, e richiudevo gli occhi, ma a quel punto era ancora peggio, era come se la pagina del libro si fosse impressa nella mia mente, e non riuscivo a fare buio negli occhi, c’era quella luce, eppure l’avevo spenta, e le parole soprattutto, le parole che vibravano nella luce, e sembravano vive, troppo vive, e infatti uscivano via dalla pagina, dai bordi, e a un certo punto erano dappertutto, nere e luminose, come poi potessero essere nere e luminose allo stesso tempo non lo so, ma lo erano, e poi si scomponevano e le lettere se ne andavano in giro per conto loro, e a volte formavano, formavano nuove parole, e frasi, e improvvisamente ecco una scritta, grande, come un neon nero e luminoso: NON CE LA FARAI MAI – ma cosa, cosa? – e dopo un po’: A LEGGERE TUTTI I LIBRI e io sapevo che non voleva dire tutti i libri della libreria di casa, no, e nemmeno tutti i libri della biblioteca comunale, no, quella scritta voleva proprio dire: non ce la farai mai a leggere tutti i libri che sono stati scritti. E allora di botto mi alzavo, e andavo in cucina, mentre tutti dormivano, e prendevo un libro di cucina, IL TALISMANO DELLA FELICITA’, e, visto che la prometteva così, a lettere dorate, io la cercavo, la felicità, la cercavo, o almeno qualcosa che gli si avvicinasse il più possibile, la cercavo, di notte mentre tutti gli altri dormivano, in un libro di cucina. Così ho imparato a fare la pasta frolla, e il pan di spagna e (esita) – No, la pasta sfoglia, non ho mai imparato. […]
[…] E io, cosa gli ho insegnato io? Che poi magari qualcosa, se mi sforzo, se ci penso, gliel’avrò pure insegnata, ai miei figli, qualcosa di pratico, che ne so, a fare il sugo, vabbè, sai che gran cosa, non si resta negli annali della storia familiare per aver insegnato a fare il sugo, che poi io per esempio ho imparato da sola a farlo, almeno che io mi ricordi, e… (pausa) appunto. (pausa) Comunque, non è che poi me ne freghi più di tanto, questo lo hanno imparato da me, questo da te: può darsi, insomma magari non è davvero così importante… o comunque ecco, magari non ci penserei neppure, se non fosse, se non fosse che, sentendomi così assolutamente priva di qualsiasi capacità, mi sento evidentemente, DI CONSEGUENZA assolutamente indegna… indegna di…(pausa) e penso quindi di dovermelo guadagnare, quest’amore benedetto, sudare, con la dedizione più assoluta e totale, la presenza, l’abnegazione e la disponibilità continue, incondizionate. D’altra parte, l’amore materno è per antonomasia amore IN CON DI ZIO NA TO. Non esiste amore materno condizionato, mi pare. Si possono amare condizionatamente i propri figli? (Pausa. Guarda gli spettatori)
[…]
Comunque. (pausa) Ho allattato al seno per un anno e mezzo tutti e due i figli, pure con la mastite e le ragadi – sapete cosa sono, no? – un dolore atroce, ma il paradiso bisogna pur guadagnarselo, come ci hanno ficcato ben bene nei nostri ancora acerbi spugnosi cervelletti di brave bambine cattoliche, bisogna guadagnarselo, soffrirselo, quest’amore eterno, il posto nell’olimpo dei genitori amati, venerati e mai dimenticati… quel legame indissolubile… come altro te lo guadagni sennò, se non con, sì, ecco, appunto, con il corpo! Almeno è sicuro, ce l’ho, è mio, il corpo, questo qui, questo, e il seno, e il latte, il LATTE, nessuno può allattare i miei figli al posto mio, nessuno meglio di me, voglio dire, questo è il mio regno, finalmente. (Pausa)
Ma poi, vengono certi pensieri… secondo me tutta la campagna per l’allattamento materno, a ben vedere, è una cosa… qualcosa su cui riflettere, ecco, cioè sì certo, e va bene, lo so, il latte materno è la scelta migliore, è insostituibile, l’alimento perfetto, contiene tutti gli elementi nutritivi necessari, gli anticorpi e bla bla, bla, lo so, il rapporto unico e privilegiato che si instaura con il bambino, e poi vuoi mettere, dall’altra parte: il latte artificiale, chissà cosa ci mettono dentro, le multinazionali e gli interessi economici che ci sono dietro al latte in polvere, roba da banditi, e di certo la natura fa le cose per bene, e allora, eccetera e insomma tutte quelle belle storie edificanti con cui ti fanno digerire e beatificare gli interminabili mesi in cui ti trasformi… in centrale per la produzione intensiva del latte. E mi raccomando eh, che sia chiaro: è una tua libera scelta, ci mancherebbe. (Pausa)
Ma di cosa si tratta, infine, se non di una battaglia. E il corpo, il corpo come unico territorio possibile di questa sanguinosa battaglia per l’amore.
[…]
“I sassi, i ciottoli, quelli levigati dall’acqua, in riva al mare, o sul greto di un fiume, il lavoro fatto dal tempo, dal rotolare continuo insieme ad altre migliaia di sassi, l’evidenza degli strati, della materia, il mutamento lento pur nella permanenza, le linee che compongono un disegno che non poteva essere che quello, casuale, perfetto, privo di significato, bellissimo. Essere come quei sassi, avere un destino solido, minerale, inevitabile. Esistere in un punto dove l’acufene del dubbio non incrini di continuo la fragile consapevolezza del diritto ad essere esattamente come si è. “
[…]
Lea Barletti e Werner Waas si sono conosciuti molti anni fa a Roma. Da allora vivono e lavorano insieme, prima a Roma, poi a Monaco di Baviera, quindi a Lecce e attualmente a Berlino. Hanno fatto due figli, insieme.
Per alter informazioni visitate il sito www.barlettiwaas.eu
La foto in copertina è di Daniel Nartschick
 Monologo della buona madre
Monologo della buona madre
Teatro