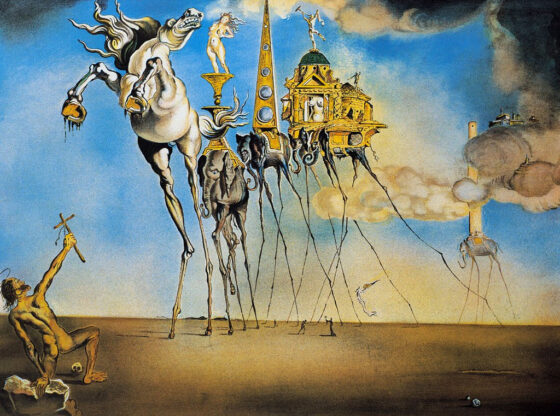Quello delle ferrovie dismesse è argomento affascinante ma anche assai serio. Perché una ferrovia dismessa racconta della politica di un paese, del suo interesse o disinteresse verso ciò che resta, comunque, un patrimonio inestimabile. Oltre che uno sviluppo mancato. Quello della rete ferroviaria appunto. Con tutto ciò che comporta in termini di isolamento per molti paesi della nostra penisola. In Italia, soprattutto negli anni del dopoguerra, l’industria automobilistica andava sostenuta. E, in Italia, questo ha significato sostenere la FIAT e il trasporto su strada. Le strade sono divenute, nella retorica dello sviluppo, i “luoghi” principali sui cui far viaggiare merci e persone. A discapito delle ferrovie. O, per lo meno, di molte di esse. Un racconto come quello che segue è, dunque, anche un modo per recuperare e per ricordare non solo un mezzo di trasporto ma una più generale visione della vita. L’articolo è apparso su La Lettura in edicola nella settimana che andava dall’8 al 14 ottobre.
Tempi di paura e di natura sui trenini di latta
Ricordi d’infanzia Quella ferrovia dismessa nelle memorie dello scrittore marchigiano
Una parte della campagna di Fermo, dove una volta passava il treno, stava sotto casa mia, e da bambino era il mio mondo, lì mi piaceva allontanarmi e perdermi al tramonto, camminare sul sentiero di terra battuta dove una volta correvano le rotaie, quando il buio cominciava a scendere sulle colline intorno. Eravamo a metà degli anni Sessanta, da dieci la ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola era stata dismessa, ma i solchi paralleli anche allora segnavano il percorso e ai lati potevi ancora vedere i muretti controterra, ferri arrugginiti di scambi, e immaginare quando il convoglio sferragliava perdendosi nelle curve inghiottito dalla macchia.
Mio padre, invece, con altri ragazzini delle campagne o del proletariato urbano, prima del passaggio dell’elettromotrice, che da pochi anni aveva sostituito le locomotive a vapore Ganz, a metà degli anni Trenta andava a mettere grandi pietre sulle rotaie, con l’idea folle che al passaggio il treno potesse deragliare. Dopo aver compiuto quella scelleratezza, i ragazzini in brache corte e maglie logore, i berretti in testa, eccitati aspettavano nascosti dentro le fratte in attesa del disastro ferroviario. Più volte negli anni lui ha raccontato a noi figli e ai nipoti di quel treno, dove aveva viaggiato molte volte, soprattutto quando andava a fare visita a suo zio Pietro Pelloni, direttore del Consorzio Agrario di Amandola. «Correva veloce solo in discesa», diceva divertito, per farci capire come allora era diverso il mondo, «in salita procedeva a passo d’uomo, tanto che d’estate, quando noi ragazzi tornavamo dal mare di Porto San Giorgio, riuscivamo a scendere, andare nei campi a rubare grappoli d’uva strappati dai filari, per poi risalire al volo». Un’altra cosa che ricordava erano le lunghe soste a Servigliano, quando si fermava per caricare le bestie che la gente della costa aveva acquistato dagli allevatori della montagna.
Pochi civici più avanti di casa nostra c’era il casello numero 6, con il passaggio a livello; dentro ci viveva il sorvegliante Raccichini con tutta la sua famiglia. Lo stabile è stato ristrutturato, alzato di un piano, ma c’è ancora. Una volta sulla facciata color ocra potevi leggere ancora la scritta sbiadita Ferrovia elettrica Porto San GiorgioFermo-Amandola.
La memoria di quel treno, che fece l’ultima corsa il 27 agosto 1956, è ancora viva nella gente e nel paesaggio, dove restano alcune stazioni fatiscenti
con i muri dagli intonaci scrostati, come quella imponente di Santa Lucia a Fermo, quella di Falerone fuori dal paese, o di Grottazzolina. Luoghi persi di ieri diventati piccola archeologia di un’epoca, come il ponte sul fiume Tenna o sul fosso dell’Oro a Piane di Falerone, il viadotto Villa Basso dalle parti del lago di San Ruffino, per le strade che vanno verso l’entroterra dei Monti Sibillini.
La stazione di Servigliano invece è stata ristrutturata, oggi ospita un centro culturale, in quella di Amandola ci vive l’ex capostazione di Monte San Martino, il fabbricato viaggiatori di Montegiorgio è diventato una scuola. Partito da Porto San Giorgio, «il trenino di latta verde», com’era affettuosamente chiamato, saliva a Fermo, proseguendo su un percorso collinare nella Val Tenna per Monte Urano-Rapagnano, poi Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Monteverde, Falerone, Servigliano, Santa Vittoria, Monte San Martino, Monte Falcone, raggiungendo alla fine Amandola (un percorso della memoria ricostruito con passione e perizia da Pino Bartolomei nel libro La
ferrovia, Livi editore, che si aggiunge alle molte iniziative della sezione locale di Italia Nostra).
Nei primi anni di vita per fare 57 chilometri impiegava tre ore. Il cronista Luigi Bertoni, ricordando quei viaggi, scriverà aulico: «Di tanto in tanto, in ogni stazioncina, il treno si fermava. Allora uscivano “le capesse”, belle ragazze dal viso serio e impettite. (…) Erano loro le regine di quelle stazioncine fiorite di ortaggi, che stampano nei viaggiatori una carezza, un bacio di rose rampicanti, di camomilla. Che tinge di giallo le scarpate della ferrovia».
Ci furono anche eventi tragici durante quei viaggi durati mezzo secolo, tra la costa adriatica e i monti azzurri, come il disastro ferroviario del 27 novembre 1930. Avvenne a Fermo, sulla curva della Torretta, e conquistò l’onore delle cronache nazionali tanto da guadagnarsi una copertina della «Domenica del Corriere», disegnata da Beltrame, con questo concitato racconto: «Il pauroso salto di una vettura elettrica, in pieno abitato a Fermo (Marche). Uscita dai binari in una curva, la carrozza ha sfondato il parapetto, precipitando da circa otto metri. Otto persone sono rimaste uccise».
Oggi quella parte di natura dove andavo da bambino non c’è più, di fronte all’edificio dove stava il casello numero 6 ci sono una rotonda e una strada di collegamento, quella che era periferia e campagna è diventata città, anche se oltre, sempre uguali, si distendono le nostre colline morbide, ondulate e un po’ fiabesche.
Ma anche se non ci sono più, le vedo quelle boscaglie, i prati verdi, vedo le querce e le piante di prugne, i rovi di more, e ricordo che quand’ero bambino mi perdevo laggiù, seguendo randagio i solchi della vecchia ferrovia, e ogni volta andavo sempre più lontano, e mi sembrava di sentire l’eco della vo- L’autore La visualizzazione di questa settimana è a cura di Michela Lazzaroni, information designer con sede a Milano (behance.net/michelaz). ce di mia madre che si sgolava chiamandomi. Non la sentivo veramente quella voce, ma sapevo che c’era.
Il buio avvolgeva la campagna, allora capivo che si era fatto tardi, e cominciavo a correre con tutte le energie possibili, il cuore batteva forte come il pestare delle scarpe, e quelle selve diventavano subito sinistre. Correvo scappando da qualcosa che non conoscevo ma che mi figuravo incredibilmente mostruoso. Animali feroci, uomini maligni come quelli dei libri che avevo letto, come il pirata Long John Silver dell’Isola del tesoro. Vedevo già i volti, le mani prensili e ossute che volevano afferrarmi. Il vento che ululava diventava un personaggio vero nelle mie fantasie mentre scappavo seguendo la traccia segnata dalle rotaie. Quelli erano tempi di paura e di natura. Lontani, avventurosi.
 Tempi di paura e di natura sui trenini di latta
Tempi di paura e di natura sui trenini di latta
Racconti
Apparso su La Lettura l'8 ottobre 2017