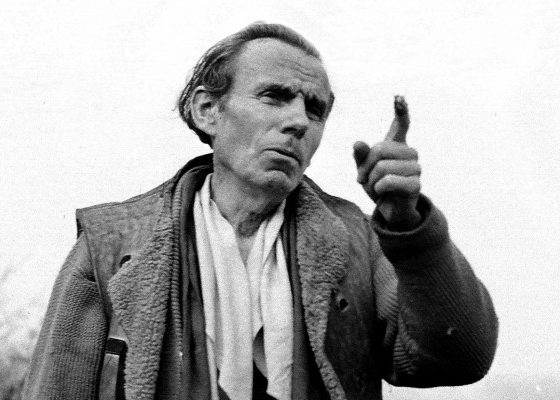Segno e Poiesis
Di Emanuele Martinuzzi
“La parola o il segno che l’uomo usa è l’uomo stesso. Perché il fatto che ogni pensiero è un segno, insieme al fatto che la vita è un seguito di pensieri, prova che l’uomo è un segno. Cosí, il fatto che ogni pensiero è un segno esterno, prova che l’uomo è un segno esterno “. Con questa frase del padre della moderna semiotica Charles Sanders Peirce c’immettiamo direttamente nel quesito cardine di questa breve trattazione, che appunto nasce con l’intenzione preliminare di percorrere da un’altezza consona al pensiero, ma allo stesso tempo distante a un’analisi più approfondita e nevralgica, le diramazioni concettuali implicite nella nozione di segno. Oltretutto la stessa definizione di segno vibra contenutisticamente in un’ambiguità, di per sé indecidibile. Definire cosa sia un segno, rispetto al contenuto (significato) o al referente denotativo (oggetto), rimane pur sempre una fatica Erculea per l’intelletto, alleggerita solamente dalla sua intrinseca vanità, ossia dal paradosso ineliminabile e sotterraneo che la sorregge. In altri termini la definizione di segno, qualunque natura esso possegga, può avvenire sempre e soltanto attraverso l’utilizzo di altrettanti segni, che si presume siano a loro volta definiti univocamente. Altrimenti sarebbe come provare a scalare una montagna o un ammasso di rocce reputandolo solido, senza tuttavia conoscere la reale densità o struttura delle rocce che lo costituiscono, cosa possibile oltretutto solo dopo averlo scalato o sperimentato in qualche modo. Certamente questa contraddizione può essere relativizzata delineando principi elementari e assiomatici, a cui il mondo dei segni, anch’esso potenzialmente ampio come il macro-universo o circoscritto come i segni invisibili del microcosmo interiore, dovrebbe logicamente attenersi.
Tuttavia non può essere superata compiutamente, perché ogni ipotesi teorica di costruzione del segno non può non sottostare all’antropomorfismo ermeneutico di un segno sui generis immerso tra i segni, come pare essere lo stesso uomo. Conoscere l’uomo, questo segno dal vacillante significato o dal significante in continuo cambiamento, immerso nella natura e nei suoi molteplici segni, pare un volo di Icaro, un’impresa impossibile già destinata a fallire per le ali di cera dell’essere segno. A questo punto, enucleando alle sue più radicali conseguenze queste fragili premesse, risulterebbe arduo perfino distinguere il mondo dei segni extra-umano, precedente la sua attività antropica e conoscitiva, comunemente detto natura, e il mondo susseguente sorto dalla prassi umana e dalla sua attività ermeneutica, comunemente considerato artificiale, sia in senso materiale che culturale. Quindi l’uomo stesso è un segno esterno, nel senso che nel continuum pre-semiotico di ciò che pare divenire o appare per essere, l’uomo-segno si staglia da questo flusso indefinito di segni di là da venire o si confonde con questo stato perduto dopo la caduta dall’indistinto nei segni, simboli, interpretazioni, illuminazioni.
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che sono vivi,
una foresta di simboli che l’uomo
attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.
Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un’unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.
Profumi freschi come la pelle d’un bambino
vellutati come l’oboe e verdi come i prati,
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza
che tende a propagarsi senza fine- così
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.[1]
“Nella vita degli individui e della società, la lingua è il fattore più importante di tutti.” Così affermava Ferdinand de Saussure, illustre fondatore della linguistica moderna, chiarificando la natura intersoggettiva dello stato ermeneutico in cui si ritrova l’uomo-segno. Il soggetto conoscente, che interpreta le articolazioni della realtà in una rete di segni, scopre tra le possibilità intrinseche dell’essere segno quella di farsi medium comunicativo con altri mondi simbolici. Il linguaggio e la società attuano quelle che sono le potenzialità intersoggettive e simboliche del segno. Questa tensione del segno di aprirsi e ampliarsi verso l’altro si potrebbe presumere derivi proprio dal fatto che il continuum indistinto, da cui il segno si ritaglia una porzione discreta di senso, non viene racchiuso né escluso in questa parziale creazione ermeneutica di segno, ma per sua misteriosa natura trabocca e straripa in altri segni e afflati simbolici. L’uomo-segno non soltanto si riconosce parola tra le parole, segno navigante nelle maree dei segni esterni o interni a se, ma è proprio nell’oscillazione stessa tra segno e uomo che vive esistenzialmente nella quotidianità, che riesce a trovarsi e rispecchiarsi nella naturale apertura di relazione con altri segni ermeneutici, anch’essi connotati da questo peculiare senso di indeterminazione.
Non vi sono segni senza confini, ma allo stesso tempo ogni segno rimanda ad uno spazio non toccato dai segni, perciò sconfinato. Questa indefinitezza coinvolge il segno di per sé, la sua disponibilità generativa a farsi parola, suono, immagine, concetto, alterità etc. Si potrebbe dire che proprio lo sguardo ermeneutico del segno-uomo nel confrontarsi con l’infinità del continuum da cui deriva lo fa giungere a pensarsi segno discreto, e viceversa, confrontandosi con la rete sussistente tra le articolazioni dei vari segni discreti in cui abita, arriva a immedesimarsi nuovamente nell’indistinto edenico o apocalittico, da cui proviene e che non ha mai lasciato, in una sfumatura misteriosa ancora da decifrare.
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quïete
Io nel pensier mi fingo, ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.[2]
“L’uomo è l’unico essere che vive nella misura in cui vive in un mondo di segni. Questo è il mare in cui nuota il pesce umano, questo è il suo elemento naturale. Altri animali sono indubbiamente sensibili a certe cose come segni di altre cose, ma ciò che per essi è casuale ed episodico, per l’uomo è essenziale e costante. Mentre altri organismi si muovono a seconda dei segni che il mondo procura, l’essere umano si trasforma e trasforma il mondo per mezzo di segni che egli stesso produce […]. Nella capacità di plasmarsi attraverso i segni che produce, l’uomo è unico. La misura dei suoi segni è la misura della sua libertà”. Sembrerebbe dire Charles W. Morris, semiologo positivista del Novecento, che il comportamento dell’uomo, il suo articolare ermeneutico la sostanza primordiale, amorfa e silenziosa che precede l’evento del segno, sia la cifra fondamentale della sua libertà, ossia la possibilità di attuare il segno come fattore comunicante, ossia di interrelazione tra segni. Quindi detto in altri termini, forse ancora in modo più specifico, la libertà del segno-uomo si esprime attraverso la strutturazione di molteplici linguaggi, costituiti da interconnessioni tra i loro segni in sistemi aperti e auto-generativi. Un linguaggio infatti non è un luogo astratto, chiuso nello spazio e nel tempo, immobile e cristallizzato in una forma come nei suoi prevedibili contenuti, bensì l’insieme dei segni che lo compongono, siano essi significanti o significati, e che variano continuamente in prospettive imprevedibili, con moti bruschi o millenarie fermentazioni. Reperti di questo incessante divenire, che ricalca parallelamente il continuum pre-segnico, non ancora connotato né dal divenire ne dall’essere, sono i testi scritti, la trasposizione del segno orale, aurale o concettuale nel segno visibile o perfino tangibile dei linguaggi visivi, grafico-pittorici, plastici o scritturali. Il farsi materico del segno parla nell’intertestualità dei linguaggi espressivi.
Il testo, il supporto grafico-pittorico o addirittura l’uomo come segno artistico espressivo nella parabola novecentesca della comunicazione artistica, sono la traduzione materica del farsi altro del segno, della sua mutazione interiore e esteriore. Una pietra, incisa da solchi più o meno grossolani, e la pagina bianca, scritta da nere linee d’inchiostro, si parlano non soltanto per similitudine, ma anche e soprattutto per corrispondenze simboliche sottili. Le epoche più disparate si toccano, pur nella loro lontananza temporale. Gli ambiti espressivi si contaminano nonostante la loro apparente riluttanza a aprirsi al differente. I luoghi, come anche i non-luoghi, acquisiscono senso dalla sovrapposizione ermeneutica dei loro segni. Perfino lo stesso non-segno del concettuale acquisisce discorsività e corpo dalla lacerazione e dal distacco di ciò che l’ha preceduto nel mondo visibile e tangibile. Non c’è più contrapposizione gerarchica tra alto e basso, sublime e reale, visionario e naturalistico. Neanche ovviamente tra segno e supporto materico del segno: entrambi sono l’espressione dialettica del segno stesso. Lo spazio del dicibile o dell’indicibile trova nell’interdipendenza dei segni il suo regno incontrastato e universalizzante, che s’identifica mimeticamente anche nella più umile e angusta dimora dell’interpretazione individuale.
Vorrei renderti visita
nei tuoi regni longinqui
o tu che sempre
fida ritorni alla mia stanza
dai cieli, luna,
e, siccom’io, sai splendere
unicamente dell’altrui speranza.[3]
“La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità.” Nel capolavoro di Umberto Eco Il nome della rosa, esemplificativo dell’intersecarsi in uno stesso lavoro testuale di più generi letterari e modi di ricerca linguistica, troviamo questa frase filosofica, pertinente e puntuale rispetto alla riflessione finora trattata. La bellezza che si propaga dal cosmo proviene e ritorna dalla molteplicità all’unità e viceversa, sembra affermare l’autore attraverso il personaggio del romanzo. L’estetica del tutto sembra caratterizzata sia da un moto dinamico, che da un senso di staticità. Questa passaggio dalla stasi informe al dinamismo segnico, o viceversa, si può immaginare come una specie di uscita e ritorno dal nulla, un movimento ermeneutico, in cui i termini del discorso non sono definiti e definibili una volta per tutte. Detto ciò sembrerebbe che questo dialogo con se stessi, aperto al potenziale altro, debba arenarsi come un conflitto irrisolvibile, un eterno girare in circolo senza mai punto di approdo, intriso da tutta la sua complessità intraducibile. La dialettica del segno, ovvero del non-segno, non sembra trovare una sintesi che possa manifestare il nuovo, la risposta, il diverso in un certo senso. Proviamo però a guardare le cose da un’altra prospettiva, invocando in un certo senso l’aiuto della classicità. Con Erodoto per la prima volta appare il nome ποίησις che significa propriamente il fare dal nulla, in quel caso col senso specifico di “creazione poetica”. Ma la poiesis dovrebbe essere in teoria solamente uno specifico modo dei segni di farsi linguaggio, materico o concettuale, nell’interazione tra il segno della parola e il segno della pagina col fine dell’espressione di un contenuto parziale. Il fare poesia non sembrerebbe essere lo stesso farsi del segno, piuttosto una maniera specifica del segno di aprirsi alle potenzialità del linguaggio. Tuttavia credo che per non accontentarsi di questa interpretazione comune e scontata della creazione poetica si debba risvegliare dal nome poiesis tutte le sue potenzialità sopite. Il significato di ποίησις si diceva essere il fare dal nulla. E se invece si provasse a declinare leggermente la prospettiva della traduzione in un altro senso, ossia come il fare del nulla. In questo caso la poiesis sarebbe lo stesso atto creativo del Nulla, ossia di uno stato pre-segnico indefinibile e indecidibile, continuum e infinito come qualsiasi cosa non abbia ancora limitazioni discrete e circoscriventi. Si apre adesso un orizzonte senza orizzonti, una lingua che parla tutte le lingue proprio perché non ne abbraccia nessuna, una montagna in cui la cima, le pendici o i piedi sono la stessa cosa e quindi dovunque si incominci la scalata la cima è già territorio di conquista da parte dell’esploratore. La poiesis è quindi lo stesso atto originario, che continuamente si ripete nell’infinita varietà delle forme, nel venire alla luce del segno da una non-condizione precedente, avvolta nell’oscurità e nel silenzio pre-segnico. Poetare è il movimento creativo che sta alla base della creazione di qualsiasi segno, che nello strutturarsi si ritaglia una porzione di senso, nonché un’articolata connessione con altri segni. Poetare è non altro che l’atto omnicomprensivo del Nulla di frammentarsi nel segno, qualsiasi linguaggio o mondo denotativo si consideri. La vaghezza simbolica della Poesia, che ritroviamo come un tratto specifico di significazione in un determinato linguaggio letterario, non è altro che il parallelismo metasemiotico del Nulla, del suo essere un continuum, ancora non illuminato né illuminabile, dall’ermeneutica che pone il segno dal Nulla. Ma è proprio attraverso questo viaggio a ritroso, possibile solo con la poiesis in questa accezione fondante e fondamentale, che possiamo ripercorrere il misterioso viaggio dal segno verso il Nulla, dalla vita alla genesi, dalla varietà all’unità, dal frammento verso il cuore dell’immensità.
M’illumino
d’immenso.[4]
Note
[1] Da I fiori del male – Corrispondenze, Charles Baudelaire
[2] Da Canti, L’infinito, Giacomo Leopardi
[3] Da IX Ecloghe, Nautica celeste, Andrea Zanzotto
[4] Da L’Allegria, Mattina, Giuseppe Ungaretti
In copertina Emanuele Martinuzzi. Credit di Celsi Angelo (Foto presa da facebook)