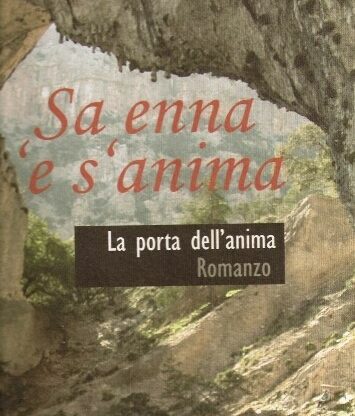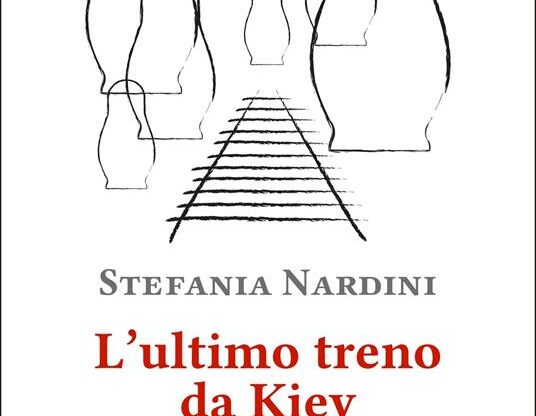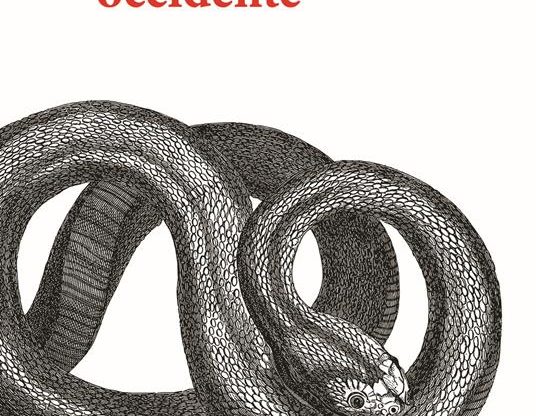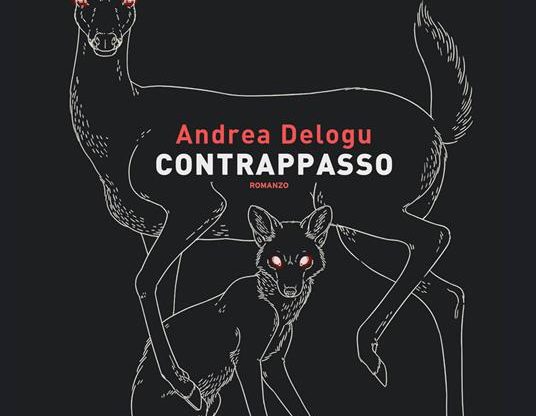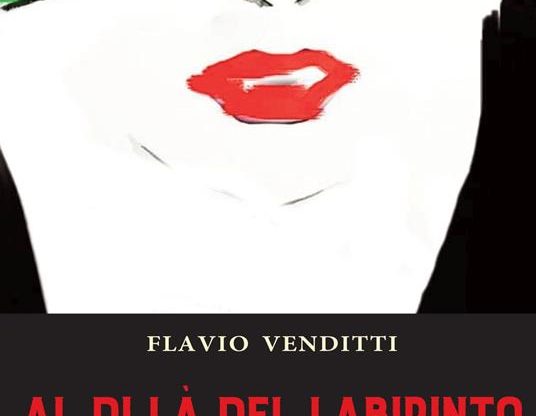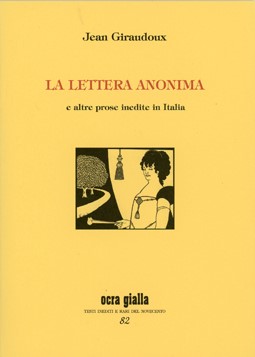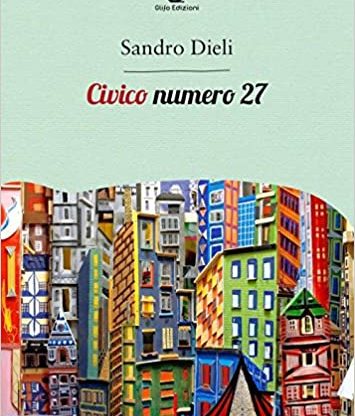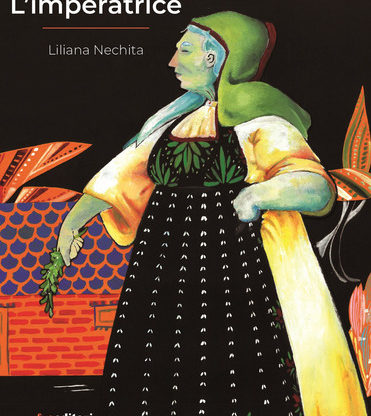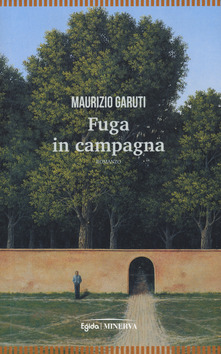El garrote. (sulla violenza)
Romanzo Breve
Di Francesco Garrone
“Il mondo è eterno perché muore”
Gennaro Sasso.
“Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico…”
J.
L. Borges, La cifra.
“Se c’è un principio è la violenza. Poi vengono il terrore più vile, il fremito, il tumulto oscuro delle passioni e, infine, la serie degli eventi e delle cose…”
La mente del giovane Hans van Dijk inseguiva il tono di questo genere di pensieri nel tentativo di ricavarne un aforisma o una breve sentenza. Alla vista del colpire dei bastoni sforzava la sua immaginazione e la sua memoria per ricollegare quella sconosciuta arte marziale caraibica alla scherma o a una qual certa disciplina del lontano Oriente, per analogia. L’uomo conosce in questo modo, pensava. Era sicuro che per quel genere di elucubrazioni avesse ancora molto tempo. Il silenzio della scena, attraversato dalla secca e ritmica toccata dei legni, lo persuadeva addirittura che disponesse dell’eternità. E sebbene ogni suo tentativo di definizione razionale o logica alla fine restasse vano, Hans van Dijk aveva la serena certezza che un altro combattimento si sarebbe dato ed una più scrupolosa osservazione, prima o poi, lo avrebbe condotto all’essenza di quel gioco.
Hans era seduto sotto uno dei tanti alberi di mango della periferia nord di Ajutín, nel largo patio di Heriberto Zanoja, il maestro. Immerso nell’ombra fresca teneva le braccia strette intorno alle gambe. Con la mano sinistra stringeva una succosa parchita che avrebbe morso più tardi. Con la destra accennava, cercando di copiarli, i movimenti del polso del combattente che considerava più abile. Mai il brillante Hans van Dijk si sarebbe reso conto che quello era solo un goffo tentativo di appropriarsi di quel qualcosa nell’unico modo che non si fosse lasciata prendere. Mai avrebbe realizzato quanto quella ostinata osservazione gli sarebbe stata fatale.
Più in là, dentro una grande voliera vuota, in rispettoso silenzio, una vecchia ara aspettava la fine di quel rito domenicale per ripetere il nome del proprio padrone, ogni volta che ne avesse avuta voglia. Di rado la si vedeva beccare cibo, sebbene chiunque l’avrebbe detta grassa. Era di una specie rara che si incontra perlopiù nelle pianure dei llanos, dove vive assieme all’iguana e ai serpenti cascabel. Non pochi, per una certa sua maestosità, la consideravano la vera padrona di casa. Più di una volta Hans aveva avuto la sensazione che quel terribile uccello lo sorvegliasse.
Sul lato opposto del cortile, su una sedia troppo bassa per la sua statura, sedeva Heriberto Sanoja. Scrutava scrupoloso le mosse dei due bastonatori, circondato a rispettosa distanza dagli altri combattenti. Il suo sguardo era placido perché sapeva lontana la vera violenza. Con piccoli mugugni dava cenno di approvazione o biasimo alle mosse dei due combattenti.
I garroteros, in tutto una ventina, erano di differente età e dai volti creoli. Tratti da indio, spagnoli, portoghesi, italiani, ma anche tedeschi e libanesi, mescolati. Vestiti come contadini, stavano chi con le spalle al muro, chi seduto in terra, chi impalato afferrando stretto il proprio bastone. Pronti allo scontro ma docili. Alcuni sorseggiavano birra, altri posavano la mano libera sulla spalla del proprio compagno accanto o sul proprio cappello di paglia. Quelli che bevevano non avrebbero più combattuto quel giorno, perché l’alcool eccita ed il garrote si pratica lucidi per acquisire maggiore lucidità. Il sole ancora forte e gli abiti di rozzo cotone erano intrisi del sudore della giornata.
Ad un certo punto, due uccelli rossi gli si posero davanti. Hans pensò che anche quel giorno era soddisfatto ma non del tutto. Il garrote gli celava ancora troppi indecifrati aspetti. Considerò che sbagliava chi paragonava quelle riunioni ad altri generi di incontri popolari molto diffusi nella regione, come la santería, la brujería, la magia o il semplice ballo tamunangue. Era troppo rozzo per lui sovrapporli, troppo facile metterli in relazione. Hans era convinto che si dovessero considerare le differenze e non lasciarsi ingannare dal fatto che, stando sullo stesso territorio, tutte quelle cose avessero finito per sovrapporsi. Hans avrebbe voluto dimostrare una volta per tutte che il garrote aveva una sua profonda natura, che era qualcosa di sottile ed autentico. Ma prima di arrivare a dirlo, ne avrebbe voluto avere lui stesso una incontrovertibile prova. Era rigoroso su quest’argomento con sé stesso. Con un gesto di misurata stizza cacciò i due uccelli rossi.
Qualche tempo prima ad un mercante di caffè che aveva incontrato in città e che gli aveva chiesto una spiegazione di questo genere, Hans rispose che il garrote era qualcosa più prossimo alla geometria che al folclore o alla religione, come invece molti credono. “Entrambi richiedono concentrazione, sviluppano figure, manipolano lo spazio, solo che il garrote richiede concentrazione mentre il corpo è in azione, quella disciplina matematica piuttosto presuppone l’immobilità fisica. Entrambi fissano un possesso, impongono un ordine dove c’è incertezza e indecisione. Cercano di cogliere il ritmo, la dinamica delle cose, di imbrigliare il movimento, ma mai definitivamente perché da esso dipendono”. Non era affatto sicuro di avere dato una risposta soddisfacente per il mercante di caffè. Anzi, per niente affatto. Forse perché quello s’aspettava altro. O più probabilmente, come avrebbe intuito qualsiasi altra persona minimamente maliziosa, perché era stato solo un modo di dire a Hans, non senza ironia, che perdeva tempo a studiare il garrote. Hans, tuttavia, era certo che anche con quella risposta avesse fatto un passo avanti nella sua ricerca.
Nel frattempo l’ultimo combattimento continuava. Un altro uccello rosso si posò davanti a lui, rinnovando la sfida all’olandese. Hans lo lasciò stare. Distolse il suo sguardo, alzò la testa e s’accorse che era iniziato il tramonto. In lontananza sentiva il fragore del fiume montare.
Furono le ultime stoccate e anche quel duello terminò. I presenti salutarono fraternamente il maestro, poi passarono dalla signora Zuleima che era in cucina a preparare arepas per la cena. Le diedero la buonasera e uscirono. Al solito Hans raggiunse per ultimo Sanoja. Gli disse che anche quella sera era felice di quanto aveva visto. Sentiva gli occhi dell’ara fissi su di lui. Sanoja lo guardò con bonarietà e aggiunse “estamos a la orden!”. Il vecchio si accese una sigaretta e gli domandò se volevano cenare insieme quella sera, era pronta della zuppa di gallina, e un po’ di platano fritto. Hans sorrise all’amico, infilò in una tasca la parchita e decise di restare.
Come al solito, mangiarono nello studio di Sanoja. Era una grande stanza fumosa, illuminata da una fioca lampadina insufficiente a illuminare l’ambiente. Su una grande scrivania stavano sparsi appunti, carte di vario tipo e alcuni libri con una rilegatura di canapa, sulla cui costa si leggeva: Historia verdadera de la guerrilla venezolana di Hana Kneuer; Bolívar y la guerra revolucionaria di Núñez Tenorio, Magia y religión en la Venezuela contemporánea di Gustavo Martín.
Appese alle pareti, c’erano molte foto di garroteros, di varie dimensioni, perlopiù in bianco e nero. I due conversarono a lungo del garrote, di alcune mosse dei combattimenti del giorno appena trascorso, delle storie e dei maestri precedenti ma anche della vecchia guerriglia e della nuova rivoluzione. l’incontro con Avenarius era però l’argomento preferito di Hans, ogni volta voleva farsi raccontare tutti i dettagli. Sanoja seguitava a fumare, anche quando beveva la zuppa e spezzava un’arepa. Hans ascoltava l’anziano amico con profonda deferenza e composto compiacimento.
Alle undici, entrambi con gli occhi stanchi, si salutarono affettuosamente. Uscendo dalla casa, Hans sentì l’ara lanciare un verso spaventoso. Preferì non farci caso, non voleva lasciarsi suggestionare. Lungo la via, mentre la sua figura s’immergeva nel buio delle strade, Hans prese a ripetersi a bassa voce il verso di quella canzone popolare che dice
Cante, cante, compañero;
pero no se me alborote,
porque le doy a guelé
los polvos de mi garrote
Cante, cante, compañero ;
pero no con fantasías.
porque mi garrote tiene
las cinco cuartas medías”[1]
La mattina successiva, il 23 luglio del 20**, Hans Albertus van Dijk venne trovato morto davanti alla panaderia del compadre Edilio Gutiérrez. Aveva 32 anni. A scoprire il corpo fu Cruz Betlem Martín, di professione cuoca, pronipote di Selidonio Baptista Martín, il celebre miracolato dalla Divina Pastora di Santa Rosa. La donna passava di lì con il figlio Antonio Ramírez per portarlo a scuola.
Appena si rese conto che si trattava di un cadavere, la donna coprì con il palmo della mano gli occhi del bambino. Gli disse di aspettare all’angolo della strada e di guardare verso il laghetto della villa Misericordia, senza girarsi. La donna si accostò al morto, osservò il viso insanguinato del poveraccio, ma a stento ne individuò i lineamenti. C’era sangue ovunque, i vestiti erano stracci, sbrindellati; il corpo torto, in una posizione che lo faceva sembrare un Cristo buffo o una marionetta: il cranio gonfio ed ovale, le braccia che accennavano ad una svastica celtica, e le gambe, fratturate in più punti, che se fossero state in piedi si sarebbe detto che avrebbero figurato un balzello. La povera Cruz, schifata da quanto visto, fece per ritornare dal figlio. Non ci riuscì. Corse in un angolo, s’accasciò e vomitò.
Poco dopo, attirati da quella macchia di sangue come mosche accorsero sul posto due uomini. Dopo di questi altri e due, ed altri e due ancora, fino a quando la piazzetta si riempì di gente. Mormoravano, cercavano di capire, ripetevano “Dios mio!” chiedevano insistentemente spiegazioni alla povera Cruz, per ciò ancor più nauseata e ormai sull’orlo dello sfinimento. La domanda che circolava, a più gradazioni di tono, era “Quien es?”.
Il sole era ormai alto. Il piccolo José Antonio da quasi un’ora se ne stava lì ormai, con gli occhi verso il laghetto di Villa Misericordia ad obbedire all’ordine. Arrivò un medico, cubano, di quelli fatti arrivare dal Presidente per aiutare il popolo dei barrio. Il medico infilò un tranquillante nella bocca della stordita Cruz che era quasi allo stremo. Poi si decise di portarla all’ambulatorio. La caricò sulle proprie braccia Ramon Peréz Fernández, un venditore di verdure e, seguendo il medico cubano, fecero per andarsene. Nel frattempo era giunto anche Selidonio Baptista Martín, che con riconosciuta autorità, si adoperò a fare largo tra le persone perché il medico, sua figlia e il venditore di verdure avessero facile passo. Il piccolo José Antonio allora, riconoscendo il volto della madre in quella signora portata come la vergine a processione, chiuse i pugni e corse dietro al gruppo.
Dopo due ore le autorità tardavano ancora ad arrivare, i giornalisti non si facevano vedere. Un giovane guappo, Heriberto Hernández, ebbe infine il coraggio di avvicinarsi al cadavere, scandalizzando gli altri che lo rimproveravano.. Il guappo sentenziò “È l’olandese. È il giovane olandese!”.
Arrivarono infine la polizia e alcuni
infermieri. Il cadavere fu caricato su una vecchia jeep e portato all’ospedale
di Ajutín. In breve la piazza restò vuota, macchiata da quella larga pozza di
sangue, malamente coperta di segatura, su cui tutte le mosche della regione
sembravano essersi date appuntamento ingorde.