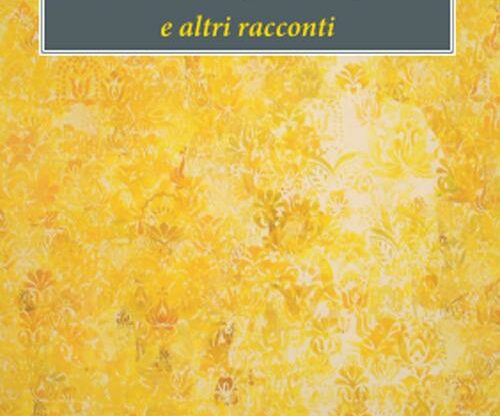Questo Inverni è, prima di tutto, un libro scritto bene. E davvero, iniziare con questa osservazione, è cosa per nulla scontata. Scritto talmente bene che ho dovuto leggerlo due volte. La prima lettura infatti mi ha vista costretta a concentrarmi proprio sulla scrittura, sul ritmo, sulla costruzione del testo con i suoi giochi strutturali. E, questa prima lettura, mi ha distratta dalla storia. E questo, credo, è un elemento di non poco conto quando si parla di libri, di storie che sulle parole si basano e che, sulla loro tenuta, devono fare affidamento. Ci sono belle storie scritte male, storie abbastanza normali scritte benissimo e poi, capita, ci sono belle storie scritte bene. Ecco, Inverni è un esempio di questo tipo.
Ma come tutti gli esempi di questo tipo, Inverni non è un libro facile. E se si arriva alla fine con questa sensazione, allora vuol dire che è sfuggito qualcosa. Sicuramente è sfuggito il profondo legame tra una scrittura che non rifugge la complessità e una storia che fa altrettanto. Anzi due storie, solo apparentemente parallele che non si incontrano e che, invece, sono intrecciate l’una all’altra. Una fuga, una rinascita, una apparente salvezza e l’impossibile desiderio di trattenere questa salvezza dandole una apparente perfezione, una apparente immortalità: la morte.
Sullo sfondo, accennata ma riconoscibilissima, la città che muore, la fin troppo famosa Civita di Bagnoregio ma qui vista, guardata (non è la stessa cosa) e raccontata al di fuori della mielosa retorica da marketing a cui siamo abituati noi che viviamo nel viterbese.
Francesco è un giovane professionista di successo. Federico un giovane ex tossicodipendente. Emma la sua salvezza, forse. Civita un luogo fisico e metaforico che agisce come luogo di una rinascita. Cosa tiene insieme tutte queste storie? Tutte queste vite? La curiosità, la disperazione in un certo senso, l’inquietudine, la paura di morire, la voglia di morire. Talvolta. E il suo contrario. Tutto giocato a livello semantico. Perché, in fondo, è questo che fa la differenza. Come ci dice l’autore, ad un certo punto, se non ci fosse l’infelicità non ci sarebbe il suo contrario e viceversa. Se non ci fosse la morte non ci sarebbe la vita e viceversa. In fondo, davvero, basterebbe eliminare una parola per eliminare anche il suo contrario. Basterebbe usare alcune parole per cambiare il corso di una vita. Lo capirà Francesco quando si accorgerà che Emma (che incrocerà anche la sua di vita) avrebbe potuto salvarsi se solo lui le avesse chiesto, almeno una volta: “Come stai?” E lo capirà grazie ad altre parole, quelle di un poeta, Wilcock e quelle di un anziano libraio.
Lo capirà forse anche Federico, inconsapevole portatore di una legge non scritta ma non per questo meno marchiata a fuoco, proprio come una frase stampata, nella vita di alcune persone: ogni uomo uccide ciò che ama. E più amerà, più sarà pericolosamente vicino al punto di non ritorno. Emma è un ponte, in un certo senso, per Federico, tra la vita e la morte. Un ponte talmente saldo da portare le due cose, le due parole a coincidere. Almeno per lui.
Un ponte tra la vita e la morte come quello che unisce (o separa, dipende dai punti di vista) Civita dal resto del mondo. Un ponte tra la vita e la morte (anche metaforica) come quello che unisce o separa Francesco dalla sua vita di prima a quella di dopo. Dopo cosa? Dopo aver capito che la sua esistenza fino a quel momento era regolata dall’inessenziale, dai riti omologanti che sembrano essere l’unica democrazia di cui dispone questa società.
Sì perché questo libro ha anche belle riflessioni su alcune delle piaghe del nostro tempo, fatte di capitalismo e social network o capitalismo dei social network e delle dinamiche relazionali da essi introdotte e amplificate. E ancora una volta, almeno secondo me, anche queste riflessioni diventano riflessioni sulle parole e sul loro portato. Come la parola “condivisione” tanto usata e abusata sui social. Talmente abusata da essere divenuta esattamente il contrario. Condivisione è intimità, come la bella scena di Francesco che, inaspettatamente, si ritrova a bere una birra con l’anziano libraio, parlando, uno davanti all’altro.
Impossibile dire tutto in una recensione. Impossibile raccontare anche perché, in questo libro, c’è anche un intreccio che si scopre poco per volta e che non voglio svelarvi. Un intreccio che vive, oltre che di bella scrittura, anche di personaggi molto ben disegnati, accompagnati nel loro muoversi nel mondo anche quando pensano di essere diversi dal mondo. Operazione non facile. Né la loro né quella dell’autore che li racconta senza mai, mai, giudicarli. Altra dote di questo libro.
Chi o cosa continua a vivere tra i personaggi di questo libro? Chi o casa muore? Infondo non è così scontato capirlo se, davvero, basta levare una parola affinché smetta di esistere anche il suo contrario.
Davvero da leggere
 Inverni. La città che muore
Inverni. La città che muore
Narrativa
Sette Città
2016
97