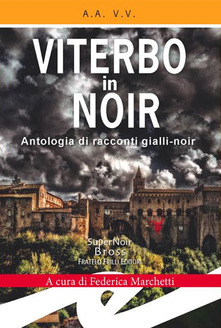Piccole scene del delitto
Una storia di maschere
Di Tommaso Lupoli
Dedicato ad Alice
che dopo aver finito di leggere mi prenderà a calci
e ad Irene
che mi ha ispirato nella creazione dell’aspetto della protagonista
Prologo
L’agente Marion Wheeler, cinquantaquattrenne, si aggirava silenziosa per la grande aula, lanciando di tanto in tanto delle rapide occhiate agli studenti che, compostamente, occupavano i banchi davanti a lei. Nessuno di loro le toglieva gli occhi di dosso, tranne che per lanciare delle rapide occhiate all’orologio, che segnava le 10:32 AM. Mancavano altre quattro ore alla fine delle lezioni. La Wheeler si schiarì la voce, osservando uno ad uno i suoi studenti: tutti dall’aria seriosa, la maggior parte di loro convinta che sarebbe bastato frequentare quelle poche lezioni con lei per divenire capaci di risolvere un caso in autonomia, nonostante solo un paio le avessero, fino ad allora, effettivamente dimostrato di avere le palle per diventare dei detective con un minimo di competenza. La donna si fermò al centro dell’aula, si chinò e raccolse un pezzetto di carta, non potendo fare a meno di notare la tensione dello studente affianco. Una volta alzatasi lo aprì, ne lesse il contenuto e se lo mise in tasca. “Signor Joyce – esordì, facendo alzare lo sguardo allo studente interessato – non so dove lei creda di essere, ma confido nel fatto che sappia che esistono dei momenti nei quali certe cose è meglio non farle. E, specialmente durante le mie lezioni, scambiare apprezzamenti sul ‘gran bel culo’ della signorina McLain con gli altri studenti, mi pare una cosa alquanto inopportuna”. 6 Alex Joyce si sentì sprofondare. Drew McLain, dall’altra parte della classe, si alzò dal posto e gli lanciò, con una mira impeccabile, la sua penna in testa. Marion si massaggiò le tempie con due dita, cercando di trovare una differenza fra i suoi studenti e dei semplici ragazzini delle superiori e poi, con un tono di voce glaciale sbottò: “Silenzio!” Pur non avendo parlato a voce alta, grazie all’acustica perfetta della aula, il suo comando potè essere udito sin dagli ultimi banchi. L’effetto fu immediato, e tutti, che fino a quel momento avevano riso, ammutolirono di colpo. “Bene – disse, con una lieve punta di sarcasmo nella voce – In queste prime due ore di lezione abbiamo ripassato le procedure standard da seguire quando ci si reca sulla scena del crimine e avete appreso le nozioni generali riguardanti le varie tipologie di serial killer che, ricordate, in un vostro ipotetico futuro da investigatori vi capiterà di incontrare, seppur in rari casi. Nelle prossime tre ore e mezza, invece, dal momento che oggi siete decisamente distratti, non seguiterò a farvi una noiosissima lezione sul ruolo che la polizia scientifica avrà nelle indagini, ma vi descriverò le scene del crimine di quei casi irrisolti che sono costati la faccia a questo dipartimento un paio d’anni fa. Non sono molti, ma sono tosti, quindi spero che abbiate tutti a disposizione dei popcorn ed un sacchetto per il vomito, perché ne vedrete delle belle”.
Prima scena del delitto: un Bugsbunny da incubo
Non capita tutti i giorni di venire svegliati alle tre di notte da una chiamata urgente del proprio capo, perlomeno, non se sei un cittadino comune. In ogni caso, ciò era cosa rara anche per me, Marion Wheeler. Eppure eccomi lì, seduta sul bordo del letto con il cellulare all’orecchio, a mormorare un flebile “Chi è?” Con la voce impastata dal sonno. “Marion, svegliati!” Fu la risposta che ricevetti. Nel riconoscere la voce del mio capo, l’agente Michael Smith, scattai sull’attenti come se l’avessi davanti, incurante di mio marito, che nel sonno emise un lamento. “Buon giorno capo.” Risposi, prima di accorgermi dell’orario. Dall’altro capo del telefono potei sentire un sospiro, seguito dalla risposta: “Sbrigati Marion, c’è stato un omicidio sulla trentanovesima, numero cinquantadue di Helborn street, ti voglio qui fra cinque minuti.” Prima ancora che potesse agganciare mi ero già vestita ed ero uscita di casa. Saltai in sella alla mia moto e, probabilmente infrangendo tutti i limiti di velocità e passando una volta col rosso, riuscii ad arrivare a destinazione in dieci minuti, più o meno. Un paio di vetture della polizia erano già davanti alla casa, una piccola villetta tutta finestre e niente muri con il tetto in stile orientale. Michael era già sulla porta e mi stava facendo cenno di entrare anche se, in effetti ero, lo ammetto, un po’ reticente all’idea di addentrarmi in quella villa degli orrori, 8 dal momento che su quasi tutte le finestre visibili erano presenti schizzi di sangue. Nel senso che qualcuno, col sangue, ci aveva disegnato sopra. Tutti i disegni, ad occhio e croce, erano stati dipinti sul vetro con le dita, seguendo uno stile semplicistico, e raffiguravano la faccia stilizzata di un coniglio, con gli occhi rotondi e, particolare alquanto inquietante, un ampio sorriso. All’interno dell’enorme bocca erano ben visibili i denti aguzzi. “Ti avviso – esordì Michael quando lo raggiunsi – all’interno è buio pesto, quindi prenditi la torcia e fai attenzione a dove metti i piedi.” La prima cosa che notai, non appena misi piede dentro l’abitazione, fu la presenza di frammenti di vetro sparsi dappertutto e, alzando lo sguardo, ne capii la provenienza: le lampadine erano state tutte frantumate. Alla destra dell’ingresso era situata la cucina. La cosa che saltò subito all’occhio, oltre al disordine dovuto ad una probabile colluttazione, fu la totale assenza di coltelli nell’apposito portacoltelli. Diedi solo una rapida occhiata, visto che poi quelli della scientifica avrebbero spulciato ogni angolo. Dalla stanza accanto mi giunse la voce nauseata di Michael, che mi chiamava con una certa urgenza. Era in salotto. E teneva la torcia puntata in direzione del cadavere. Quando ci posai sopra lo sguardo non potei fare a meno di avere un conato di vomito: in tutta la mia carriera da investigatrice non avevo mai visto il frutto di un così orribile, efferato ed aberrante omicidio. La vittima era una giovane donna. Una giovane donna sulla ventina, con gli occhi spalancati e lo sguardo ormai 9 completamente spento, privo di vita. Era stata posizionata su una poltrona di velluto, messa seduta con le gambe accavallate. Era nuda. Sul tavolino davanti a lei era stato allestito un servizio da te, con due tazzine riempite con un liquido rosso e viscoso. Nessuno di noi faticò ad immaginare di cosa si trattasse. Le erano state amputate entrambe le mani e le erano state ricucite in testa, con i palmi rivolti verso l’esterno e le dita aperte, alle quali erano state strappate le unghie. Suddette unghie gliele ritrovammo in bocca, dalla quale però erano stati strappati i denti. Le erano stati amputati i piedi ai quali erano state a loro volta staccate le dita. Le piante dei piedi e i talloni li rinvenimmo all’interno della teiera, bolliti nell’acqua calda. I dodici coltelli erano stati conficcati nel suo addome e nei suoi seni. In seguito ad analisi successive le trovammo i denti infilati nella vagina e le dita dei piedi nell’ano. Una volta svolta l’autopsia venimmo a conoscenza di un fatto agghiacciante: l’intera tortura le era stata inflitta mentre era ancora viva. Quella ragazza si chiamava Jane, e pensammo che il suo fosse un caso a sé stante. Capimmo di esserci sbagliati due mesi dopo, quando ci imbattemmo nella seconda scena del crimine.
Seconda scena del delitto: cena per due
La scoperta del corpo di Jane mi aveva completamente destabilizzata: quella era stata la prima volta che, al ritrovamento di un cadavere, avevo avvertito un così profondo e vivo malessere dentro di me. E nei due mesi successivi, durante le indagini, non potevo chiudere occhio la notte senza che mi si presentasse davanti agli occhi la stessa orribile scena. Una ragazza senza volto che mi invitava a prendere un tè, seduta su una poltrona di velluto rosso. Bevevamo in silenzio, scambiandoci sguardi di apprezzamento reciproco. Giunta a metà, però, non potevo fare a meno di percepire un sapore ferroso sulla lingua. Smettevo di bere e guardavo il contenuto della tazza, accorgendomi con crescente orrore che quello che avevo bevuto fino ad allora era sangue, puro e semplice, rosso e viscoso sangue. Alzavo lo sguardo verso la ragazza, solo per notare le sue mani cucitele in testa, l’assenza dei piedi, e dodici coltelli conficcati nel suo petto. Ecco che allora il suo viso diveniva quello di Jane e lei, reggendosi in piedi sulle caviglie, mi si avvicinava lentamente, senza alcune fretta. Si piegava su di me e la mia mascella si disarticolava, quasi possedesse una volontà propria. Jane mi guardava con i suoi occhi senza vita, dischiudeva le labbra e le unghie che aveva in bocca scivolavano silenziosamente nella mia. Solo allora io notavo la pesante e nauseabonda puzza di carne in putrefazione che lei aveva emanato per tutto il tempo. 11 Era raro, quindi, che i miei tempi di sonno superassero l’ora e mezza. Non di rado mi svegliavo in preda ad una forte agitazione, a volte facevo fatica a respirare e venivo colpita da terribili fitte alla testa. Una cosa che di solito mi accadeva quando c’era qualcosa che avrei dovuto ricordare ma che, per una ragione a me ignota, come un fantomatico mostro di Lochness, se ne stava sotto la superficie, ben attento a non venire a galla. Allora mi alzavo dal letto, stando attenta a non svegliare mio marito, andavo nel mio studio, e mi ponevo di fronte ad una ipotetica Jane. Solo che la Jane che mi immaginavo era una ragazza bella, sorridente, ben vestita e con tutti i pezzi al loro posto, proprio come la raffiguravano le foto nella casa dei genitori, con i quali avevo parlato di recente. Parlavo molto con la Jane immaginaria, solitamente rivolgendole domande alle quali lei non rispondeva o rispondeva almeno in parte. Anche la sera in cui ricevetti la seconda chiamata ero seduta davanti alla sua immagine intenta ad interrogarla. La vedevo chiaramente, seduta sulla sedia davanti alla mia scrivania, con le gambe accavallate e vestita con un lungo abito da gala nero, bordato in pizzo. Aveva dei lunghi capelli corvini, lasciati sciolti e grandi occhi grigi, come un cielo nuvoloso che si prepara a dare tempesta. La carnagione chiara. Non era la Jane barbaramente uccisa, ma la bellissima ragazza del mio sogno. “Jane, Jane, Jane… – rimasi un secondo in silenzio – devi aver provato molto dolore, quindi, perché non hai urlato, perché non hai chiamato aiuto quando potevi? Oppure, nel caso tu l’abbia fatto, com’è possibile che nessuno ti abbia sentita? Abbiamo controllato, sai? Loro erano in 12 casa a quell’ora, eppure dicono di non aver sentito niente.” “Beh – mi guardò, cercando le parole giuste per spiegarsi – sinceramente non lo so, tutto quello che posso fare è avanzare delle ipotesi: è possibile che i vetri di casa mia fossero fonoassorbenti, oppure, seguendo il tuo ragionamento, potrebbe essere che i miei vicini pur avendomi sentita, abbiano deciso di non aiutarmi o che, nella peggiore delle ipotesi, siano stati proprio loro ad uccidermi. L’ultima ipotesi però la scarterei, se fossero stati loro, goffi come sono, io sarei probabilmente riuscita a fuggire e loro avrebbero lasciato delle impronte o tracce di DNA. Non sono delle persone così sveglie da prendere in considerazione questi aspetti, lo hai appurato tu stessa quando li hai interrogati. Inoltre voi non avete trovato la minima traccia di DNA o impronte in casa mia, il che significa che l’assassino, che avrà sicuramente toccato qualcosa, è riuscito a tenere a mente tutti gli oggetti e a pulirli in un secondo momento, oppure…” La nostra conversazione venne interrotta dallo squillo del mio cellulare. Seccata da questo fatto, portai l’apparecchio vicino all’orecchio e sentii Michael che imprecava pesantemente. “Capo, è successo qualcosa?” chiesi, sapendo che a volte poteva capitare che l’agente Smith sbagliasse numero. “Quel grandissimo figlio di puttana l’ha fatto ancora, ecco cos’è successo!” Rimasi in silenzio, sbalordita. “Marion, sei ancora li?” “Sì capo, ci sono. Potrebbe spiegarmi, per favore, chi abbia fatto cosa?” 13 “Si tratta dell’assassino di Jane Richardson” rispose, recuperando la solita compostezza. Mi sentii gelare il sangue nelle vene. “Dove” mi limitai a chiedere, atona. “Staraway street, ventottesima, la casa è la numero ventisei.” “Cinque minuti e sarò lì.” La numero ventisei era un piccolo edificio in cemento armato, dal tetto piatto sul quale spuntavano le ringhiere che delimitavano un giardino sopraelevato. C’erano poche finestre, tutte di piccole dimensioni. La porta era blindata, e per aprirla ci sarebbe stato bisogno di una chiave magnetica. L’interno era un bilocale, con camera da letto e bagno in una stanza e cucina e salottino nell’altra. Ispezionammo ogni angolo, ma non trovammo alcun cadavere. Poi salimmo la scala che conduceva al giardinetto rialzato. La parte esterna del tetto era ricoperta da un prato sintetico, in un angolo erano poggiate due sedie a sdraio arancioni e al centro era posizionato un tavolo rotondo con due sedie. La terza era stata gettata vicino alle sdraio. La vittima non era una sola. Sedute, avevano posto due persone, entrambe nude: un uomo e una donna. L’uomo era depilato, con le gambe accavallate, le spalle curve e le braccia distese lungo i fianchi. Anche la donna era depilata, ma aveva le gambe bene aperte, in modo che la sua vagina fosse ben visibile. Aveva la schiena dritta e le braccia poggiavano sul tavolo, le mani ermeticamente chiuse attorno alle posate. Ad entrambi era stata mozzata la testa, e le loro viscere asportate e gettate a 14 terra, scompostamente. Negli addomi sviscerati di ognuno era stato infilato il cranio dell’altro, con gli occhi chiusi e la bocca aperta, senza i denti. Le loro mani erano prive di unghie. Al centro del tavolo, una grande teglia, nella quale c’era un neonato, o quel che ne restava: il suo corpo sembrava esser stato bollito per un lungo periodo di tempo, poi diviso in due metà simmetriche. Il cuore ed i polmoni erano stati asportati ed impastati con della farina, triturati e con essi erano stati creati due plumcake, posti poi nei piatti davanti ai due adulti. Nella bocca del neonato, quasi a voler somigliare ad un’orribile ciliegina su una torta disgustosamente insana, era stato infilato il pene tagliato del padre. Se la prima volta che avevo posato gli occhi su Jane avevo resistito, quando vidi quello scempio di vite non ce la feci più. Corsi al parapetto e vomitai di sotto. Avevo lo stomaco vuoto, e quindi tutto quello che venne fuori fu bile. Nell’assistere a qualcosa di così orrendo tutti noi venimmo presi dal disgusto più totale e credemmo, per non dire sperammo, di aver toccato il fondo del barile. Ma così non fu. Quell’essere, incarnazione dell’Abisso più cupo e malvagio, non si sarebbe fermato tanto presto. Né avemmo la certezza quando, una decina di giorni dopo, ci imbattemmo nella terza scena del delitto e ormai ci fu ovvio: quello che ci trovavamo davanti era un serial killer.
L’immagine di copertina è Chateau noire, di Paul Cezanne, foto presa da wikipedia