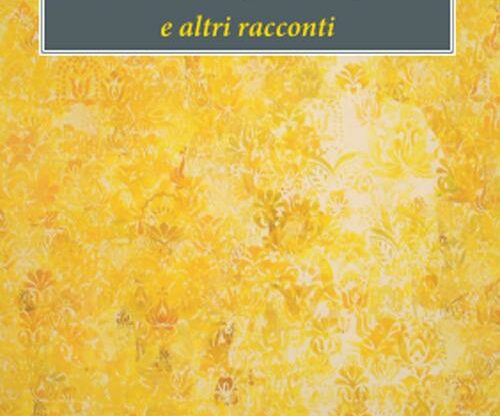Giulia aveva comprato dei fiori. Un mazzetto di tulipani, avvolti in un foglio di plastica, per 5 euro, da un ambulante incontrato lungo il marciapiede di viale Monza, oltrepassato Rovereto, poco dopo essere uscita da lavoro, mentre tornava a casa – aveva voglia di camminare.
Li teneva a testa in giù, con disinvoltura; pensava a dove li avrebbe sistemati una volta rincasata. Spesso si diceva che avrebbe dovuto tenere dei vasi di fiori in soggiorno, cambiarli regolarmente, ma non li comprava mai e le uniche piante che sopravvivevano in appartamento, ai termosifoni e alle sue cure incostanti, erano piante grasse e un ficus che sembrava imbalsamato: lo aveva preso all’Ikea e la seguiva da tre traslochi e altre città; in definitiva aveva vissuto più dei mobili che ne avevano accompagnato l’acquisto.
Superato piazzale Loreto che coi suoi cartelloni pubblicitari, in alto sui palazzi, ricordava una versione triste di Oxford Circus, accelerò il passo. Non sapeva che ore fossero. Le sarebbe piaciuto che ci fossero ancora stati i rintocchi delle campane a indicarle l’ora della giornata, quegli anelli di suono metallico che si propagavano nell’aria scemando fino a perdersi, inghiottiti dall’orizzonte e dai rumori scomposti e interminabili della città. Ma non c’erano più campane a Milano, e quelle superstiti, ripristinate e armonizzate nel dopoguerra, avevano un suono scordato e privo di grazia, come se avessero voluto conservare, proiettandola settant’anni dopo, l’ansia irrisolta – come irrisolto era quel piazzale – che probabilmente si respirava in quegli anni che erano stati insieme terribili ed eccitanti; quel suono che oramai – chissà perché – si sentiva soltanto la domenica mattina, un giorno da sempre strano: metà relitto in fondo alla settimana, metà rito propiziatorio per l’ennesimo inizio.
Adesso doveva recuperare lo smartphone dalla tasca per conoscere l’ora: il numero che campeggiava sul display, con la sua precisione satellitare e la discrezione della luminosità opportunamente regolata, diceva che tra quattro minuti sarebbero state le 19,00.
Era l’orario clou dell’aperitivo. Avrebbe potuto capirlo anche senza controllare il cellulare se avesse prestato più attenzione agli spostamenti migratori lungo le traverse di corso Buenos Aires, in prossimità di porta Venezia, luoghi prediletti per certi locali che alternavano il piastrellato alla carta da parati e servivano cocktail discreti con tanto ghiaccio e cibo nella media, piante, lampade, bottiglie apparecchiate scenograficamente: locali che guardavano a Berlino, Londra, New York, ma per occhi esterni, come quelli di Giulia quando si era da poco trasferita, erano inequivocabilmente milanesi, in quell’accezione neutra in cui la valenza non si è stabilizzata su un unico versante – positivo o negativo –, ma oscilla, influenzato da come gli occhi della città ti guardano, giudicano e infine ti incollano una etichetta addosso.
Oltre che l’ora dell’aperitivo, però, era anche, con un’evoluzione che si estendeva sino alle 20,00 circa, l’ora in cui finiscono le storie d’amore. Se non altro a Parigi e se non altro in quel racconto che aveva letto un paio di sere addietro (dalle fine dell’estate aveva preso l’abitudine di leggere un racconto ogni sera, prima di spegnere la luce, coprirsi fin sotto al mento con il piumino e dormire; racconti qua e là, da raccolte e antologie sparse, perché i racconti hanno questo di buono, come diceva proprio l’autrice di quello che le era appena tornato in mente: non richiedono il tempo di un romanzo, l’attenzione prolungata e la concentrazione sulle cuciture e i raccordi; sono come un flirt estivo: ti prendono, ti conquistano, poi ti lasciano ad altro).
Comunque non solo a Parigi succedeva. Forse in ogni città, a quell’ora, le luci, il traffico, i toni delle parole che si tengono in equilibrio innalzandosi sopra le teste, le piante sui balconi e le campane assenti, il cielo sfumato nel nero e l’aria fredda addensata dallo smog: tutto, ogni dettaglio, si assembla – come una orchestrazione della natura – a costruire il set ideale per dire addio; quell’addio che già da tempo rimbalzava da una parte all’altra del corpo, come una biglia che cerca la sua buca d’uscita o un grumo d’ossigeno che reclama la sua libertà.
Aggirò piazza Duomo, come sempre. Non sapeva esattamente perché non amasse attraversarla, preferiva addentrasi nel reticolo di stradine alla sua destra (strade curve, come il tempo in prossimità del Sole), tagliare la Galleria lateralmente e guardare ammirata le vetrine – si perdeva già quelle della Rinascente per assecondare questo vezzo, così che, di tanto in tanto, cercando di non perdersi nessun nuovo allestimento, andava appositamente a guardale. Si sentiva provinciale mentre le guardava fingendo nonchalance. Probabilmente era vero quello che le ripeteva Samuel: che era una piccola snob; piccola perché si vergognava di esserlo.
Ed ecco, l’orario era quello giusto e il pensiero – neanche a farlo apposta – andava a Samuel. Già da diverse settimane non stavano più insieme; a contarle tutte erano già due mesi, ma concedersi questa precisione le sembrava una forma di rimpianto alla quale non voleva – in alcun modo – dare spazio. Era finita, sì; era stata una storia importante, ok, ma si era già logorata da tempo, molto prima che formalmente approdasse alla sua conclusione. Quindi, sotto tanti aspetti, quell’addio, camuffato dalla retorica preconfezionata e già stantia che consiglia e impone di mettere da parte ogni risentimento e di essere – o fare – gli amici, per lei era stato un momento liberatorio.
Ma la tristezza era dietro l’angolo, mentre oltrepassava Cordusio e si avviava, sempre col suo passo spedito (la stanchezza, sapeva già, l’avrebbe avvertita quando si sarebbe fermata, tolta le scarpe, il trucco con dischetti di cotone imbevuti di struccante e poi lasciata scivolare sul divano, in mezzo ai cuscini) verso via Santa Marta, in quella serpentina di case antiche e portoni imponenti, luci accese dietro le tende alle finestre: lei non era rimasta amica con nessuno. L’unico modo che aveva per continuare, per provare a stare meglio, raggiungere quell’oltre sempre agghindato di promesse e di un nuovo inizio – mai definitivo, soltanto un giro di giostra destinato a chiudersi con l’affievolirsi della musica di accompagnamento in sottofondo, un’altra hit del momento da sostituire alla stagione successiva, poi recuperarla magari, in un attimo di nostalgia futura, tra il repertorio caotico delle memorabilia –, l’unico modo che aveva, dicevamo, era: spegnere la luce, chiudere, abbandonare di corsa le scale.
Nella sua testa si figurava l’immagine di una ghigliottina che precipitava: separava in maniera definitiva – un trancio netto – quello che era stato un corpo unico, ma da quel momento in poi non sarebbe più stato tale.
Era triste, lo sapeva; provava rammarico per non essere capace di cambiare modalità; rabbia, contro se stessa, per non riuscire ad essere – almeno ogni tanto, almeno su alcune cose, su quelle che sembravano funzionare nelle vite degli altri – come la maggior parte delle sue amicizie, o come una ragazza – una donna oramai, prima o poi avrebbe imparato a ritenersi e definirsi tale – come tante, come una di quelle accanto a cui stava passando in quel momento, che ridevano davanti all’Ostello Bello: bicchieri di vino rosso poggiati a terra, sigarette rollate a mano che si consumavano velocemente tra le dita, una collana lunga di corallo che scendeva su un maglione nero seguendo la curva del seno, occhi perfettamente truccati che guardavano il suo mazzo di tulipani, poi risalivano su di lei. Si era sempre chiesta, con un profondo senso di disagio, cosa potessero pensare degli sconosciuti vedendola in strada, andare col suo passo ritmato e sostenuto, anche mentre passeggiava senza meta e senza tabelle che imponevano la loro marcia.
Doveva ammettere, non senza imbarazzo – anche se era una constatazione che non avrebbe mai condiviso con nessuno –, che era questo pensiero a guidarla ogni mattina mentre sceglieva cosa indossare, i colori, gli abbinamenti, le scarpe, gli occhiali da sole che sembrava pescare a caso dalla sua collezione vintage (anche questo le rimproverava Samuel, sfottendola: il suo credere, con ostinazione, nella valenza estetica – e morale! – dell’usato), e per i quali, invece, aveva sviluppato un particolare talento, così che, in una manciata di secondi, riusciva ad individuare nel mucchio e a prendere proprio il paio più azzeccato, quello che, insieme al resto, come la spezia giusta su un piatto indiano, l’avrebbe insaporita e mascherata, in un unico gesto.
Eppure aveva paura, continuò ad ammettere a se stessa. Di quei pensieri che non riusciva a decifrare, quelle parole non dette che intravedeva dietro certi sguardi che veloci la colpivano qua e là, scivolando sulle sue superfici corazzate, non senza averle prima intaccate, magari in prossimità delle giunture. Sì, aveva paura. E non aveva ancora imparato a dire qualcosa con la sua voce, malgrado gli anni passassero velocemente, oramai, e già vedeva – se lo sentiva addosso, con tutta la sua pesantezza – lo spartiacque dei quarant’anni, non troppo distante, lì, dietro l’angolo, a un paio di isolati di distanza.
E a queste paure, immancabilmente, rispondeva fuggendo: il tram 2 era alla fermata, laggiù, dopo l’incrocio. Iniziò a correre, per come poteva, frenata dal tacco delle scarpe, dalla borsa pesante, dai fiori che stringeva in mano e che fece sbattere, con violenza, ma senza volerlo, contro un palo della segnaletica, prima di attraversare con il rosso le strisce pedonali. Infine era riuscita a salire sul tram; l’autista, probabilmente, assistendo alla sua corsa dallo specchietto laterale, aveva deciso di attendere che salisse; chiuse le porte subito dopo. Una volta a bordo, ritagliato un po’ di spazio, per sé e per i fiori, in mezzo alla folla che, come sempre a quell’ora, gremiva il tram, fece un cenno con la testa, confidando che la sua riconoscenza nei confronti dell’autista riuscisse a scavalcare tutti i passeggeri e giungesse a destinazione; in fondo – e questo aspetto in qualche modo le piaceva, le sembrava dovuto – continuava a credere nella gentilezza, nella buona educazione, nel potere di un piccolo sorriso che si apre qua e là lungo la giornata, inatteso, senza calcolo, privo di leziosità.
A Samuel piacevano i suoi sorrisi. Non era vero che aveva avuto sempre pronte le critiche e i rimproveri, doveva ammetterlo: a volte, anzi, spesso, lasciandole cadere con disinvoltura – a tratti con dolcezza, come fosse una sua parte –, tirava fuori delle osservazioni, poche parole, scondite e semplici, che erano un piccolo specchio che le rimandava un’immagine avvalorata di sé, che la faceva sentire capita, le suscitava conforto e forse, in qualche modo che ancora non le era del tutto chiaro, accresceva la sua consapevolezza: di sé, del mondo, della fisica dei quanti.
Sorrideva adesso, mentre il tram oltrepassava semaforo dopo semaforo per raggiungere il capolinea, in porta Genova. Sorrideva provando tenerezza: per quello che era, per le sue fragilità, per l’immaturità che vedeva come ingrediente principe del suo carattere.
Quante cose aveva ancora da capire! Troppe le aveva imparate tardi, anche l’importanza dell’igiene orale. Fino a qualche anno fa, ad esempio, si limitava a spazzolare i denti con uno spazzolino dalle setole dure, con forza e movimenti ellittici; ogni quindici giorni aggiungeva il bicarbonato al quotidiano dentifricio sbiancante. Poi, di colpo, un’epifania, sfogliando una brochure nella sala d’aspetto del dentista e poi lasciandosi incantare dalle parole di un giovane igienista dentale che forse voleva affascinarla: ma in quel momento per lei aveva importanza soltanto la scoperta dello spazzolino elettrico e delle setole morbide, del filo interdentale e dei movimenti che non scoperchiano le gengive, del dentifricio bianco e semplice – il più possibile – e dell’appuntamento semestrale, possibilmente presso la stessa clinica.
I quarant’anni non erano distanti, ma certi giorni si sentiva una ragazzina che scorgeva per caso, per la prima volta, la complessità di tutte le cose; cercava di coglierla, di comprenderla e prevederla, ma non ci riusciva e si arrendeva. Una voce dentro la testa, quasi un’istanza psichica modellata su schemi cinematografici vecchia maniera, le diceva che in fondo era una disadattata, o forse semplicemente disfunzionale (ma le differenze in cosa consistevano?), comunque non c’era modo – categoricamente – di cambiare questo dato di fatto.
Eppure, pensò scendendo dal tram giunto nel frattempo a destinazione, certi giorni – anche se non proprio frequenti – aveva l’impressione di riuscire a cavarsela.
Se la sarebbe cavata anche stavolta, anche senza Samuel, anche dopo quella passeggiata lunga che aveva smosso gli umori, tra picchi e precipizi, veli di depressione – a cui, sapeva, era sempre esposta, per indole, segno zodiacale e forse una sua specifica conformazione cerebrale – e ventate di conforto che altro non erano, in definitiva, che spirito di conservazione.
Percorse l’ultimo tratto di strada prima di giungere in casa, accanto al Naviglio Pavese carico d’acqua e di luci riflesse. Per un attimo ebbe timore di ritrovarsi nella scena della settimana precedente, quando una sera, sempre al ritorno dal lavoro, tra le mani le buste della spesa per la cena che doveva preparare (attendeva ospiti, cosa non usuale per lei), si ritrovò sotto al suo palazzo una manifestazione che un paio di cartelli dichiaravano essere contro l’invasione. Erano tutti giovani i partecipanti; quando salì in casa, sconvolta e turbata, si affacciò alla finestra e li contò: non raggiungevano il centinaio, forse una settantina di ragazzi, circondati e scortati dalle forze dell’ordine – loro sì, in tanti –, tutti uguali, o quantomeno molto simili, nell’abbigliamento, nella camminata, nel taglio di capelli da repertorio, nel silenzio in cui marciavano; irreali nella loro assurdità, con le loro pretese e prospettive con le quali richiamavano il mondo a un ordine inesistente, così fasullo che ai più – lei compresa – era sembrato superfluo opporre una qualsiasi obiezione, almeno fino a quel momento, cioè tardi.
Stasera invece solo risate e voci e musica dai locali intorno, le sembrava quasi, se avesse avuto un orecchio più fine, di riuscire a sentire la schiuma della birra che veniva spillata, poi poggiata sul banco, con un colpo secco, e servita; il crepitare dei crostini col pomodoro tra i denti dei ragazzi che ritardavano la cena dilungandosi a bere, in compagnia, svagati: le solite storielle di cui tracciare i retroscena, le solite battute di cui ridere, i soliti problemi da non prendere troppo sul serio, musica nuova che ricordava quella vecchia: volti armonici, rossetti waterproof, macchie di nicotina, sorrisi timidi, parole leggere, orologi pesanti su polsi mascolini, capelli che fluttuavano nella spensieratezza.
Si avvicinò al portone, lì a poche decine di metri, e già pregustava il tepore che avrebbe trovato tra le pareti del suo bilocale accogliente e ogni cosa in quel momento – per la prima volta da che la giornata aveva avuto inizio, anzi, per la prima volta da molti giorni e molte settimane – le sembrava racchiudere una forma, infinitesimale, instabile, ma comunque presente, comunque degna, di grazia che alleviava la sorte.
 Ore 19:00, il conforto
Ore 19:00, il conforto
Racconto
2018