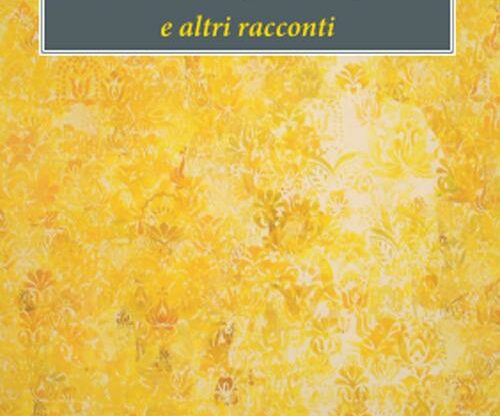Patrizia Di Donato, nasce a Giulianova e qui ancora risiede con la sua famiglia.
Tra gli impegni familiari e quelli di insegnante di sostegno hanno visto la luce un romanzo e numerosi racconti: il romanzo “IL GESTO” ha ricevuto una segnalazione di merito al Premio Letterario Nazionale “Nuove Scrittrici” (Pescara 1996); il racconto “L’UOVO DI COLOMBO” è stato segnalato nell’edizione 1999 del Premio Teramo e inserito nella raccolta di racconti “Ventagli” edito dalla casa editrice Sovera. Nella edizione del Premio Teramo anno 2005, vince con il racconto “Che bel dono” la sezione dedicata allo scrittore abruzzese Mario Pomilio.
Con i racconti “Lettera a Celeste” e “Il tempo di un aperitivo” è online sulla rivista Progetto Babele.
Il libro dal titolo: La neve in tasca edito da Galaad- Duende è il suo ultimo lavoro
Letterario.
Il libro ha ricevuto una Menzione D’Onore al Premio Martucci Valenzano.
E’ stato inserito nel Programma del 16° Premio Nazionale Paolo Borsellino 2011, in un incontro letterario dal tema: Com’è difficile essere donna oggi.
Ha partecipato al Festival delle Letterature dell’Adriatico, Pescara 2011.
Presentato altresì Al Premio Annino Di Giacinto Teramo 2011 e alla terza edizione del Festival Trabocchi libri e rose 2012.
Ha ricevuto un Premio Speciale al Festival Il Dio di mio Padre 2012. Dedicato a John Fante.
Coautrice dei libri: Sinfonia delle tre stelle. Collana Radici. Rupe Mutevole edizioni.
Il cono si racconta. Ed Duende.
365 storie d’amore. Delos edizioni
Premio Civitaquana.
Patrizia Di Donato è stata presidente del Festival Nazionale della Letteratura Città di Giulianova Costa Blu, gemellato con il Festival della Letteratura di Mantova.
L’ADORATA
Non lo diceva per ferirla. Lo diceva perché la adorava. Lei più volte lo aveva invitato a desistere ma niente da fare. Lui si scusava, prometteva di non dirlo più, si inginocchiava e la pregava di perdonarla, univa le mani in quel gesto orante che odiava. Va bene, va bene, non preoccuparti, dai. Ora alzati però, ti stai sporcando i pantaloni, gli diceva distogliendo lo sguardo.
Le donne non si adorano, le donne si amano, ripeteva fissando quella piccola striscia di blu che si stagliava all’orizzonte. Mare, si chiama mare. Sei vissuta dentro le estati di quella striscia, sciocca. Ora, alla domanda rispondi, non amo l’abbronzatura e poi il mare invecchia. Lo dici mentre invecchi. Senza sale e senza sole.
Sua madre lo vedeva rincasare spesso con qualche pacchetto e i suoi occhietti di allodola seguivano il dimenarsi di quei fiocchetti. Si contorcevano nel vuoto, giusto il tempo di guadagnare il portone. Il mattino dopo, davanti alla solita tazzina di caffè avrebbe sospirato, beate te, ti porterebbe l’uovo del lupo, tanto ti adora. A proposito, hai mica buttato il fiocchetto verde? E tu avresti sospirato, te lo porto subito. Il suo dito avrebbe indicato lo sportello in basso e tu l’avresti infilato fra l’enorme pila di fiocchetti abbicati alla rinfusa. Lei avrebbe sostato un po’, inorridita da quei vermi multicolori. Inutili. Senza speranza.
Cosa ne avrebbe fatto? A cosa le servivano? A chiudere la velina con cui incartare i suoi dolci.
Ma si muoveva a fatica, ormai. E quel maledetto dondolio aumentava di giorno in giorno. La burrasca era vicina. Tieni pure i tuoi fiocchetti, mamma.
Intanto lui non perdeva occasione di sottolineare questa sua devozione, questo amore incondizionato, leale, purissimo, suscitando l’invidia delle amiche.
Ti andrebbe un gelato? Dove vorresti andare stasera? C’è qualche film che ti piacerebbe vedere? Dove vorresti andare in vacanza? Vado a prenderti qualcosa di pronto?
Le sorprese poi, quanto amava le sorprese. Chiudi gli occhi, tieniti a me, cammina lentamente, ecco, ora siedi qui e attendi un attimo. Lei restava con gli occhi serrati infastidita dallo scricchiolio che sentiva avvicinarsi. Ecco, ora apri gli occhi. Lei apriva gli occhi e si trovava fra le braccia un involucro ingombrante. Indovina cos’è? Prova ad indovinare dai tesoro. Lei provava a indovinare, con la borsa dentro l’involucro lei elencava una serie di oggetti che potessero uguagliarne il peso. No, no, no, acqua, acqua. Allora lui afferrava l’involucro e strappava la carta con violenza. Voilà!
Stupenda, diceva lei, veramente stupenda.
Hai visto? Era questa vero, la borsa che fissavi nella vetrina del centro l’altro giorno, mentre passeggiavamo in silenzio?
Lei annuiva e ripensava quella donna riflessa, quella con la parrucca. Il desiderio di fuggire, di trovarsi altrove. La forza sovrumana a colpire la sua schiena, vecchio batacchio che non brilla più. Vai via, scappa. Vattene via.
Fissava per la prima volta quella borsa che non le piaceva affatto, la vedeva oscillare fra le dita del marito e si sentiva come lei, in bilico, tentennante, instabile.
Gliela rimetteva sulle ginocchia e lei fingeva una gioia sciocca, provava a battere le mani, come la scimmia dell’uomo che vendeva noccioline. Tentava di commuoversi ma le lacrime non fluttuavano dentro gli occhi, tracimavano, neanche fossero acqua reclusa da una diga matrigna. Così piangeva. La borsa fra le braccia piangeva copiosamente.
Poi smetteva. Da abile maestra, spostava l’obiettivo, provava a distrarre il dolore.
Chissà se quella borsa avrebbe mai scelto lei? Le piacevano le sue braccia, le sue dita, il suo sudore? Avrebbe concesso volentieri il suo utero per accogliere la sua Moleskine, le sue penne, i suoi libri, i ventagli neri?
Era felice di essere finita lì?
Come al solito poi era giunto l’abbraccio, quella stretta sbagliata, da offesa, quella che scludeva i bacini, i femori, le ossa e la carne. Si abbracciavano a pezzi, si escludevano. Lei ingoiava la pancia, lo stomaco, le gambe. Con i piedi rivolti all’esterno, in fuga.
Tana, tana per Chiara dietro l’albero.
Le malattie sono i discorsi evitati, sono le cose non dette, le cose nascoste, sono le finzioni, le risate che non ci fanno ridere, le urla che abbiamo impedito e le verità che abbiamo taciuto.
Le malattie giungono quando abbiamo finto di non aver udito, di non aver visto, di non aver capito.
Così anche le adorate si ammalano. E lei? Quando aveva iniziato a fingere di non aver udito, di non aver sentito dolore? Ricordava il momento preciso in cui aveva desiderato essere altrove?
Si, lo ricordava benissimo. Fu quando lui le disse per la prima volta quella parola.
Erano in vacanza sul lago. L’aria era trasparente. Lei era scesa giù e con difficoltà aveva guadagnato la riva. Amava i laghi. Li trovava buoni, quieti ma sani. Io sono un lago e qui non si galleggia. Se non vi piaccio andate al mare. Il lago era il coraggio, quello che le mancava.
Ecco, lei avrebbe desiderato essere un lago. Se mi vuoi sono così.
Era una giornata di fine luglio, assolata e calda. I cavalli liberi da selle e paramenti, affondavano gli zoccoli lungo le rive. Vide un piccolo scoglio e lei decise di sedersi lì, bagnarsi i piedi. Come i cavalli. Sentiva il ronzare degli insetti e qualche voce lontana rimbalzare fra i boschi delle alture.
Decise di sollevarsi e fare un bagno ma quando immerse il primo piede sentì avvilupparsi sotto al calcagno una melma vischiosa. Provò a sollevarsi ma scivolò rovinando sul piccolo scoglio. Urlò forte il nome di suo marito. Lui apparve immediatamente sopra, sul bordo dell’altura e la chiamò con quel nome detestabile. Che significava?
Lei restò ferma mentre la melma le saliva sulle ginocchia. Sperò di non aver udito bene ma lui gridò ancora con quel nome. Allora si aggrappò con ambedue le braccia allo scoglio e con tutta la forza che credeva non possedesse, si trascinò fuori dall’acqua.
E’ tutto a posto, urlò, ero solo scivolata, sto bene, stai tranquillo.
Sedette sull’erba e pianse. Pianse e capì.
Poco dopo lui era lì, a stringerla, a baciarle la testa, le guance, la fronte. Era lì con l’acqua fresca da bere, frizzante come piaceva a lei, con il disinfettante, un asciugamano pulito. Era un infermiere, un assistente, una guardia del corpo, un poliziotto, un avvocato personale, un dermatologo, un terapista. Uno che darebbe la vita per la sua adorata.
Poi? Quali altri campanelli erano squillati prima che l’oncologo sospirasse fissandola negli occhi?
Si, a ben pensarci, molto prima dell’incidente sul lago, c’era stato un lento allontanamento. Lui aveva preso a guardare le altre donne. Erano tutte donne belle, avvenenti, che stavano al gioco di sguardi. Avevano litigato più volte per questo motivo. Lui mentiva, le ripeteva che lei era l’unica donna della sua vita, che non l’avrebbe sostituita con nessuno al mondo, che la adorava. E le chiedeva perdono. Tornava con un nuovo pacco voluminoso e la notte la stringeva a sé, così come si stringe una madre, una sorella, un’adorata.
Il corpo di lei, lentamente, si adeguava al nuovo ruolo. Stringeva la mano di lui prima di prendere sonno , poi ambedue si giravano dall’altra parte, occupando una sottilissima linea alla fine del materasso, in quel precipizio in cui non cadevano mai. Alla luce che penetrava dalle persiane ella provava silenziosamente a toccare le sue lunghe gambe. Hai delle gambe, le senti Chiara? Hai una pancia, due seni, una schiena. Hai un corpo. Le prime volte funzionava, poi piano piano si convinse. Non possedeva alcun corpo. Era una colata di cemento, un intero, un pezzo di carne lungo un metro e settanta. E si cancellò.
Madre e moglie non cedettero di un passo. Sedute sullo scranno della giustizia, della decenza, della morale, dileggiavano qualsiasi discorso riferito a corpi, a seni e altre scempiaggini. Idiozie da sciocche adolescenti. Non si distruggono le famiglie. Piuttosto ti distruggi, ricordalo.
Il piatto della bilancia, le ripeteva sua madre. Metti tutto sul piatto della bilancia. Cose che possiedi e cose che ti mancano. Se le cose che ti mancano sollevano di poco il peso, allora resta dove sei. Non te ne pentirai.
E lei restò al suo posto, come un soldato. E perse pezzi. L’utero, le ovaie, il seno. Si cancellava lentamente. Se il suo corpo non poteva essere altrove, allora ce lo portava lei, pezzo dopo pezzo, dentro contenitori di asettiche sale operatorie. Andava via restando.
La malattia la santificò. Nel timore di perdere quella donna madresorella, di cui mai avrebbe saputo fare a meno, lui si dedicò a lei con una devozione tale da sfiorare la pazzia.
Quando le caddero i capelli, lui crollò fra le braccia di suo padre e pianse fino a morirne.
Tutto questo fino al giorno in cui l’oncologo la convocò urgentemente. Era un sabato mattina e il professore avrebbe dovuto essere fuori servizio, invece era tornato lì per lei.
Chiara sedette davanti a lui, spaurita e silenziosa. Lui aprì la cartella clinica fingendo di controllare ma improvvisamente chiuse la cartella e sbattendola con violenza sulla scrivania urlò, perché vuole morire Chiara? Lei ammutolì. Voleva davvero morire? Tentò di giustificarsi. Ma professore, non deve dirmi, certo che voglio vivere, certo che voglio lottare.
Non faccia questi giochetti con me, aveva tuonato lui. Capisco benissimo quando una paziente decide di morire. Ora risponda alla mia domanda, perché diavolo ha deciso di morire?
Lei sta osteggiando le cure, lei non crede di potercela fare, è così vero? E se lei dice al suo corpo che è stupido e che non ce la farà mai, mi sa dire perché questo corpo dovrebbe ingaggiare questa dura battaglia in suo favore? Ricordi una cosa Chiara, ogni malattia ha un nome. Riesce a identificare il suo? Non voglio saperlo, voglio che Lei lo riconosca.
Un bolo viscido le ostruiva il respiro. Non riusciva a rispondere.
Chiara deglutì a fatica e con un flebile suono rispose: Papino.
Lui la guardò aggrottando la fronte. Cosa ha detto? Mi sta prendendo in giro? Chi sarebbe questo “papino”?
Chiara tirò un lungo respiro e continuò. Sono io dottore. Mio marito mi chiama così. Papino. Lui mi adora sà, non mi fa mancare nulla.Io ho messo tutto sulla bilancia e il peso è andato tutto su lui e i miei figli. Il mio è troppo leggero. Conta poco. Poi vede, ormai ho anche i miei anni, sono una donna matura. Devo pensare alla famiglia. Lui mi adora. Chieda a mia madre, che conserva tutti i riccioli colorati dei doni che lui puntualmente mi fa, chieda pure. L’uovo del lupo mi porterebbe.
Restarono in silenzio. Un lunghissimo silenzio. Uno di quegli interminabili vuoti che riempiamo lentamente. Mattone dopo mattone. Fino al tetto.
Trascorsero ancora alcuni minuti, poi il professor Berardi spalancò la finestra e le fece cenno con una mano di avvicinarsi. Siamo al settimo piano Chiara, questo lei lo sa bene. Guardi bene sotto, poi mi dica cosa vede.
Chiara non capiva ma si affacciò ugualmente e guardò sotto. Macchine posteggiate, la scalinata, l’edicola per la distrazione al male, la gente che andava e veniva. Niente di anormale. Così tornò agli occhi del professore che incalzò, lei pensa che se si affaccia alla finestra del quinto piano, vede le stesse cose che vede ora?E se si affaccia alla finestra del terzo, del secondo o del primo, lei vede allo stesso modo di ora?
No, dottore, vedrò meglio. E’ logico, rispose velocemente. Dunque? Qual era il nesso fra lei i piani di un ospedale?
Lei non può continuare a vivere una vita da settimo piano. Deve imparare a vivere la sua vita dal primo piano, e dal secondo e dal terzo. Deve poter rivendicare il diritto di scendere e salire, restare o andar via. Deve camminare sapendo che il suo corpo occupa un posto nel mondo, un posto che nessun altro può occupare. Se qualcosa o qualcuno le vive sulla schiena, lo strattoni. Non gli faccia posto. Lei non è una colonia, lei è una donna. In questo ordine perfetto che è il mondo, il suo posto dov’è?
Lei provò a mettere i capelli dietro alle orecchie, ricordò di portare una parrucca e lasciò ricadere la ciocca senza vita.
Gli sembrò che per un attimo gli occhi del professore fossero attraversati da un leggero velo di tristezza. Chiara tese la mano e sentì la stretta vigorosa dell’uomo che raccolse il cellulare, le chiavi e sospirò: Mi raccomando Chiara, scelga la vita. Ci vediamo mercoledì.
Tornò a casa, sedette sulla poltrona e attese il rientro del marito.
Lui si precipitò su di lei e chiese ansioso cosa avesse detto il dottore.
Lei prese del tempo. Restò in silenzio, il silenzio della cura. Lui ripetè la domanda. Perché quell’attesa? Stava forse per comunicargli qualcosa di tragico?
La risposta giunse quando volle: Il mio nome è Chiara. Io non sono né tua figlia, né tua madre, né tantomeno tua sorella. Non permetterti mai più di chiamarmi Papino. Io sono una donna.
Per tutti questi lunghi anni ho più volte provato il desiderio di fuggire, di crearmi una relazione, di amare ed essere amata. Amata non adorata. Sono restata ma questo non ti dà il diritto di trattarmi come se non occupassi un posto nel mondo. Fammi spazio, dunque.
Si alzò e lo lasciò solo, in ginocchio sul tappeto. Salì in camera e si spogliò. Accarezzò a lungo quel corpo odiato e sussurrò: Sono al primo piano dottore. Da qui si vive.
 L'adorata
L'adorata
Racconto
2017