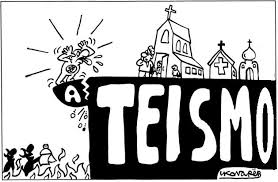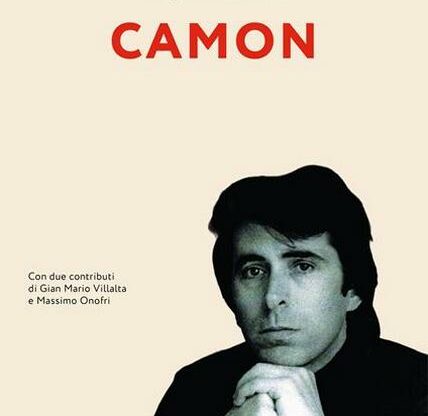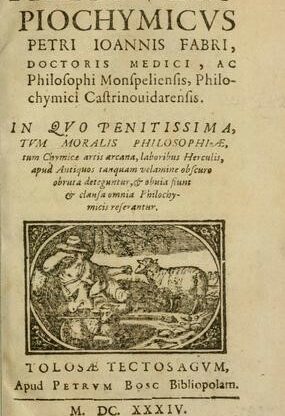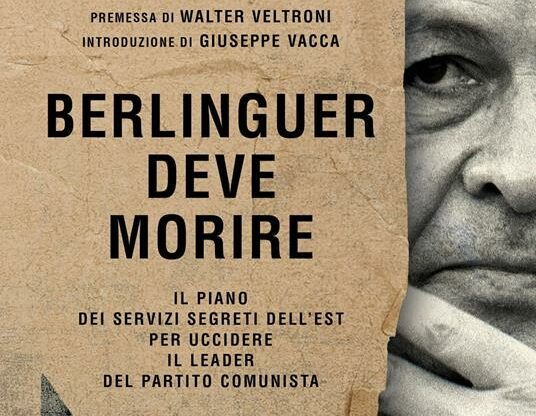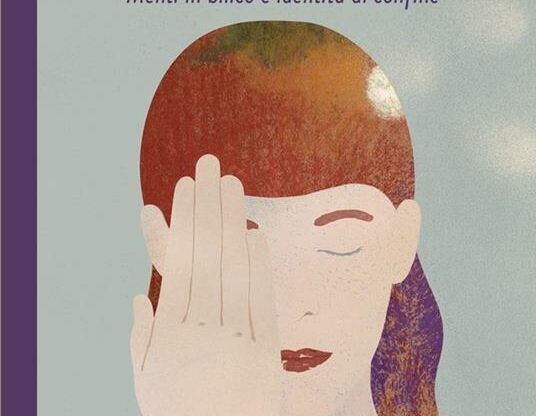Essere confine per attraversare il dolore del mondo. Un libro necessario.
Di Alessandro vergari
“Questo libro parla di confini e di coloro che li violano”, scrive Shahram Khosravi nell’Introduzione al suo Io sono confine, finalmente pubblicato in Italia dall’ottima casa editrice Elèuthera, con la traduzione dall’inglese di Elena Cantoni, a quasi un decennio dall’uscita con il titolo originale ‘Illegal Traveller’: An Auto-Ethnography of Borders. Questo libro, in verità, parla dell’autore stesso, del suo peregrinare e sostare in zone di scambio, del suo trasgredire e migrare altrove, del suo rincorrere la speranza. Khosravi, iraniano del Bakhtiari, antropologo sociale, vive e insegna a Stoccolma. Il suo approdo in Svezia è marchiato da una fuga dall’Iran, attraverso l’Afghanistan, il Pakistan e l’India, tappe di un’odissea “illegale”, che qui viene raccontata in forma auto-etnografica, ovvero alternando la narrazione di esperienze personali con l’analisi etnografica propriamente detta.
La famiglia di Khosravi risiede nella città di Eshafan, pur facendo parte di una minoranza etnica radicata in aree rurali. “Abitavamo nel quartiere ebraico, e dunque mescolati a un altro gruppo minoritario. Conservo due ricordi molto nitidi della mia non appartenenza all’Iran urbano. Il primo risale all’inizio della scuola, quando avevo sette anni. Non parlavo bene il farsi e i compagni trovavano ridicolo il mio accento. Rivedo ancora quella classe di bambini che rideva di me. Il secondo risale alla prima adolescenza, alle medie. Un giorno stavo andando a bere alla fontanella nell’angolo del cortile quando un compagno mi ‘avvertì’ di non farlo: ci aveva appena bevuto un compagno ebreo. L’insulto non era diretto a me, ma mi fece comunque avvertire il peso della ‘diversità’”.
L’anno 1986 segna l’inizio di tutto. Il Medio Oriente è infiammato dalla guerra tra la Repubblica islamica guidata da Khomeyni e l’Iraq di Saddam Hussein. Centinaia di migliaia di adolescenti iraniani sono forzatamente arruolati. La sorte che attende moltissimi di loro è atroce: saranno feriti, mutilati, intossicati dai gas, uccisi. Anche Shahram Khosravi riceve la cartolina precetto.
Messo alle strette dalla convocazione dell’esercito, Khosravi cede e decide di arruolarsi. Sua madre si oppone. Vince, per fortuna, l’insistenza materna, una proibizione motivata dall’amore, un’imposizione che gli salva la vita. Per il giovane l’unica strada percorribile è la partenza precipitosa, l’infrazione dei confini, la fuga. D’altro canto, i bakhtiari non accettano l’idea di migrazione. Soprattutto, non ammettono che un figlio possa abbandonare la propria famiglia. L’andamento dialogico di Io sono confine si muove tra questi contrasti. Ogni volta c’è un muro da abbattere, ogni volta c’è una linea da varcare. Pregiudizi da sconfiggere, per andare oltre e inseguire l’obiettivo di una vita migliore.
Cos’è, quindi, un confine? E come si configura, in termini politici e sociali, un uomo o una donna che lo varca? Viviamo nell’epoca della feticizzazione e della naturalizzazione dei confini, visti come qualcosa di già dato, di rigido e di non revocabile. “Le frontiere sono selettive e discriminatorie. La regolamentazione della mobilità opera attraverso una selezione basata sulle diseguaglianze di sesso, genere, razza e classe. Supera il confine soltanto chi è utile, chi è produttivo. Le frontiere sono una tecnica per calcolare il valore degli stranieri”. È per questo che il ‘clandestino’, declassato da persona a nuda vita biologica, ‘inquina’ la comunità di arrivo ed è sempre il-non-benvenuto all’interno di una ‘patria’. Lo straniero non è desiderato, infrange un ordine inteso, o propagandato, come sacro, rompe la presunta compattezza di un territorio e non apporta nulla in termini di valore aggiunto. Espellerlo è la soluzione migliore per chi governa. Non si sa bene, infatti, cosa fare con lui. O con lei. “Il sacrificio è un atto religioso primario, e il sacrificio di chi viola i confini è parte integrante della religione professata dallo Stato-Nazione, è una manifestazione della sua sovranità”. Il difensore delle frontiere ostenta un diritto, quello di esporre il viaggiatore, sgradito, alla morte. Attorno ai confini il corpo del migrante è particolarmente fragile. “Lo stupro è una prassi sistematica, consolidata e segue gli stessi modelli in ogni luogo del mondo. È diventato un meccanismo di controllo”. Di più: la violenza sessuale è il pedaggio con cui pagare un diritto di accesso, una tassa crudele per sconfinare dall’altra parte.
Khosravi si sofferma sulle figure dei dal lal, i trafficanti di uomini, o per meglio dire i ‘facilitatori’, ingranaggi essenziali della macchina della migrazione illegale. Ad esempio, attorno alla Cannt Station di Karachi, luogo di soggiorno provvisorio e di smistamento per centinaia di clandestini, dove Khosravi permane per otto mesi, è un pullulare di faccendieri che chiedono svariate centinaia di dollari, per agitare davanti agli occhi degli ‘aspiranti profughi’ la possibilità (solo la possibilità, non la certezza) di un passaggio verso la meta agognata. Spesso, i dal lal spariscono nel nulla o differiscono all’infinito la data della partenza. Una legge non scritta recita che quanto più diventano invalicabili i confini, tanto più aumenta il costo economico, fisico e umano del tentativo. Non è raro che un ‘mercante’ si approfitti della ‘merce’ che ha in mano. È il caso di Farhad, un nome che equivale a un rimorso e a un tormento della memoria. “Abitava nella stanza 304, direttamente sotto la mia, insieme a due adolescenti iraniani, una ragazza e suo fratello minore. I due ragazzi avevano consegnato tutto il proprio denaro a Farhad e lui aveva promesso di portarli in Canada”. Le promesse, però, sono un’arma di ricatto. “Si era trasferito nella loro stanza. Da quel momento la ragazza non era più uscita”. L’abuso è appunto una regola. “A chi potevano chiedere aiuto? Erano clandestini, e i soldi risparmiati dai genitori per mandarli in un luogo sicuro li aveva intascati il trafficante che ora li teneva prigionieri”.
Singolare è la testimonianza di Amir Heidari, iraniano di origini curde, forse il dal lal più famoso al mondo. Khosravi lo intervista due volte, entrambe in carcere. Heidari si dichiara un seguace dell’esistenzialismo francese. “Credo che l’individuo abbia la libertà di scelta, e dunque anche la responsabilità che ne deriva. Sono convinto che tutti abbiano il diritto di decidere della propria vita”. Ci troviamo di fronte a un ambiguo imprenditore del dolore altrui che ricorre alla retorica dell’impegno morale per giustificarsi, o, al contrario, al cospetto di un vero benefattore, una sorta di Oskar Schindler dell’epoca della globalizzazione? Heidari, un uomo che allo stesso tempo sfrutta le caratteristiche sicuritarie dell’ordine mondiale e le deplora, nella sua testimonianza, sorprendente e inusuale, auspica una rivoluzione globale a vantaggio del libero movimento delle persone. Ammette di aver lavorato molte volte in perdita, ma di essere comunque felice, e per nulla pentito, del servizio compiuto. “Se credi in ciò che fai, il prezzo da pagare non ha importanza. Anche Socrate ha pagato per le sue convizioni… In Svezia c’è un doppio standard di moralità. Durante la seconda guerra mondiale Raoul Wallenberg ha fatto per gli ebrei le stesse cose che io ho fatto per i curdi. Oggi lui è un eroe e io sono un criminale”.
Khosravi, giunto in Svezia, diviene profugo, perchè profughi si diventa. “È il campo stesso a produrre il profugo, o la sua condizione, attraverso una burocrazia patologizzante”. Il futuro antropologo viene sottoposto a test e ad esami medici, in quanto il nuovo status comporta il riconoscimento ufficiale di una condizione fisica o mentale di minorità, una deviazione dai medi standard di salute. Il profugo, nella prassi spersonalizzante dei riti di confine, deve presentare, all’ingresso del paese ospitante, un corpo infranto dalla tortura, fratturato dai colpi dei carcerieri, o bucato dalle pallottole… Vi si deve leggere addosso, scolpita, la tragedia patita. “Per ‘meritare’ l’asilo bisogna aver sofferto. Si presume che la sofferenza umana si manifesti nei corpi. Le ferite sono accettate come prova oggettiva e ritenute più credibili delle parole. Il corpo funge da testo”. Una misteriosa casistica delle effrazioni e delle efferatezze governa le pratiche di concessione dell’asilo politico. “Quante dita bisogna aver perso in una stazione di polizia di Giacarta? Quanti stupri bisogna aver subito a Mogadiscio?” Il paradosso è dietro l’angolo. Khosravi riporta il tabulato di un interrogatorio, relativo a una pratica esaminata in Inghilterra. L’interessato è un profugo etiope, cui l’asilo è infine negato. Così si esprime il funzionario preposto all’istruttoria: “Riteniamo che tu non sia nel mirino delle autorità, perché in passato avrebbero avuto la possibilità di arrestarti, incarcerarti o ucciderti, e invece non l’hanno fatto”. Eloquente il commento dell’autore: “Il richiedente sarebbe stato meritevole di asilo se fosse stato ucciso, ma ovviamente a quel punto il problema si sarebbe risolto da sé. In altre parole, ‘un buon richiedente asilo è un richiedente morto’”.
Morte che Kosravi vede molto da vicino, il 21 ottobre 1991, quando un razzista, un aggressore seriale di immigrati armato di fucile con puntatore laser, gli spara dritto in faccia, nei pressi del campus universitario. John Wolfgang Alexander Ausonius, “figlio di uno svizzero e di una tedesca immigrati in Svezia, da piccolo era stato tormentato dai bulli per i capelli neri e il nome straniero. Da adulto si era tinto di biondo i capelli e aveva cambiato nome spacciandosi per svedese”. È un classico della psicologia del razzista: un sentimento di frustrazione produce nell’animo un velenoso rancore, e quindi violenza verso i più poveri, i nuovi indifesi, gli immigrati. Tuttavia, anche gli organi di sicurezza partono dal presupposto che l’altro, lo straniero appena arrivato, provochi turbolenze in virtù del suo semplice esistere. Le indagini sono suggestionate dal pre-giudizio, dallo stereotipo, e subordinate a un’esigenza di etichettamento per etnia, popolazione, genere, provenienza. “I primi poliziotti venuti a parlarmi in ospedale avevano già tratto le loro conclusioni sul mio conto e sulle cause dell’aggressione. Mi chiesero se avessi rapporti con la ‘mafia iraniana’ a Stoccolma, se avessi nemici in Svezia o se fossi in contrasto politico con lo Stato iraniano”. Il giorno dopo, un ispettore “si lanciò in una lunga filippica sui problemi causati dagli immigrati iraniani”. Esattamente come gli afroamericani colpiti a morte negli Stati Uniti o gli ebrei perseguitati e sterminati durante il Nazismo, il migrante-vittima se l’è cercata, e pertanto è oggetto di un ribaltamento percettivo: il migrante ha la colpa di essere migrante…
“Da una prospettiva foucaultiana, la ‘produzione di criminalità’ è un modo per creare la ‘norma’”. Ne deriva che “la criminalizzazione dei non-cittadini indesiderati è soprattutto un modo di costruire la cittadinanza… Al cittadino ideale si contrappongono le masse non identificate e quindi ingestibili di stranieri”. È un circolo vizioso, una dialettica perversa, connaturata al discorso sguaiato e ultracinico delle destre di tutto il mondo. In Italia, occorre aggiungere, l’efficacia di tale strategia è massima, funzionale ad un processo di assoluzione collettiva dagli endemici mali nazionali: la corruzione vezzeggiata ed esibita, il mancato rispetto dei principi della Costituzione, l’ossequio feudale per i potenti, l’individualismo sfrenato, il disprezzo per la cosa pubblica (tanto per citarne alcuni). Non vi è nulla di più comodo che spostare il focus dell’attenzione sul nemico esterno, poggiandosi su adeguate “tecnologie di cittadinanza”. Gli autoctoni necessitano di rassicurazioni paternalistiche, per poter rivendicare, ma sarebbe meglio dire lamentare, una priorità assoluta su risorse, beni e diritti.“Le tecnologie di cittadinanza costituiscono un progetto di moralizzazione e ‘responsabilizzazione’ che punta a trasformare i cittadini in soggetti etici e responsabili, contrapposti ai soggetti irresponsabili e immorali, L’antitesi del cittadino ideale è l’anti-cittadino, un individuo che esiste fuori dal sistema di ordinata regolamentazione, che viola le norme costituite e che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini ‘normali’”.
Sulla scia delle riflessioni di Benjamin, Arendt, Derrida, Foucault, Agamben, Bauman, in forza della mole poderosa di concetti mutuati da etnologi, antropologi, sociologi, esperti delle politiche migratorie, filtrati in citazioni qui riportate con puntigliosità e rigore accademico, senza dimenticare le interviste raccolte e le preziose testimonianze degli informatori, la vita avventurosa di Kosravi si srotola e, grazie alla cultura, anzi, alle culture (al plurale) assimilate, acquista significato, entra in un sistema di relazioni, di simboli e di valori. Kosravi trova nelle parole di Étienne Balibar la ragione del titolo. “’Alcuni confini non sono più situati al confine’, nel senso geografico e politico del termine. Sono diventati invisibili, sono ovunque e in nessun luogo, Pertanto gli indesiderabili non sono più espulsi dal confine, sono costretti a essere il confine”. Io sono il confine, tu sei il confine. Ovunque vi sia esclusione e oppressione, è il confine. Sul lavoro, è il confine, laddove una raccomandazione ci sbarra il passo e ci relega ai margini di una carriera. In un’università, è il confine, se il figlio del barone di turno conquista una cattedra senza merito, e ci impone il purgatorio di un ennesimo concorso. In famiglia, è il confine, se ci manca il coraggio per distaccarci dall’aspettativa di successo cullata per noi, contro di noi, da un padre o da una madre. In una coppia è il confine, quando la prevaricazione fisica e/o psicologica è un comando impresso sulla donna, fino a disintegrarne i talenti e i sogni. Negli uffici pubblici è il confine, nei partiti e nei sindacati è il confine, nella sessualità, nella storia di ognuno di noi è il confine. I migranti sono nostri fratelli non in senso astratto, ma nella comune esperienza del pregiudizio, dello stigma, della privazione.
“Guardare la storia dal punto di vista degli sconfitti predispone a una filosofia in grado di ‘organizzare il pessimismo’ – un pessimismo inteso non come attitudine contemplativa ma come presa di posizione attiva, militante, pratica, come strategia politica volta a prevenire i pericoli che incombono sull’umanità”. Non ultimi, i sovvertimenti scatenati dal cambiamento climatico, molla micidiale delle migrazioni di massa, probabilmente incontenibili, che ci aspettano nel futuro prossimo venturo.
Il libro auto-etnografico di Sharham Khosravi, estraneo alle semplificazioni e sensibile alla complessità della questione trattata, è bellissimo, sincero e dolente. Al termine della lettura, un groppo in gola si scioglie in una domanda disperata: Sinistra, dove sei?
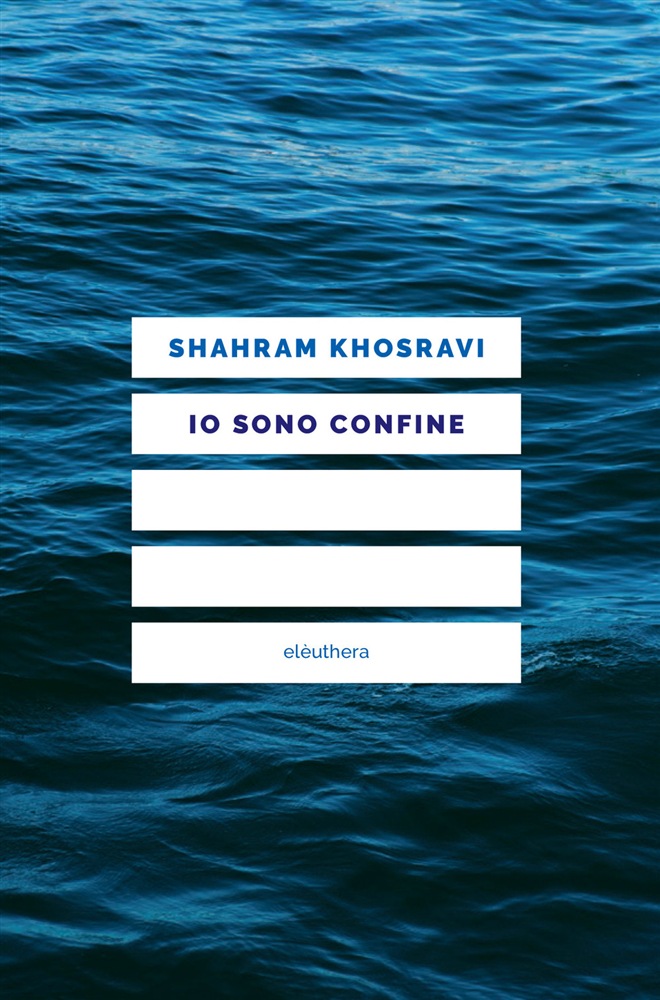 Io sono confine
Io sono confine
Saggistica, memoriale
Eleuthera
2019
238 p., brossura