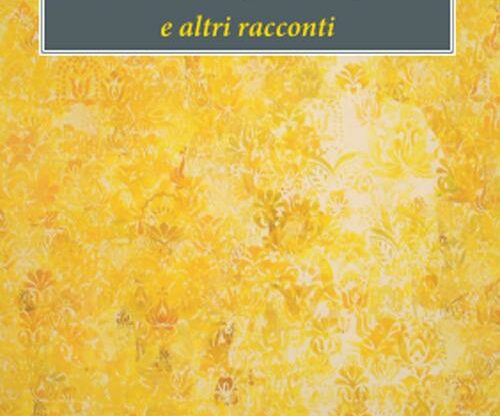| Il libro di Francesco Biscione “Il delitto Moro e la deriva della democrazia”, edito da Ediesse (2012), raccoglie alcuni studi e saggi che l’autore ha scritto tra il 2008 e il 2011.Tutti ruotano attorno a un problema di fondo: la crisi della democrazia italiana. Una crisi, etica, politica, economica e culturale, che arriva ai nostri giorni ma che ha radici lontane e profonde che attraversano la storia della repubblica segnandone il volto fino a sfigurarlo con l’uccisione del Presidente della democrazia cristiana Aldo Moro nel 1978.Francesco Biscione ha scelto di sondarle cercando di riunire i tanti e complessi fili in una trama interpretativa di largo respiro che non arretra davanti alla difficoltà di ridurre a sintesi avvenimenti tanto ampi e articolati che scontano ancora persistenti elementi di oscurità nella ricostruzione storica. E non arretra di fronte alla necessità di armonizzare le acquisizioni della storiografia più accreditata con la politologia e con la storia delle idee sviluppando una tesi di lungo periodo su un piano multidimensionale.
Il risultato è un libro suggestivo che mantiene un impianto sempre coerente anche se sviluppato con una architettura che in letteratura definiremo a “intreccio multiplo”. Un libro con il quale non è facile confrontarsi per la forza dell’interpretazione che offre e per la complessità degli interrogativi che cerca di sciogliere e che solleva a sua volta. Un compendio di una riflessione che l’autore forma progressivamente in una vita di studi e che presenta, sembrerebbe a se stesso in primo luogo, quasi a verificarne consistenza e sostenibilità. Il delitto Moro e la fine della solidarietà nazionale emergono come la rottura di maggior rilievo nella storia del dopoguerra. Certo, gli avvenimenti compresi nel biennio 1989-1991 e gli anni di tangentopoli avrebbero sancito un rivolgimento di tale portata da passare alla storia come “la fine della prima repubblica”. Eppure il sistema era già deteriorato, privo di capacità di rinnovamento e, in fin dei conti, destinato a una dissoluzione che solo la rigidità del quadro internazionale ritardava. Questo lungo tramonto era iniziato con la crisi della sostanziale unità dell’antifascismo conquistata con la Resistenza e la Liberazione. Una unità che, nonostante il clima della guerra fredda, aveva regalato all’Italia una Carta Costituzionale condivisa capace di incarnare un riferimento basilare del disegno nazionale e democratico. La Costituzione fu la proiezione giuridica della prospettiva che le forze politiche antifasciste decisero di riconoscere come patrimonio comune, il confine invalicabile della dialettica politica che si andava componendo di conflitti anche radicali. Il ragionamento di Francesco Biscione è consequenziale; accettarne le premesse significa seguirlo fino in fondo con altrettanta convinzione. Credo, altresì, che meriti una riflessione importante proprio la premessa: la conquista dell’unità antifascista. Il patrimonio condiviso mi sembra possa essere considerato come la vera fase “straordinaria” della storia d’Italia. Non so se chiudesse davvero la “guerra civile” degli italiani del 1943-1945; a mio avviso ne nascose la portata. La rapidità del crollo del fascismo da un punto di vista formale e istituzionale fu verticale, immediata, quasi sorprendente; a livello culturale, intellettuale, di sensibilità politica e di diffusione della mentalità nella società il crollo non fu altrettanto rapido, se mai crollo ci fu davvero. I rivoli della cultura politica fascista invasero la repubblica e il suo spazio etico e spirituale come un fiume che arriva al suo delta: dividendosi in tante ramificazioni, scomparendo e riemergendo. La spaccatura tra l’elites politica e il paese reale, forse la vera grande caratteristica di lungo periodo dell’intera esistenza dello stato unitario nazionale, si approfondì e cambiò segno. La discussione politica, sociale, culturale e intellettuale della tradizione risorgimentale da pubblica, seppur ristretta nell’Italia liberale, finì per essere accompagnata da una continua, sotterranea resa dei conti non sul terreno del confronto ma dello scontro nell’Italia repubblicana. Quanta parte dell’ethos comune della classe politica resistenziale passò nel paese reale, con quante differenze tra il Nord e il Sud del Paese e con quanta strumentalità nell’utilizzo pubblico della storia è un tema che merita, a mio avviso, un ulteriore approfondimento. A questo proposito Francesco Biscione introduce uno degli elementi di maggior interesse del libro: la Costituzione fu elaborata da una classe dirigente formata dalle elites dei partiti antifascisti. Una classe dirigente che l’autore definisce “colta, estremamente composita e compenetrata nelle vicende internazionali che aveva maturato un robusto disegno di ricostruzione del Paese […] nella lotta contro la dittatura questi uomini e queste donne avevano elaborato un linguaggio comune e avevano progressivamente dato vita a un progetto che escludeva sia il puro e semplice ripristino del liberalismo prefascista sia le ipotesi rivoluzionarie di stampo giacobino o sovietico”. Questa classe dirigente, l’unica paragonabile secondo l’autore alla Destra storica per capacità politica e culturale, riuscì a costruire una casa comune nella quale poterono convivere diverse culture e sensibilità che promanavano da una moderna società di massa; fu in grado di gestire e contenere il conflitto, di aprire il Paese alle possibilità che il mercato offriva, di accompagnarlo nella modifica di equilibri civili, politici e morali, di aprirlo alla partecipazione democratica come fine del processo di nazionalizzazione delle masse. Questa classe dirigente offre uno specchio che rimanda a immagini di ben altro tenore: in primo luogo la manifesta insufficiente della classe dirigente italiana che si trovò a gestire la Seconda repubblica, insufficienza politica ma soprattutto morale e culturale e quindi progettale: è interessante l’invito implicito a prestare maggior attenzione alla formazione e alla continuità delle classi dirigenti per leggere i momenti di continuità ma anche di rottura della storia del Paese. Ancor più suggestivo seguire questo percorso in controluce partendo dai limiti con i quali le classi dirigenti a volte si confrontarono a volte si prestarono: i limiti dell’accettazione della cultura democratica, la resistenza di vasti stati sociali ad accettare la modernità in termini di partecipazione e allargamento dei diritti, l’utilizzo degli assetti internazionali per irrigidire tali limiti attraverso un doppio processo condizionante e condizionato, la strumentalità nell’utilizzo di residui, a sinistra come a destra, di pulsioni rivoluzionarie e antidemocratiche. Emerge il tema del “sommerso della Repubblica”, un tema che ha impegnato Biscione in altri lavori, ovvero di una vasta area della società italiana sorda alla democrazia e ai valori della Costituzione che trova la sua genesi nelle modalità di costruzione dello Stato nazionale e attraversa la storia del Paese come un fiume carsico. E alle classi dirigenti è legato il problema, esplorato ma non esaurito dalla storiografia sociale, della sovraesposizione del conflitto sociale e della violenza nella storia dell’Italia repubblicana. Utilizzando le parole di Luca Baldissara: “La rilevanza del conflitto sociale nella storia italiana rappresenta un evidente segnale dei pesanti limiti d’egemonia delle classi dirigenti, tradottisi nel patologico orientarsi verso soluzioni autoritarie (il 1898 e il 1922) o comunque di democrazia protetta (il centrismo di De Gasperi e Scelba, sino al tentativo tambroniano e alle torbide trame della strategia della tensione), ogni qualvolta la classe operaia organizzata riporta in primo piano la questione della sua storica esclusione dalla vita dello Stato. Certo, si potrebbe anche aggiungere che il surplus (di lotte, di sacrifici, di costi umani) richiesto al movimento operaio italiano per accedere alla democrazia (come anche, non senza paradosso, per difenderla) ha contribuito all’elaborazione di una cultura del conflitto che a sua volta ha ridotto i margini di azione della cultura riformista e al contempo enfatizzato l’immagine della funzione nazionale della classe operaia di Togliatti quanto di Di Vittorio. Forse, si potrebbe concludere, la marcata ma inevitabile dimensione politica dell’azione sindacale e la costrizione del riformismo in spazi angusti sono i due volti con cui storicamente non può che presentarsi la dialettica sociale in Italia. E l’ostilità, quando non l’aperto rifiuto, e comunque la periodica messa in questione, verso la legittimità della rappresentanza sindacale e politica degli interessi del movimento operaio è l’elemento che consente il perdurare di questo doppio profilo” Nel libro di Biscione non mancano i riferimenti alla centralità del tema della violenza nella storia dell’Italia repubblicana. L’esistenza stessa di un “sommerso della Repubblica” non è leggibile senza l’originalità con la quale si manifesta il conflitto nel Paese. In una democrazia che fatica a penetrare nell’anima profonda del Paese, con classi dirigenti spesso più attente a “proteggere” la democrazia piuttosto che a diffonderla, con interi settori della società costretti a ricorrere a un conflitto permanente per rendere possibile l’accesso ai diritti, la violenza diventa un canale ineludibile di espressione delle dinamiche sociali. Violenza che trova spettatori interessati sul palcoscenico della politica disposti ad assecondarla e strumentalizzarla in nome di lealtà e interessi non direttamente e indiscutibilmente riconducibili alla democrazia: la strategia della tensione, il terrorismo sono ferite aperte nel corpo della nazione che rimandano alla complessità dell’intreccio democrazia – violenza – conflitto sociale e politico sul quale Biscione ha senso una parte importante della sua stagione di studi. Il “sommerso della Repubblica” è categoria di analisi davvero complessa perché necessita di approfondimenti sul piano politico, sociale ma anche culturale: perché dialoga, a mio avviso, con fili rossi di lungo periodo della nostra storia difficili da sciogliere dall’originale ricezione nel Paese della cultura liberale, sempre mediata e resa “spuria” che rimanda alla solitudine di un Gobetti, all’importanza della cultura idealista della scuola napoletana che incrocia e a volte interpreta il pensiero liberale, all’originalità del pensiero marxista italiano a partire dalla grande lezione di Antonio Gramsci, fino all’eredità della complessità del mondo fascista con il quale non abbiamo fatto fino in fondo i conti passando per la trasformazione del pensiero cattolico dall’antimodernismo dell’Ottocento fino al Concilio Vaticano II. Proprio nel rapporto tra cultura, dato politico e trasformazioni socio-economiche attraversate nei 150 anni di unità trova la sua ragione di fondo il “paradosso” che correttamente Biscione legge e ci propone: “Ciò che si può osservare è che, paradossalmente, allorché la fine della guerra fredda e lo scioglimento del partito comunista aprirono la strada a una democrazia compiuta, cioè a una possibile alternanza di governo e alla stabilizzazione del sistema democratico, più aggressive si fecero le pulsioni del sommerso, fino a stravolgere il quadro delle relazioni politiche e rendere il paese ingovernabile (azzardando un po’, potremmo dire che per la seconda volta in un secolo, dinanzi ai rischi della democrazia, l’Italia ha scelto la reazione – il fascismo prima e il berlusconismo poi). Se dunque vogliamo cercare il senso del paradosso dobbiamo innanzitutto valutare che ben più robusta era la prima anomalia (quella del sommerso) e, secondariamente, mettere in conto l’ipotesi – inquietante e, in fin dei conti, per il paese poco onorevole – che in Italia un governo democratico si è realizzato solo nel periodo in cui un equilibrio internazionale militarmente blindato ha limitato in modo sostanziale le scelte politiche”. Il nesso nazionale – internazionale rimane una delle categorie fondamentali con le quali cercare di leggere correttamente la storia unitaria d’Italia. Ma in questo caso Biscione non torna, e lo specifica anche nell’introduzione, a immergersi nel dibattito nato in seguito alla formulazione di Franco De Felice del tema della “doppia lealtà”, piuttosto sembra suggerire di tornare a guardare le dinamiche interne del Paese e a ragionare su come le rigidità che il sistema internazionale imponeva nei singoli sistemi nazionali siano state utilizzate strumentalmente a vantaggio di specifici interessi o progetti politici. In un panorama di studi che spesso ha posto l’accento sulla dimensione internazionale per spiegare la dimensione nazionale Biscione ci spinge a tornare alle dinamiche endogene e al loro stretto compenetrarsi con le dinamiche esogene. Nel percorso che porta alla rottura dell’orizzonte democratico e antifascista condiviso nato nel dopoguerra e formalizzato dalla costituzione la morte di Aldo Moro è un punto di svolta decisivo e drammatico. Biscione mostra un notevole apprezzamento per lo statista pugliese. Lo definisce il maggior stratega della Dc post degasperiana, il maggior interprete del ruolo del partito cattolico nella società italiana come elemento di stabilità e di progresso, l’interprete consapevole della politica estera del Paese, l’uomo dell’apertura a sinistra e della solidarietà nazionale. E anche uno dei pochi politici con una spiccata visione complessiva dell’Italia capace di guardare ai dati economici, sociali, politici, internazionali per definire lo scenario nazionale e raccordarlo al progetto costituzionale repubblicano. Moro è l’uomo che legge correttamente la crisi della democrazia italiana, la necessità di ricomporre il quadro politico sulla base delle nuove condizioni e del progetto costituzionale repubblicano, le tensioni che pulsano in settori delle istituzioni e della società e la necessità di una discontinuità politica. La sua ultima operazione politica consisteva nel disarticolare il reciproco assedio tra Dc e PCI facendo perno sulla politica di solidarietà per aprire l’Italia a una condivisa alternanza di governo delle maggiori forse politiche. Era in gioco la tenuta del Paese e andava messo in campo un disegno egemonico di direzione intellettuale e morale. Non mi soffermo sulle valutazione che l’autore fa di Aldo Moro e che per molti versi trovo condivisibile. Piuttosto, Biscione allarga lo sguardo e legge attraverso Aldo Moro la complessità di un partito come la Democrazia cristiana; il partito cattolico ha molte anime e ancor di più ne rappresenta. E’ parte del comune sentire che dai Comitati di liberazione nazionale alla Costituzione costruisce l’orizzonte della democrazia italiana ma, attraverso un disegno egemonico, “costituzionalizza” anche parti del Paese che non si riconoscono completamente in quell’orizzonte. Ha una capacità di direzione che consente, certo attraverso tanti e pericolosi compromessi, di tenere sotto controllo giocatori occulti che tendono a fuoriuscire dalle regole del gioco democratiche. La fine della democrazia cristiana e il conseguente libero dispiegarsi di forze populiste e in qualche misure avventuriere negli anni della seconda repubblica ci restituiscono la necessità di ripensare il ruolo della DC nella storia del Paese senza accontentarci di visioni semplicistiche o semplificatorie che ne svalutino la funzione democratica di contenimento di un’area del Paese a-partecipativa che aveva subito la Costituzione più che condividerla. Mi colpisce la difficoltà di leggere il rapporto tra lo statista pugliese e il suo partito: penso che Moro rappresentò un punto di mediazione, anche avanzato, delle tante anime della Dc. Un punto di mediazione è certamente un merito perché rappresentò un contenimento delle forze più reazionarie ed eversive della destra conservatrice ma è pur sempre un compromesso che nasconde cedimenti alla gestione del potere accettabile in chiave realistica ma che contribuì a rendere meno limpido il discorso politico evitando che il dibattito assumesse, di fronte ai cittadini, la forma di un confronto chiaro e di scelte nettamente alternative. La “gestione” del sommerso nasconde il problema di quanto Moro riuscì a governare la complessità del partito o di quanto la complessità del partito finì per “gestire” Aldo Moro. Aggiungo che a mio avviso andrebbe ripensato anche il ruolo delle forze progressiste e antifasciste e dello stesso PCI nella sua evoluzione. Credo meriti più attenta considerazione la suggestione di Biscione sulla vera alterità del PCI: l’essere stata l’unica esperienza di protestantesimo di massa della storia d’Italia. Il delitto Moro, il rapimento, i cinquantacinque giorni, tutti i misteri raccolti e intrecciati in quel drammatico evento, non a caso coevo a vicende che segnarono sostanzialmente e simbolicamente la crisi della democrazia italiana come gli scandali Sindona, Calvi, la vicenda di Banca d’Italia, disegnano la trasformazione radicale del quadro politico italiano. Con la morte di Moro fallisce il suo progetto politico, la solidarietà nazionale si trasforma in un guscio vuoto senza contenuti, si aggrava la convenzione ad excludendum del PCI che inizia una lunga agonia privo di progetti politici credibili, la Dc si ritrae a partire dal Congresso del 1980 in una gestione del potere priva di prospettive mentre l’auge del craxismo lasciava intravedere uno stravolgimento del progetto costituzionale. La vera eredità del delitto Moro verrà alla luce solo negli anni Novanta quando la fine della guerra fredda e la scomparsa dei partiti che avevano composto il quadro costituzionale svelerà tutte le arretratezze del paese. Nel vuoto del mercato politico aperto dalla scomparsa della Dc e con la fine delle rigidità imposte dal sistema internazionale la contesa per il potere avviene tra forze non comunicanti, reciprocamente delegittimanti per via di orientamenti costituzionali diametralmente opposti. Al posto di un agone comune subentrano progetti radicalmente alternativi: uno di difesa della Costituzione e uno di messa in discussione costante della stessa. E’ una deriva politica inarrestabile che dietro una presunta conquista della logica dell’alternanza nasconde l’ingovernabilità del Paese. Accanto alla deriva politica, altrettanto inarrestabile è la deriva morale e intellettuale: scompare il senso della collettività, delle comuni radici, del confronto di idee in un orizzonte valoriale condiviso. La rottura del progetto repubblicano-costituzionale e la disgregazione delle forze ideologico-politiche che avevano tenuto insieme la nazione segna una rottura drammatica di quella ricca tradizione del pensiero italiano che aveva visto De Ruggiero e Gobetti dialogare con Gramsci, che aveva letto insieme la tradizione di Machiavelli, Vico e Cuoco per trarne, pur in presenza di progetti politici diversi, una condivisione di un modo specifico e originale della modernità italiana. La crisi della nazione diventa soprattutto crisi spirituale, perdita del senso della nazione e della democrazia, accettazione acritica di uno spirito di rinuncia che non trova più compensazione ne sul piano etico ne su quello intellettuale anche se, naturalmente, non mancano reazioni da parte di settori importanti della società civile e del mondo politico. __________________________ Edmondo Montali è ricercatore della Fondazione Di Vittorio. Si occupa della storia italiana ed europea, con particolare attenzione per il sindacato e il mondo del lavoro. Tra le sue pubblicazioni Il sindacato, lo Stato nazionale e l’Europa. Il sindacalismo tedesco e il processo di integrazione europea (1945-1963), Ediesse, 2008; 1968: l’autunno caldo della Pirelli: il ruolo del sindacato nelle lotte operaie alla Bicocca, Ediesse, 2009. Tra i volumi curati per i 150 anni dell’unità d’Italia, si segnalano I 150 anni dell’Unità d’Italia: risorgimento, unità nazionale e lavoro,Ediesse, 2012; Unità e libertà nell’Europa delle nazioni : i Risorgimenti italiano e tedesco a confronto, Ediesse, 2012. |
 Il delitto Moro e la deriva della democrazia
Il delitto Moro e la deriva della democrazia
Saggi
Società - Politica
Ediesse
2012
Brossura
145
www.officinadellastoria.info