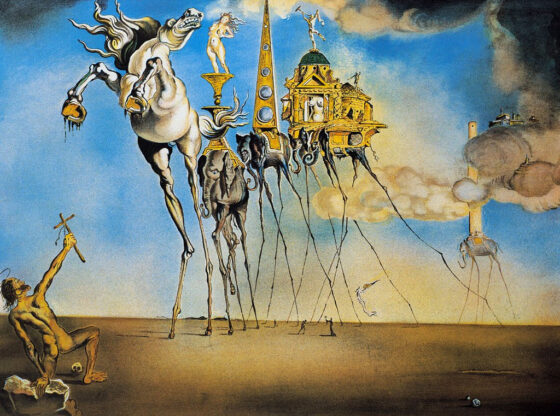AQUÌ SE QUEDA LA CLARA. STORIA DI ANTONIO CERVI, IL COMANDANTE
Di Gino Cervi
Giovedì sera, verso le 20, ho salutato il Comandante. Intorno al letto c’erano due infermieri, un uomo e una donna. Il Comandante sorrideva. Alla donna, ovviamente. L’infermiere diceva: “Antonio, allora, l’abbiamo finalmente trovata la cura. Per te ci vogliono solo infermiere! Adesso vado di là e lo dico io ai dottori: ma che ossigeno, e antibiotici… Solo infermiere, possibilmente carine”. Il Comandante, che da qualche giorno comunicava solo con gli occhi, li ha spalancati ancora di più, ancora più celesti del solito. Era il suo modo per approvare la proposta di cambio terapeutico. Gli ho dato un bacio sulla testa e sono tornato a casa. L’ultima volta che l’ho visto sorrideva. All’infermiera. Il Comandante, quando ieri mattina, il 15 marzo 2019, se n’è andato, aveva novantasei anni, nove mesi e ventisei giorni. Era nato il 17 maggio 1922. Mussolini aveva già fatto danni, ma il peggio doveva ancora arrivare. All’Antonio, anzi, al Tugnìn – come lo chiamava la sua nonna, anche lei Tugnina, allevatrice di oche e segnatrice di malattie – toccò vestirsi da balilla, saltare nel cerchio ai Littoriali, fare il saluto romano e libro e moschetto eccetera eccetera. Gli restava però anche un po’ di tempo per giocare centravanti nel Gambolò e, come diceva lui con orgoglio tutto rurale, per saltare i fossi “a la lunga”. I fossi probabilmente incominciò presto a saltarli anche con le giovani mondine che a maggio arrivavano in banda nelle cascine della Lomellina: sulle aie le prime sale da ballo, nei fienili le prime lezioni d’amore. Tutto finì però troppo presto. La guerra, a vent’anni, è una cosa che neanche riesco a immaginarmelo. Arrivò la chiamata alle armi: le divise estive a Cuneo, nell’inverno del ’42, e quelle invernali ad Agrigento nell’estate del ’43. Della Valle dei Templi ricordava solo il pagliericcio, le cimici e le zecche. E siccome dicevano che lì sarebbero arrivati presto gli Alleati e ci sarebbe stato da sparare davvero, gli parve saggio iscriversi a un corso di meccanico carrista ad Ancona. Era il luglio del ’43. Tempo di prendersi una brutta flebite, di passare qualche settimana in ospedale e poi in licenza a casa per convalescenza, e di tornare quindi ad Ancona, in tempo per essere trasferito di stanza, lui e il battaglione, a Trento. L’8 settembre lo passò nel cortile della caserma a chiedersi, come quasi tutti, che diavolo stesse succedendo. Quindi la decisione: si torna a casa. Erano in due, lui e il suo amico di Pescantina, provincia di Verona. Fecero pochi chilometri lungo la sponda dell’Adige, direzione sud. Appena il tempo di buttare alle canne le divise e vestirsi di qualche straccio borghese recuperato chissà come, che finirono in bocca a una pattuglia tedesca. Fine della fuga. Si ritrovò insieme a tanti altri su un carro piombato. Brennero, Innsbruck e poi Bad-Sulza, in Turingia, nello Stalag IX-C. Per 20 mesi, dal settembre del 1943 al maggio del 1945, fu un IMI, un Italienische Militär-Internierte, uno dei 600.000 soldati italiani catturati che preferirono il campo di detenzione e lavoro invece di continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco. L’Antonio tornò a casa alla fine di agosto del 1945 che pesava 42 chili. Ma era tornato, ed era già molto. Recuperò il peso e le forze necessarie per il raccolto del riso a ottobre e per ricominciare in fretta una nuova vita. Vita da fittavolo, a tirare la corsa a una famiglia numerosa, a provare a portarla fuori da un mondo antico di buoi e cavalli, di aratri e carri dalle ruote di legno, di falci e rastrelli. E a litigare col padre per l’acquisto del primo trattore, testacalda il trattore e, secondo il nonno, anche lui, il figlio. Che però aveva ragione a pensare che la famiglia fosse troppo angusta per diventare un’azienda, di quelle dove devi sapere guidare l’erpice ma anche tenere un bilancio, programmare la produzione di latte e contrattare il prezzo del riso al mercato. Roba da comandante, insomma. E coi gradi conquistati non al fronte, dove al massimo era stato caporalmaggiore, ma sul campo, inteso come pertiche pavesi, come produzione al metroquadro, come quintali di latte da vendere alla Centrale. Fu così che il Comandante Antonio fece il grande salto, con al fianco la Rosetta, che era mezza milanese, faceva la sarta, ascoltava Modugno, teneva a Coppi e al Milan. Ma soprattutto che in cascina, tra i cognati, le manze e le oche, non ci voleva stare. Erano gli anni Sessanta, anzi il 1960, quello delle Olimpiadi a Roma, in settembre, e qualche settimana dopo del loro viaggio di nozze, sempre a Roma, a vedere il Papa, come oggi si vanno a vedere le spiagge dello Yucatan o i grattacieli di Dubai. L’azzardo, spalleggiato dalla Rosetta che “vedeva il bicchiere sempre mezzo pieno”, fu quello di rimettersi in gioco a 46 anni. Via allora dal lavoro coi fratelli: per quasi due stagioni aspettò che arrivasse l’Occasione Buona, quella che gli consentisse di giocarsi al meglio le sue carte. Quei due anni furono il nostro, il mio e il suo, parco-giochi: avevo 4 anni e giocavo con lui nel cortile sotto casa, la clèr di un garage a fare da porta e a rimbombare a ogni gol segnato; a imparare a fare i colpi di testa senza chiudere gli occhi; a girare in bicicletta per il paese, Besate, all’epoca quattro case che scivolavano giù nella vallata e nei boschi del Ticino. L’Occasione Buona fu una grande cascina monumentale nella campagna lodigiana, a Borghetto: Cascina Barbavara. La più bella casa in cui abbiamo mai abitato, un’ala del palazzo padronale, con le scale di marmo, il parquet a listelli obliqui, la cucina con il lavello in pietra e un grande tiglio profumato nel giardino. Lì, il Comandante iniziò a davvero comandare. Faceva “l’agente agricolo”, si diceva in casa. A me, a dire il vero, sembrava purtroppo che facesse quello che faceva prima, e infatti basta pallone, basta colpi di testa, basta bicicletta. Però “l’agente agricolo” già dal nome suonava molto più importante, una cosa di responsabilità, anche con un che di romanzesco, di avventuroso, quasi come se l’agente, fosse più che agricolo, segreto. La mamma dovette accettare la cascina, con ancora più manze, e vacche e trattori, ma senza oche e cognati. Sarà per quello che si adattò. Fece addirittura la patente di guida per potermi accompagnare in macchina a scuola. Prima elementare, dalle suore di non so quale congregazione a Borghetto Lodigiano. Ricordo però il nome di due suore, Noemi ed Emerenziana – giuro: non era la Macondo di Garcia Marquez – e, se mi concentro bene, riesco ancora a sentire l’odore colloso del riso scotto del refettorio. Ma era proprio il riso che mancava al Comandante, i campi da allagare ad aprile e da curare in estate fino al raccolto a ottobre, con le grandi mietitrebbie che tagliavano fino alla sera al buio. E così dopo due anni si tornò nel Pavese, proprio nei boschi del Ticino, alla Zelata, alle Cascine Orsine. Lì di riso da coltivare ce n’era a volontà e il Comandante visse, per quasi vent’anni, la sua lunga stagione “di comando”: mica tutto liscio, s’intende. Di lì a poco, gli vennero a dire che quello che aveva sempre fatto, le tecniche, i concimi, i diserbanti, doveva scordarseli. Si tornava a coltivare come un tempo, al naturale, anzi mettendoci anche qualcosa di più, qualcosa di quasi magico: tipo le corna ripiene di letame da sotterrare, i composti di erbe e liquidi da miscelare sempre girando nello stesso senso, e con particolari condizioni di luna, e altre robe un po’ filosofiche – l’antroposofia, l’euritmia, Rudolf Steiner – e un po’ matte, come parevano al Comandante. Era la biodinamica, che a metà anni Settanta, alle Cascine Orsine, era una roba da pionieri. E anche da sconsiderati, a giudizio del Comandante, che doveva far quadrare conti e bilanci con il crollo quantitativo della produzione dei raccolti e l’aumento esponenziale dei costi di manodopera. Tornare a lavorare come ai tempi del Carlocodega al Comandante gli sembrava di essere tornato a litigare con suo padre per l’acquisto di un trattore nuovo o per quello di un toro da monta dal pedigree molto più performante. Quello della Cascine Orsine era però un laboratorio, e soprattutto grazie alle risorse quasi illimitate messe a disposizione dalla “proprietà” – come la chiamava lui, e a me sembrava un’entità astratta, impalpabile e allo stesso tempo onnipresente e immanente – si inaugurò, non senza qualche patema e qualche buffa conseguenza, il ritorno, graduale, a un’agricoltura sostenibile, pulita,a ciclo quasi chiuso, dove i foraggi prodotti dai campi senza chimica alimentavano il parco bestiame che a sua volta, ovviamente, produceva latte di migliore qualità; dove il riso tornava a essere un prodotto di eccellenza organolettica, e non una sottoprodotto semi-industriale. Poco per volta, il Comandante, da scettico che era all’inizio, divenne il direttore d’orchestra di questo singolare esperimento di agricoltura biologica e biodinamica, quarant’anni fa una frontiera esoterica, oggi una solida realtà nel panorama dell’agricoltura nazionale. Poi, però, a 65 anni, disse basta. Considerando che, pause belliche a parte, la misura bassa e faticosa della terra l’aveva sperimentata da almeno 50 anni, aveva ragione lui. Il trauma del pensionato “e-adesso-cosa-faccio” non lo sfiorò neppure. Da indaffaratissimo manager di campagna passò di punto in bianco a distaccato flaneur di città di provincia: libri, giornali, passeggiate. A 75 rimase solo. La Rosetta, di lui più giovane di sette anni, lo prese in contropiede. “E adesso, che si fa?” mi chiesi io. Da una vita il Comandante era “viziato” dalla presenza di due donne, di due “regiure” di chiara fama, la mamma e la nonna Sandrina, il vero impeccabile e implacabile nostromo di vascello: entrambe se ne andarono nel giro di sei mesi e lui rimase solo. E ovviamente al comando. Di bianco e celeste non aveva la maglia, ma i (non molti) capelli e gli occhi. E s’inventò allora la sua ultima fuga, la sua personale Cuneo-Pinerolo. Come se lo avesse sempre fatto nella vita, divenne un perfetto casalingo: cucina, spesa, pulizie, all’occorrenza baby-sitter. Ma soprattutto, con la saggezza pari solo alla sua naturale discreta eleganza, riscoprì l’antica passione per il ballo. Centri diurni e balere pomeridiane, il Comandante fece strage di gare di ballo e di qualcosa altro, probabilmente. Il target era ampio – si sa che la percentuale di sopravvivenza femminile nella terza età è molto più alta di quella maschile – e il Comandante andò più volte a bersaglio. Fino a quando incontrò, tra un giro di valzer e una mossa di bachata, la Carla, la signora Carla, la sua compagna di questa ultima parte della sua lunga corsa a tappe. Con la Carla furono tornei e coppe conquistate, che sono rimaste in bella vista sulla cassapanca del soggiorno. E furono interminabili partite a scala quaranta. E vacanze fuori stagione a Pugnochiuso e a Sorrento, a Villasimius e a Fontane Bianche, oltre alle puntuali parentesi termali: Boario, Salsomaggiore, Chianciano, dove il Comandante sfoggiava camicie colorate e leggeri foulard e scarpe chiare, faceva ingelosire la Carla e non saltava un giro di danza, anche le mazurche più saltellanti. Così è stato fino a meno di quattro anni fa. Poi una caduta, un femore scanchignato, la Carla anche lei sempre più malandata, i ricoveri ora di uno ora dell’altro, il cuore, l’insufficienza renale, e poi ancora il cuore, e la Carla che, a dispetto di tutti i suoi morosi sotterrati molto prima di lei – cosa che faceva dapprima temere il Pepe per l’integrità del nonno – mollò il colpo – e lui che la salutò in lacrime trattenute dicendole “Carla, l’è la vita!” – , e poi ancora l’infinito dentro-e-fuori dal Santa Margherita, fino all’ultimo chilometro della settimana passata, dopo la corsa al Pronto soccorso e l’allettamento in reparto di Medicina. La fiamma rossa, Comandante, mio Comandante, l’hai superata col fiatone, sempre più corto, sempre più affannoso, ma comunque sempre con dignità e con coraggio. Senza quasi voler far pesare sugli altri la malattia, l’infermità, sui dottori, sugli infermieri, sulla Cris e sulla Maria, su di me. Tenendo sempre il dolore per te, come qualcosa di naturale, come qualcosa che aveva necessariamente a che fare coi tuoi novantasei anni, quasi novantasette di vita. “I dolori voglion dire che sei vivo”, dicevi. Ora, infatti, basta dolori. E adesso, che pur non sei più niente, continui a esser di me la gran parte.
In copertina Gino Cervi. Foto di Renzo Chiesa