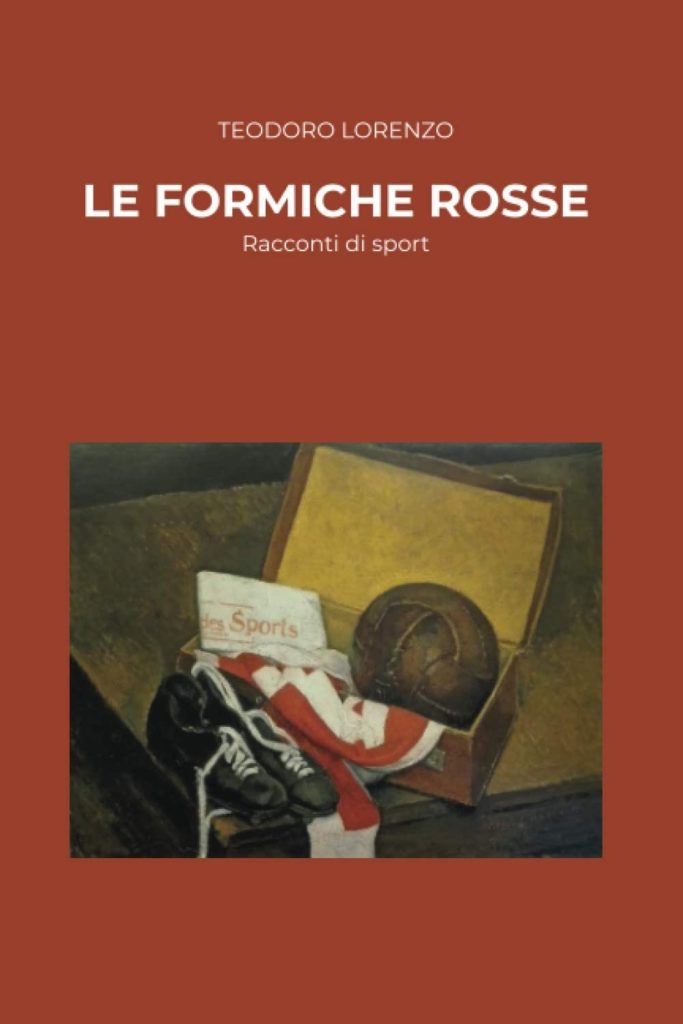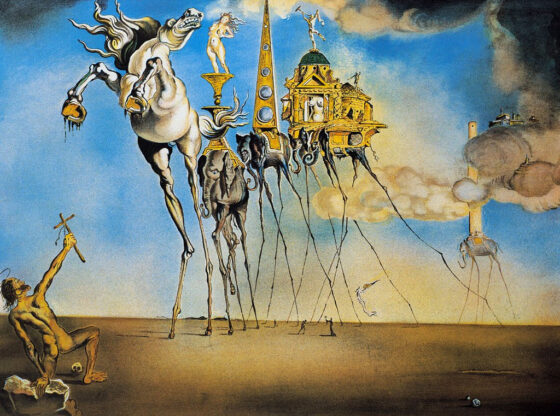SALUTI DA BUENOS AIRES
Racconto di Teodoro Lorenzo, tratto dal suo libro Le formiche rosse, racconti di sport
L’avevo pregata di chiedere all’amministrazione del Sant’Anna la cartella clinica della madre e di portarmela in studio. Ci avrei pensato io a farla avere al dottor Monaco, il medico legale, in modo che potesse scrivere la perizia conclusiva relativa al suo infortunio.
La signora Capuano era stata ricoverata una decina di giorni in ortopedia ed aveva subito un intervento ai legamenti del ginocchio, rotti a seguito di una caduta da una scala mobile della “Rinascente”, bloccatasi improvvisamente e inspiegabilmente all’arrivo al piano.
L’Associazione Consumatori, alla quale si era rivolta, aveva incaricato me di seguire la pratica legale e fu Isabel, la figlia,ad avere i primi contatti con il mio studio.
Ci vedemmo diverse volte e simulando un interesse professionale mi feci raccontare ogni particolare della sua famiglia. In realtà di professionale non c’era nulla, o comunque ben poco. La verità è che lei mi piaceva; per questo la trattenevo molto oltre il necessario.
A pensarci la pratica quotidiana della ginnastica era stata sicuramente determinante nel delineare quelle forme. Manon era l’aspetto fisico il motivo della mia attrazione, non solo quello almeno.Èdifficile da spiegare ma aveva comunque a che fare con la musica. Lei era attraversata da qualcosa di musicale, sembrava che ascoltasse una melodia tutta interiore e uniformasse a quel ritmo i suoi passi, i suoi gesti, perfino le sue parole. Così che a starle accanto venivi preso da una sorta di incantamento, una malìa esotica e misteriosa; lei era un flauto che ipnotizzava.
L’ultima volta che la vidi fu proprio quando mi consegnò la cartella clinica della madre.
Era sconvolta, si muoveva a scatti. Era stonata e fuori tempo. Pensai che dovesse essere successo qualcosa di grave perché della sua musica non vi era più traccia.
Ed anche le parole furono aspre e scordate: “Laparatomia, capisce avvocato. Mia madre nel settantasei aveva subito un intervento di laparatomia “.
Poi se ne andò di corsa, senza nemmeno salutarmi. Non la vidi mai più. Ed io non avevo capito nulla di quel furore.
Era nata a Buenos Aires ma i suoi genitori erano di un angolo sperduto della Campania: San Gregorio Matese, provincia di Caserta. Non vi affannate a cercarlo sulla carta geografica perché non lo troverete.
Anche lì, in mezzo a quelle pietre di ruvida miseria, pulsava il sogno di una vita diversa e il padre partì verso Buenos Aires sulla scia di un fratello che aveva già tentato l’avventura e mandava lettere piene di mirabilie raccontando entusiasta una terra tutta nuova, piena di opportunità.
Prese la nave a Genova, la traversata durò quindici giorni, passati quasi tutti sul ponte a contemplare il mare e a interrogare il futuro.
Era un mare sconosciuto quello che stava solcando, denso e profondo da mettere i brividi. E adesso la sua anima tremava. Forse non era stata una saggia decisione la sua. Forse non doveva staccarsi dalle pietre del suo paese, quiete e conosciute. Se era nato lucertola doveva rimanere attaccato a quei muri, accettare il suo destino e non improvvisarsi squalo.
Non era fatto per navigare quei mari ma era tardi ormai per ogni ripensamento: la linea dell’orizzonte si spostava ogni giorno più avanti e trascinava con sé tutta la sua vita.
Lui, come tutti gli italiani su quella nave, quelli che lo precedettero su quella rotta e quelli che lo seguirono,provarono gli stessi sentimenti e le stesse emozioni di quel primo italiano che la percorse. Come Cristoforo Colombo anche lui, anche loro, si portarono dentro un sogno da realizzare, l’angoscia dell’ignoto e la paura di non farcela.
Arrivato a Buenos Aires si sistemò nel quartiere del porto, la Boca, dove c’erano suo fratello e tanti italiani.
L’Argentina non lo deluse anche se non era l’Eldorado descritto nelle lettere; non c’era l’oro, che in verità non aveva nemmeno voglia di cercare.
Domenico Capuano non aveva l’animo dei Conquistadores. Rimpiangeva i muri calcinati del suo paese e aveva l’animo della lucertola.
Non ambiva a grandi ricchezze, non voleva accumulare tesori; voleva solo trovare un posto dove potersi godere in pace i raggi del sole.
Il sole alla Boca non mancava mai e la tranquillità, ed anche un certo benessere,glielo diede la bottega di frutta e verdura che aprì quasi subito. Lui non l’avrebbe mai ammesso né tantomeno se ne sarebbe vantato ma in giro lo dicevano tutti: Don Mimmo dietro il bancone ci sapeva fare.
La frutta fuori dalla sua bottega era un’esplosione di colori. Sistemava le cassette con una precisione geometrica, appoggiandole al muro su un piano inclinato. Erano i petali dei fiori che attirano le api e i passanti non resistevano a quella tentazione cromatica: la verduleria di Don Mimmo era sempre piena.
Alla sua frutta dedicava attenzioni che avrebbe ritenuto eccessive anche per sé.
Le pere le esponeva nella stessa posizione, tutte indistintamente con il picciolo all’insù come soldati in parata all’atto del presentar arm. Le banane le attaccava al soffitto con tutto il casco ed i clienti si servivano da soli staccandone secondo il bisogno, immaginando di essere in qualche piantagione brasiliana e non nel centro di Buenos Aires. Quanto alle mele la mattina presto, prima di aprire,le faceva lucidare con un panno bianco, una ad una,da un paio di ninos di strada chiamati con un fischio: al termine dell’operazione da quella cassetta si sprigionavano bagliori di diamante.
Quando ritenne di essersi assestato chiamò a sé la moglie, la signora Maria Capuano per l’appunto, per dividere con lei sole e benessere in parti quasi uguali. Domenico Capuano era pur sempre un uomo del sud e la mentalità di quei luoghi e di quei tempi prevedeva che la donna rimanesse sempre un passo indietro, sempre un po’ in ombra rispetto al paterfamilias .
Poi nacque lei, Isabel, anche se in Argentina quelli non erano tempi propizi ad un futuro di speranza.
Una sollevazione di militari aveva portato al potere il colonnello Videla. La libertà era diventata un ricordo, cominciava l’epoca della dittatura.
Ma in queste cose Domenico Capuano non voleva entrarci, non erano questioni che lo riguardavano. Era una cosa loro, degli argentini, e se loro avevano deciso così, volenti o nolenti, così doveva essere.
A lui bastavano sole e muretto, non voleva altro, non chiedeva altro e memore dell’antico adagio dei vecchi saggi di San Gregorio Matese, “Male non fare paura non avere “, continuava la sua vita di sempre, convinto che nessuno sarebbe andato a disturbare la sua quiete, perché lui di male non ne aveva mai fatto a nessuno.
E poi, dittatura o no, Italia o Argentina, alla fine era sempre la stessa storia. Bastava avere le conoscenze giuste e tutto si sistemava. E lui la conoscenza giusta ce l’aveva.
Non veniva forse a rifornirsi di frutta nella sua bottega la moglie del generale Ramon Montero, alto papavero dell’Esercito?
Non solo, Maria Capuano aveva perfino ricevuto il grande onore di essere invitata da Dona Gladis, la moglie, a prendere il mate nella sua sfarzosa villa di Belgrano, il quartiere dei ricchi.
Era la casa di un principe quella e Maria Capuano quel pomeriggio non riuscì a nascondere il suo imbarazzo di fronte a una tale cornucopia di quadri, tappeti e ceramiche. Un particolare le si impresse nella mente: la bombijia nella tazza. Aveva ormai imparato a conoscere le usanze argentine, aveva già visto quella specie di cannuccia con i fori in fondo con cui si beve il mate, ma l’aveva sempre vista di metallo; quelle di casa Montero erano d’oro.
Quando lo raccontò alle comari della Boca vide riflettersi nelle loro facce la sua stessa meraviglia. E l’oro di Dona Gladis passò di bocca in bocca fino a diventare leggenda.
L’imbarazzo di Maria Capuano scomparve nelle visite successive, perché ve ne furono altre, e la bombijia d’oro cessò di essere il Santo Graal, il mirabolante oggetto delle favole,per entrare nel novero delle abitudini casalinghe.
La gentilezza della signora Montero aveva reso quegli incontri distesi e colloquiali. Pur essendo salita a quelle altezze sociali, Dona Gladis aveva mantenuto una bonomia quasi popolana. Forse perché era da lì, dal popolo, che proveniva e le proprie radici non si scordano mai. In fondo la potente Dona Gladis non era che una starlettina semisconosciuta che bazzicava i corridoi della televisione alla ricerca di qualche comparsata quando gli occhi del generale Montero la videro decantare le qualità di un dentifricio in una breve apparizione pubblicitaria. O almeno così si raccontava alla Boca ma magari anche questa era solo una leggenda, come l’oro di Belgrano.
In ogni caso Maria Capuano si era completamente affidata a quella gentilezza finendo con il raccontare vita, morte e miracoli della sua vita e di quella del marito. Anche quelle cose che forse il pudore avrebbe consigliato di tenere per sé, anche le più intime e segrete. Come il desiderio di avere dei figli nonostante un intervento chirurgico che disgrazia delle disgrazie, le impediva di diventare madre.
Il generale Montero era più austero, non si lasciava avvicinare ma più di una volta Domenico Capuano lo aveva servito personalmente nel suo negozio e dopo il solito teatrino – “Pagare? Non sia mai generale. È un onore vederla nella mia bottega”- forte dell’amicizia che legava le due donne, si era convinto di essere entrato anche lui in una qualche confidenza.
La pantomima del resto non gli era costata nessuna fatica. Da uomo del sud se ne intendeva di padroni e servi e sapeva bene come comportarsi. Ce l’aveva nel sangue antico di millenni lo strapotere degli invasori, greci romani svevi normanni angioini e tutta la litania degli stranieri su su fino ai Borboni, e ai Savoia.
Sapeva come trattare i padroni, sfruttando la furbizia antica della plebe. Che si inchina al potere trattenendo il riso. Ed il generale Ramon Montero in cuor suo gli suscitava una gran risata.
Sembrava un tronfio generale d’operetta, un rinaldo in campo. Ad ogni passo tintinnavano le decorazioni che aveva sul petto, ricordo di inesistenti atti di eroismo.
Isabel parlava dell’Argentina con struggente nostalgia. Gli occhi al ricordo le si illuminavano di pagliuzze dorate.
Se Domenico Capuano rimase deluso dalla nascita di una femmina, invece di un maschio che avrebbe perpetuato il suo nome, non lo diede mai a vedere.
Per Isabel pretese il meglio. Innanzi tutto una scuola privata, la più esclusiva, il Collegio San Nicolas. Fu lì che Isabel imparò la disciplina, la ginnastica e la musica.
Ogni mattina le lezioni cominciavano sul piazzale davanti all’ingresso. Tutti gli studenti dovevano assistere sull’attenti alla cerimonia dell’alzabandiera. Lei lo faceva con gioia.
Vedere la bandiera dell’Argentina alzarsi sul pennone e garrire al vento la riempiva di orgoglio. Del resto, pensava, era proprio quello il suo posto; così bella, bianca e azzurra, doveva per forza salire in alto e confondersi con nuvole e cielo.
Poi cominciavano le lezioni, con i maestri più qualificati. Vanto dell’istituto era quello di voler impartire ai propri studenti una educazione completa, che comprendeva la musica e l’attività fisica: equitazione per i maschi e ginnastica artistica per le femmine.
Aveva così imparato a suonare il violino ma soprattutto aveva educato l’orecchio a sentire la musica: quella eterna, scolpita nei secoli dal genio ineguagliato dei grandi compositori, e l’altra.
L’altra l’andava a sentire nelle cantinas di casa sua, alla Boca, dove si suonava e si ballava il tango.
Del tango la Boca è uno dei luoghi mitici.
Lo è perché il tango esprime la malinconia degli immigrati, la loro tristezza e le loro speranze. Canta la nostalgia e la solitudine, ma anche la lealtà e la fratellanza nelle avversità. E la Boca, quartiere di immigrati, e quindi di speranze e di solitudini, era il terreno ideale dove poteva attecchire e proliferare.
Solo lì, in quell’angiporto variopinto e inquietante, popolato di marinai e pittori, massaie e prostitute, poeti e contrabbandieri, poteva nascere e svilupparsi quella musica di rabbia e sangue.
Isabel ballava su quelle piste improvvisate. Con gli anni era arrivata a livelli che qualcuno definiva professionali, ma lei ci rideva su.
Non aveva fatto altro che affinare nel tempo la sua espressività. Il tango infatti è un ballo povero di gesti ma ricco di espressività e di carattere, perfetto per lei.
Non ci sono passi predefiniti. Mentre le altre danze si basano su una figura base da ripetere alternandola a qualche occasionale variante,il tango è del tutto privo di schemi fissi e le figure vengono continuamente assemblate, frammentate e ricombinate in una figura che non si ripete mai uguale.
In questa cornice è solo l’espressività che dà il tocco personale ad una esibizione; per questo il tango va ballato con energia e decisione, sebbene sempre con controllata morbidezza. Le spalle non devono ondeggiare e la testa deve sempre rimanere eretta in un atteggiamento austeramente superbo.
Alla fine questi movimenti nervosi e insieme felpati non sono più una danza ma cambiano pelle, si trasformano, diventano un linguaggio, diventano un pensiero. Il pensiero triste che balla.
Grazie al tango, Isabel aveva ottenuto brillanti risultati anche nella ginnastica artistica.
Precisa sulla trave grazie al suo naturale equilibrio, senza sbavature al volteggio e alle parallele asimmetriche, diventava strabiliante al corpo libero dove poteva finalmente dare libero sfogo a quella musica che sentiva suonare dentro di sé.
Alla fine la sua gara non era un semplice esercizio di ginnastica ma uno struggente ed elaborato arazzo di passi danzanti nel quale il tango trovava la sua consacrazione.
Isabel interpretava i suoi passaggi e ciò colpiva tutte le giurie che la gratificavano invariabilmente di un dieci pieno.
Erano l’espressività ed il carattere che aveva imparato con il tango, l’alterigia della sua testa perennemente eretta e la morbidezza felpata dei suoi movimenti a distinguerla dalle altre ginnaste e dalla freddezza meccanica dei loro gesti.
Le altre saltavano, ruotavano, si muovevano; lei parlava, raccontava, comunicava. Era una storia quella che Isabel rappresentava sul tappeto, una storia sempre diversa ma ugualmente oscura, enigmatica e misteriosa, che evocava, come il tango di cui erano intrisi i suoi movimenti, la velatura azzurra della nebbia, il riflesso di un lampione nella pioggia,lo sguardo di una donna alla finestra, uno stiletto nascosto nella mano.
Giunta in Italia questa chiave originale di interpretare la ginnastica all’inizio sorprese e disorientò. Ci volle del tempo perché venisse capita e apprezzata.
Fu un giornalista del “Messaggero”, meravigliato da quella stupefacente contaminazione di tango e ginnastica che inventò l’epigrafe delle sue esibizioni iniziando così il suo articolo: “Isabel Capuano, il pensiero triste che volteggia”. E mai per Isabel articolo fu più vero; lei era piena di pensieri tristi.
Il ricordo dell’Argentina lontana era insopportabile, faceva troppo male.
Isabel l’aveva dovuta lasciare all’improvviso, da un giorno all’altro, perché Domenico Capuano aveva sbagliato tutte le sue previsioni.
Aveva creduto che nessuno sarebbe venuto a disturbare la sua quiete di lucertola ed invece un giorno qualcuno arrivò. Aveva pensato alla saggezza dei vecchi di San Gregorio Matese – male non fare paura non avere – ed anche loro lo avevano tradito;non aveva mai fatto del male a nessuno eppure quella volta di paura ne ebbe così tanta che di più un uomo non avrebbe retto.
Domenico Capuano era convinto di potersene stare abbarbicato al muro ma quando arriva un terremoto, e la dittatura era un terremoto, le scosse arrivano dappertutto e fanno crepe profonde, anche sul muro di casa.
Insomma accadde questo.
Domenico Capuano come al solito aveva chiuso la sua verduleria attorno alle 19.30. Era un giorno di luglio, un giorno che avrebbe ricordato per l’eternità.
Aveva fatto ritorno a piedi alla sua abitazione, una villetta a due piani, colorata di giallo e di blu in omaggio al quartiere che l’aveva accolto quando era ancora Cristoforo Colombo.
Non aveva l’abitudine di passare dalla porta, passava dall’apertura che dal garage saliva direttamente in casa.
Domenico Capuano era un uomo mite e portato al buon umore; l’incasso poi era stato particolarmente ricco quel giorno e i dollari arrotolati dentro il borsello lo rendevano particolarmente euforico.
Quello che avrebbe mutato repentinamente il suo umore, e il destino stesso della sua vita, lo aspettava alla fine della scala, al buio.
Domenico Capuano dal garage salì in casa, accese la luce e si diresse verso la camera da letto per sistemare i soldi in cassaforte.
Fu in quel momento che sentì una bocca metallica appoggiarsi dietro l’orecchio e una voce senza emozione scandire:
“No te muovas Don Mimmo. Quedate tranquillo y no te paserànada”.
Erano in due, alti e squadrati, giubbotti di pelle nera e passamontagna in testa.
Lo fecero distendere bocconi sul pavimento, gli girarono le braccia dietro la schiena e ai polsi gli strinsero un paio di manette, manette della Polizia.
“La cajafuerte Don Mimmo. Adonde esta”
Razziarono quanto c’era da razziare: denaro, gioielli, perfino l’impianto stereofonico e il televisore. Caricarono tutto sul pick up, quello che lui usava ogni mattina per andare ai mercati generali per comprare la sua frutta. Prima di andarsene gli strinsero la bocca e gli occhi con il nastro da pacchi, sostituirono alle loro manette un legaccio di corda e aprirono tutti i rubinetti di casa così da coprire qualsiasi invocazione di aiuto.
Presero tutto ma gli lasciarono la vita, il che, dati i presupposti, non era affatto scontato.
Una vita mutilata, una vita fatta a pezzi ma pur sempre vita. Si poteva ricominciare, si poteva tentare di rimetterli insieme, ma non più a Buenos Aires.
Erano stati i poliziotti. Le manette erano state la loro firma. Probabilmente quelli del quartiere, magari proprio quelli che passavano ogni giorno da lui per fare la spesa al termine del servizio. Lo conoscevano troppo bene, nome, indirizzo, abitudini, sapevano tutto di lui, di Don Mimmo, el tano.
Erano i cani da guardia della dittatura, erano i privilegiati, erano gli animali più uguali degli altri. Guadagnavano poco, volevano altri soldi, e allora si servivano da soli.
E così in un attimo avevano spezzato il sogno di Domenico Capuano. L’eden del Nuovo Mondo si era trasformato in un inferno.
Quanto tempo gli sarebbe occorso per dimenticare il freddo di quella canna piantata sulla nuca?
La verduleria di Don Mimmo non riaprì mai più.
Pochi giorni, necessari per sistemare le cose e salutare gli amici più cari, poi la famiglia Capuano si imbarcò sull’aereo per fare ritorno in Italia, destinazione Roma. L’avventura di Cristoforo Colombo era terminata.
Di tornare a San Gregorio Matese non se ne parlava nemmeno.
Dieci anni lontano l’avevano reso un uomo diverso, non avrebbe più accettato quella vita e comunque ritornare, per qualcuno poteva anche significare ammettere un fallimento e soddisfazione Domenico Capuano non voleva darne.
Avrebbe ricominciato tutto da Roma. Non gli mancavano soldi ed energia.
Isabel si integrò in fretta e bene. Conosceva perfettamente l’italiano per averlo sempre parlato in casa e comunque c’era la sua musica interiore. Lei intuiva le cose al volo e si accordava al ritmo dell’ambiente.
La sua carriera nella ginnastica ebbe una inaspettata propulsione. Dopo l’articolo del Messaggero di Isabel Capuano si iniziò a parlare in termini entusiastici. La nazionale era alle porte e tutti al Circolo Flaminio, dove si allenava tutti i giorni, le pronosticavano una brillante carriera internazionale.
Ma quelle gratificazioni e la bellezza della città non bastavano a rendere più lieve la sofferenza che le provocava la nostalgia dell’Argentina.
Se fosse stato per lei avrebbe barattato il Colosseo, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi per un churros.
Certo, anche a Roma il gelato era buono, i gusti cremosi e spumeggianti erano attraenti dietro la vetrina dei bar ma lei non sentiva quell’odore di fragola che si sprigionava nell’aria quando il gelataio di Calle Martin Fierro apriva il coperchio metallico del suo trabiccolo a pedali.
Si era anche adattata a mangiare la pasta, tagliatelle paglia e fieno, che delizia, ma l’asado della domenica ed il sapore di quella carne beh, quella ce l’aveva ancora in gola.
Rimaneva la bandiera, e quella almeno non l’aveva persa. Bastava alzare lo sguardo; nuvole e cielo, il bianco e l’azzurro, l’accompagnavano ovunque.
Giaceva nel profondo del suo essere, così nascosta che nessuno tranne lei poteva immaginarne l’esistenza, una domanda senza risposta.
Parlava italiano, i suoi genitori erano italiani, la sua nascita a Buenos Aires poteva considerarsi un mero accidente casuale ma allora perché si sentiva così profondamente e intimamente argentina?
Era una domanda che non osava porre ai suoi genitori, lei stessa ne era spaventata.
Il perché era chiaro:più si avvicinava all’Argentina più si allontanava dai suoi genitori.
La cartella clinica di sua madre, dopo tanti anni, aveva dato a Isabel tutte le risposte che cercava.
La storia mi fu chiara quando Maria Capuano mi portò in studio la perizia conclusiva del dottor Monaco.
“E Isabel- chiesi- come sta?”
“Sta bene. È partita con la nazionale per un raduno a Gaeta”
Ebbi in quel momento la certezza che stava mentendo. L’ultima volta Isabel era troppo sconvolta perché nel suo futuro immediato potesse ancora trovare spazio la routine della ginnastica.
Lessi la perizia conclusiva di Monaco e i documenti allegati, compresa la cartella clinica. Notai la discrepanza. Nella cartella clinica veniva riportato l’intervento di laparatomia del settantasei ma la perizia di Monaco non ne faceva cenno. Evidentemente la signora aveva omesso di riferire a Monaco ciò che invece aveva riferito al Sant’Anna poco dopo l’infortunio.
Da ciò si intuiva che di questo intervento la signora non parlava volentieri, che questo intervento era opportuno lasciarlo lì, sepolto per sempre nel passato. Solo l’operazione al ginocchio, quindi la necessità di fornire una anamnesi completa, le aveva imposto di riportarlo per un attimo alla luce, convinta peraltro che sarebbe immediatamente ripiombato nel buio di qualche ammuffito archivio del Sant’Anna.
Dopo l’intervento tutto era tornato come prima. Maria Capuano non aveva avuto più alcun bisogno di confessare a Monaco il suo inconfessabile segreto.
E così sulla sua relazione venivano riportate le solite generiche informazioni; luogo e data di nascita residenza professione, nome e data di nascita dei figli.
Data di nascita dei figli. Era qui il detonatore, qui l’innesco della bomba.
Perché Isabel era nata il 18 luglio 1978.
Ma come avrebbe potuto partorire una figlia nel 1978 una donna che nel 1976 aveva subito una laparatomia? Un intervento di laparatomia preclude per sempre la possibilità di generare.
Da qui una sola possibile sconvolgente conclusione: lei non poteva essere sua figlia, Isabel non era la figlia di Maria e Domenico Capuano.
Per questo motivo Isabel era sconvolta il giorno in cui mi consegnò la cartella clinica della madre. L’aveva letta anche lei e lo scoppio l’aveva colta in piena faccia.
Ma di questa storia mi sfuggiva ancora qualcosa. L’anello mancante lo ritrovai per caso un giorno, leggendo un giorno “La Repubblica”. In una delle pagine interne un articolo titolava in grassetto:” Garage Olimpo. Trovato il torturatore di Buenos Aires”.
Lessi che Garage Olimpo era la caserma segreta nel cuore di Buenos Aires utilizzata dai militari per torturare i dissidenti del regime.
Bastava una voce, una delazione, una parola sbagliata detta al mercato, all’università o nella redazione di un giornale perché le squadre della morte entrassero in azione nel cuore della notte per strappare via dalla sua casa e dai suoi affetti un innocente e portarlo lì dentro, nel Garage Olimpo.
La fortuna assisteva i pochi disgraziati che riuscivano ad uscirne indenni. Ma per quasi tutti non c’era speranza. Narcotizzati venivano caricati su un aereo dell’aviazione militare e da lassù, da tremila metri di altezza, venivano fatti precipitare nell’oceano. In Argentina sparirono così oltre trentamila persone tra il 1976 e il 1983.
Lessi che non c’era distinzione di sesso: uomini e donne ricevevano lo stesso trattamento.Veniva concesso ancora qualche mese di vita solo alle donne gravide, ma non era pietà la loro, la condanna a morte era solo sospesa; sarebbe stata eseguita a parto avvenuto. E non tutte avevano la fortuna di salvare la propria creatura. Solo se fosse giunta qualche richiesta speciale il neonato, separato dalla madre, avrebbe avuto salva la vita.
E le richieste speciali potevano provenire solo dalle alte autorità militari.
Era stato il generale Montero, il tronfio pennuto carico di patacche, a fare la richiesta speciale per conto dei coniugi Capuano. A muoverlo era stata sua moglie, Dona Gladis, che, memore delle conversazioni pomeridiane, tra una succhiata e l’altra di mate con la cannuccia d’oro, aveva voluto fare un regalo alla nuova amica Maria, sostituendosi al Padreterno e assecondando i suoi frustrati desideri di maternità.
I coniugi Capuano così avevano potuto inscenare il finto parto nella clinica privata san Firminio. Con la madre vera condannata a morte e la madre finta nella stanza accanto ad attendere il frutto di un amore che non era il suo.
Ecco la storia di Isabel, figlia di una desaparecida.
Al mosaico manca ancora un pezzo, l’ultimo.
Circa un anno dopo mi giunse in studio una cartolina. Era una veduta notturna di Buenos Aires. Dietro la cartolina solo tre parole, e nessuna firma: “La vida continua”.
Ne fui felice. L’esplosione non l’aveva uccisa.