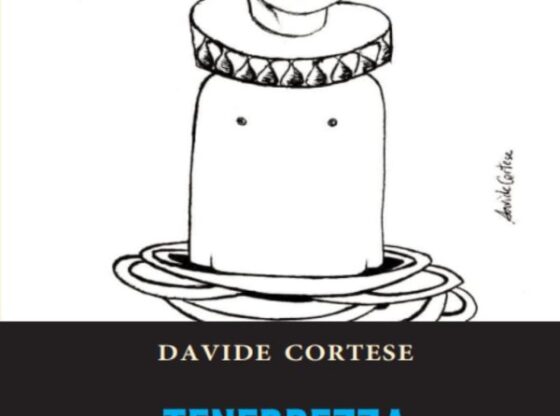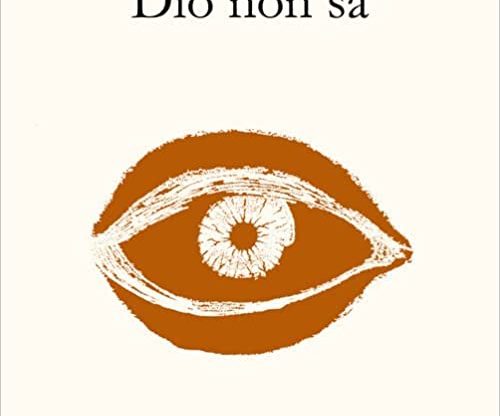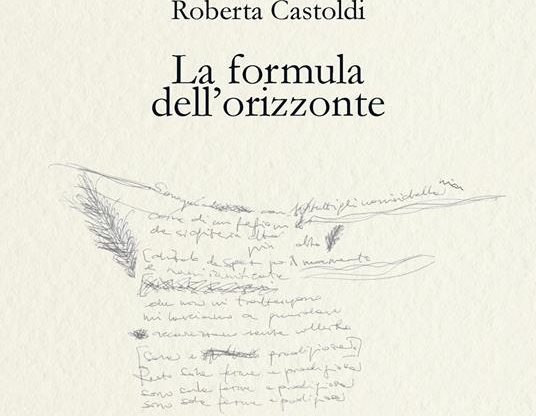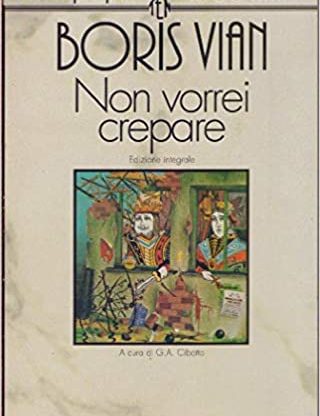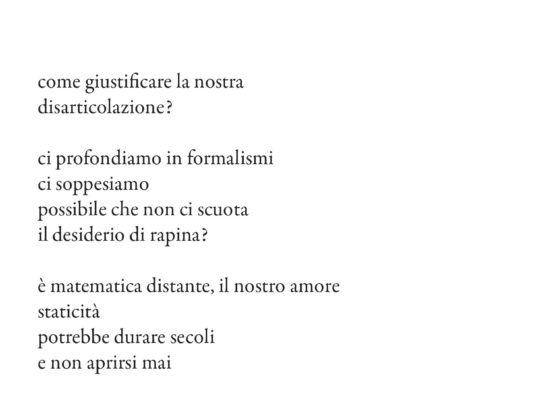La poesia come ritrovamento
Di Emanuele Martinuzzi
Approcciarsi a parlare del linguaggio è sempre in qualche modo entrare in un labirinto di specchi, in cui i riflessi si confondono con lo stesso soggetto conoscente che tenta di carpire i rimandi di quegli oggetti plastici
o intangibili della sua conoscenza, chiamati parole. Non è mai possibile rimanere estranei all’oggetto o alla materia conosciuta, questo in generale, e nel caso specifico del linguaggio sarebbe ancor più paradossale. In
primo luogo perché l’oggetto della conoscenza linguistica è conosciuto e sviscerato proprio attraverso i mezzi stessi da lui posti in essere. Le parole che compongono il linguaggio sono gli stessi strumenti attraverso i quali
si descrive ed eventualmente chiarifica il linguaggio stesso, la sua natura come le sue regole o articolazioni. In secondo luogo perché il soggetto conoscente che si avvicina al linguaggio vi si approssima grazie proprio al fatto di essere dotato di linguaggio, quindi in un certo senso la conoscenza del linguaggio per un essere dotato di parola è una via imprescindibile della sua conoscenza personale o comunque del mondo di cui è abitatore. Si potrebbe addirittura provocatoriamente dedurre che la possibilità del conoscere è un estrinsecarsi delle stesse potenzialità del linguaggio, prima che delle facoltà del soggetto conoscente. La conoscenza sembra essere proprio un espandersi e articolarsi del linguaggio stesso. Detto questo non si può certo negare il peso specifico della presenza di un essere conoscente all’interno di quella fitta trama di segni e significati che vengono vivificati dalla sua presenza, che da inerti codici che si incastrano e generano l’un
l’altro vengono caricati di un pathos esistenziale connaturato a quell’essere dotato di parola chiamato uomo. Dunque, i suoni della voce sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell’anima, e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce. Allo stesso modo poi che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi; tuttavia, suoni e lettere risultano segni, anzitutto, delle affezioni dell’anima, che sono le medesime per tutti e costituiscono le immagini di oggetti, già identici per tutti. […]. D’altro canto, come nell’anima talvolta sussiste una nozione, che prescinde dal vero o dal falso, e talvolta invece sussiste qualcosa, cui spetta
necessariamente o di essere vero o di essere falso, così avviene pure per quanto si trova nel suono della voce. In effetti, il falso ed il vero consistono nella congiunzione e nella separazione.[1]
Se si volesse dare corpo e prospettiva a questo pathos e puntualizzare questa specificità dell’uomo di essere fatto ad immagine e somiglianza dello stesso linguaggio che ne costruisce la persona come il mondo esterno, si dovrebbe prendere in considerazione una visione più ampia e trasversale del linguaggio. In questo senso l’essere umano andrebbe più essenzialmente inteso come quell’essere attraversato dai molteplici linguaggi, un crocevia di parole dalle infinite sfaccettature, una marea di segni nell’indefinito variare delle forme come dei contenuti. A questo punto le delimitazioni linguistiche delle lettere e delle sillabe appaiono in tutta la loro vaghezza e indeterminazione nel decifrare univocamente l’essere umano rispetto all’essere del linguaggio. E allo stesso modo appare in tutta la sua incompletezza il considerare l’essere del linguaggio e delle sue parole
come il solo essere rispetto alla multiformità dei linguaggi esistenti, che non adoperano solo suoni o sillabe ma vivono nella tensione del significare attraverso svariati segni e imponderabili vie.
Ci appariranno ridicoli, a mio parere, o Ermogene, gli oggetti, una volta che ci siano ben chiari per averli imitati con le lettere e con le sillabe. Tuttavia è necessario. E non abbiamo nulla di meglio a cui riportarci circa la verità dei primi nomi, a meno che, come fanno i tragici quando non hanno modo di risolvere qualche difficoltà, fanno ricorso alle macchine sollevando in alto
degli dèi, non voglia anche tu che ci sottraiamo allo stesso modo, dicendo che i primi nomi li hanno posti gli dèi immortali e per questo vanno bene. E potrà essere per noi questo il miglior consiglio? Oppure quest’altro: che noi li abbiamo accolti da alcuni barbari, e i barbari sono più antichi? O perché, data la loro antichità, è impossibile sottoporli al vaglio, come anche i
nomi forestieri? E tutti questi sarebbero espedienti, anche molto acuti, per chi non vuole dare conto dei primi nomi se sono stati posti correttamente. E sì che chi non conosce la correttezza dei primi nomi è impossibile che conosca quella degli ultimi che necessariamente vengono resi
chiari da quelli di cui nessuno sa nulla.[2]
Adesso considerare in tutta la sua complessità irriducibile questo magma cangiante, compenetrante e compenetrato dai segni nei significati, dai significanti nei segni e così via, senza una sintesi schematica che possa darne ragione e senso in maniera assoluta e definitiva, ci apre alla vertigine delle possibilità radicali. Ci si sente smarriti e trasportati da una corrente silenziosa e mostruosa insieme, traghettati dall’essere segno al sembrare significato, dal rapportarci ad un mondo e vederlo sfumare in miriadi altri. Il soggetto conoscente che trovava nel linguaggio delle parole la sua ancora di salvezza e il suo strumento privilegiato di conoscenza deve adesso vestire i panni del naufrago, così attanagliato dalla tempesta da non riuscire più a descriversi diversamente rispetto alla maestosità del mare. Il mare dei linguaggi abbraccia il naufrago e la sua sete di un approdo nel senso con tanta intimità e violenza da non lasciare altra via d’uscita che perdersi.
L’uomo ricco di astuzie raccontami, o Musa, che a lungo
errò dopo ch’ebbe distrutto la rocca sacra di Troia;
di molti uomini le città vide e conobbe la mente,
molti dolori patì in cuore sul mare,
lottando per la sua vita e pel ritorno dei suoi.
Ma non li salvò, benché tanto volesse,
per loro propria follìa si perdettero, pazzi!,
che mangiarono i bovi del Sole Iperione,
e il Sole distrusse il giorno del loro ritorno [3]
La sapienza immemore del mito giunge ancora una volta a delucidare la razionalità moderna e le sue questioni ipotetiche, votate al limbo dell’impossibilità. Ulisse, l’eroe acheo narrato da Omero nell’Odissea,
incarna l’essere disperso nei linguaggi verbali e non verbali, nella molteplicità dei sensi, una volta distrutta la rocca sacra del linguaggio, relazionato dai nomi con le cose, nella infinità dei mondi denotativi, una volta frammentata la conoscenza del tutto e l’uso ontologico del linguaggio nei vari specialismi epistemologici. L’Odissea di questo navigatore attraverso i mari, le terre, i vari popoli, le creature dell’immaginifico o del
reale, non è altro che l’epopea metaforica del naufrago del linguaggio e della realtà ad esso corrispondente, in balia della frammentazione che appare come libertà interpretativa, in preda alle forze del gesto rispetto
all’intermediazione del segno o della cultura.
Ma che cos’è la lingua? Per noi, essa non si confonde con linguaggio; essa non ne è che una determinata parte, quantunque, è vero, essenziale. Essa è al tempo stesso un prodotto sociale della facoltà del linguaggio ed un insieme di convenzioni necessarie, adottate dal corpo sociale per consentire l’esercizio di questa facoltà negli individui. Preso nella sua totalità, il linguaggio è multiforme ed eteroclito; a cavallo di parecchi campi, nello stesso tempo fisico, fisiologico, psichico, esso appartiene anche al dominio individuale e al dominio sociale; non si lascia classificare in alcuna categoria di fatti umani, poiché non si sa come enucleare la sua unità.[4]
Durante le sue peregrinazioni Ulisse apparentemente incontra tutta una serie di personaggi umani e mitologici, popolazioni primitive e mostruose presenze, che in realtà non sono altro che le metamorfosi possibili del suo stesso linguaggio, le trasfigurazioni e il travisamento di ciò che non pensava il suo comunicare potesse impersonare o attirare nella sua orbita di senso. I Lotofagi, i Ciclopi, Circe, le Sirene, Nausica e tutti gli altri momenti che scandiscono il suo viaggio all’interno della sua stessa multiformità rappresentano ognuno un modo distinto e incomunicabile con gli altri di poter essere del linguaggio. Ogni metamorfosi un segno, ogni approdo un contenuto, ogni gesto eroico un mondo. Il linguaggio può essere un fiore di Loto, capace di far dimenticare le sue origini, cristallizzato in una forma che si reputa come originaria e priva di etimologia e storia, quando invece i suoi trascorsi reconditi sono narcotizzati da ciò che appare nel presente.
Destarsi ad una visione che riacquisti prospettiva e narrazione può essere l’impeto che reimmette la dimenticanza sulla nave del divenire, di ciò che muta e non potrebbe non essere il risultato transitorio di una mutazione. O anche può comparire un linguaggio Ciclopico, schiavo del pragmatismo, unidirezionale cecità data da una visione monoculare, che riduce alla barbara materia o a un naturalismo infantile o a un realismo irreale ogni astrazione possibile. La rarefazione del linguaggio invece può farsi nessuno, sottile presenza, al di là di ciò che si reputa essere fisico. Il linguaggio può essere una perla che si dona ai porci, non più capaci di ascoltarne le intime possibilità dialettiche perché in preda magari agli incantesimi circensi
dell’intrattenimento fine a sé stesso. Può essere un canto, umano e animalesco, perciò inascoltabile, attraente e profondo come una pulsione di morte, una tensione verso la decadenza o gli abissi del dicibile. Non meno una litania di candori, un’infanzia idealizzata, una forma elementare che si mostra come la purezza del dire, una meta che abbraccia con le bianche braccia del sogno. Queste e altre personificazioni del linguaggio non ne esauriscono le infinite potenzialità. Tuttavia queste infinite specializzazioni allontanano, come in un viaggio metamorfico, il linguaggio dalla sua stessa essenza. L’essere del linguaggio si perde e si dimentica nella trama senza fine delle sue alterazioni e strutturazioni. I mondi e gli universi di denotazione si moltiplicano e con essi il nulla. Il fine del linguaggio non può che risultare strumentale o accidentale rispetto all’arbitrario mondo da denotare di volta in volta. Più i mondi si frammentano e più scompare il ricordo unitario di esso.
Se un valore che ha valore v’è, dev’esser fuori d’ogni avvenire ed essere-così. Infatti ogni avvenire ed essere-così è accidentale. Ciò che li rende non accidentali non può essere nel mondo, ché altrimenti sarebbe, a sua volta, accidentale. Dev’essere fuori dal mondo.[5]
Al di là dei mondi denotativi e dei molteplici linguaggi cosa sta se non la Poesia. Questo sembrerebbe un inciso contraddittorio rispetto a quanto scritto finora o un salto Pindarico inatteso nel procedere della riflessione. Più logicamente si dovrebbe sottintendere la Poesia come uno dei tanti linguaggi espressivi, un linguaggio prettamente letterario per esattezza, con i suoi codici, le sue forme e le sue potenzialità di senso. Il poetare perché dovrebbe differire dagli altri linguaggi specialistici, che hanno più o meno la tendenza a circoscrivere un proprio mondo di segni e oggetti, anche concettuali, rimanendo di conseguenza nei margini di un particolarismo espressivo, che non si confonde né muta a contatto con gli altri linguaggi, né li sovrasta da una posizione eminente e totalizzante. Tuttavia si può provare a considerare la Poesia e di conseguenza il linguaggio da un’altra prospettiva, inattuale quanto neonata. Omero e la sua Poesia incarnano le origini della poiesis. Omero, questa figura ad un tempo singolare e collettiva, cieca e omnicomprensiva, mitologica e reale, scritta e orale, è il custode di quel fenomeno misterioso che precede il poetare. Nella grecità la Poesia non ha semplicemente rappresentato uno dei tanti linguaggi, ma la fonte primigenia e creativa di una conoscenza che da canto, corale e aurale, è diventata scritto, immaginifico e reale, una propensione interiore che da mito poetico si è strutturata in Logos filosofico. La Poesia in questo senso non è posta in essere dal linguaggio, ma essa stessa a porre il linguaggio in essere. La Poesia abita i linguaggi, ma la sua essenza non ne è incarnata
compiutamente da nessuno. La Poesia non sta nelle parole, né nei colori, né in altro tipo di supporto che la scrive o rappresenta. La scintilla creativa che sta segretamente in ogni linguaggio ci palesa quel nulla che tutto possiede chiamato Poesia. Ulisse si nomina nessuno, come la Poesia, nella caverna, fatta di ombre che fagocitano sé stesse e ogni luce, per sfuggire alle limitate visioni dei Polifemi linguistici, che cercano di ingabbiare nel finito o nel decidibile ciò che non lo è.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Li miei compagni fec’ io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.[6]
E paradossalmente non c’è altro folle volo per Ulisse, preso come paradigma di un essere intimamente intriso di poeticità, che quello di ritrovarsi all’origine, non più disperso nei mutevoli linguaggi e nelle loro illusioni di
esistenza. Follemente non si può superare le colonne d’Ercole del conoscibile, perché questo volo della conoscenza vive nell’illusione di far propria la diversità, di conquistare una nuova parte di ciò che non si
possiede, piuttosto che di creare nel solo modo possibile, ossia facendo liberamente scaturire da quella fonte che già ha in sé il tutto. La Poesia non può essere che il ritrovamento di un’identità perduta dopo le metamorfosi, un volo verso l’impossibile del dimenticato, la follia di ritrovarsi straniero nella propria casa, il candore di chiamare sempre con nuovi nomi la stessa persona amata. Non c’è altro poetare per un viaggiatore che ritornare rinnovato alla terra natia per vederla con gli occhi di quando era fanciullo, che approdare nel porto da cui era salpato con l’emozione di chi non ha mai visto il mare. Poesia è il primo nome pronunciato dal silenzio che da realtà alle cose. Poesia è il Nulla di mura e ombre parlate, costruite dal vento.
Poesia è Itaca.
1 Aristotele, De interpretatione
2 Platone, Cratilo
3 Omero, Odissea
4 Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica generale
5 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
6 Dante Alighieri, Inferno