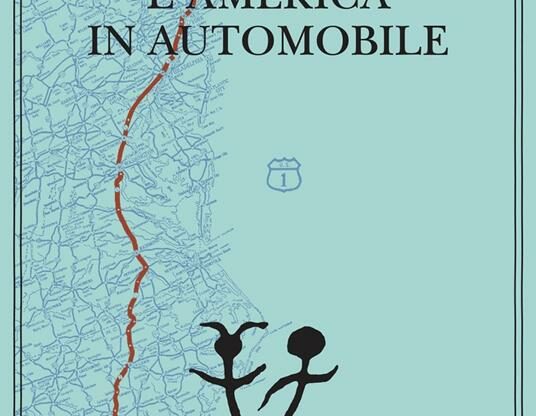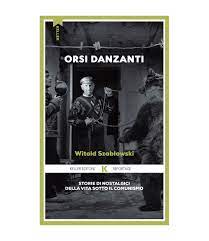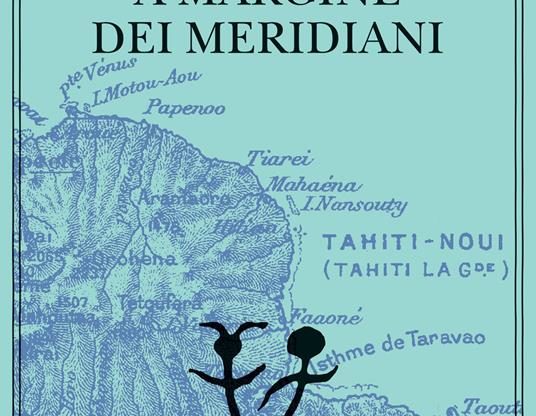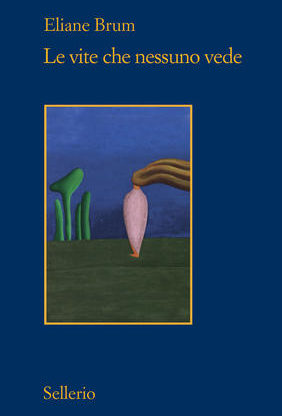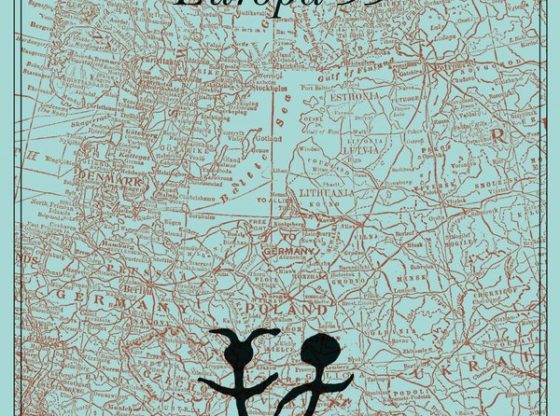19-24 agosto (Praga, con gita a Dresda del 22 agosto)
Di Marcello Caprarella
“…Im alten Hause; vor mir frei
seh ich ganz Prag in weiter Runde…
Mir ist, daß in dem alten Hause
jetzt eine Stimme “Amen” spricht…”
R. M. Rilke, “Im alten Hause”, da: Larenoffer
L’aereo per Praga del 19 agosto era alle 16, per cui avevo la mattinata a disposizione e conveniva uscire per non intralciare mia moglie nella preparazione dei bagagli. Alle sette ero già in strada. Due silenzi sovrapposti mentre andavo in palestra attraversando il parco del Canal: quello dell’ora e quello del mese, nella città vuota. In mezzo, un sole che mi pare sempre eterno, di una lunga estate bambina. Prima di partire, ho ricevuto una comunicazione dagli organizzatori di un premio letterario. Chiedevano la mia autorizzazione per pubblicare a fine mese un estratto di questo diario sul quotidiano La Nazione. Hanno scelto la pagina in cui parlo del Gitano del Sotoverde che di notte va a rubare la frutta nei capannoni. È una pagina nella quale fantastico di potermi unire alla sua banda e di poter visitare un puticlub della statale per festeggiare un colpo riuscito. Ho dato il mio placet per la pubblicazione, ma c’è qualcosa che stride. Ho come l’impressione che gli organizzatori del Premio stiano facendo di tutto per far deragliare questo diario, rendendolo “simpatico” e svuotandolo sia della sua carica eversiva sia di quella intimistica, che pure possiede. A me sta benissimo che si diffonda il contenuto che loro propongono. Mi sta benissimo che abbiano intitolato Sotoverde questo diario, e non Confessioni di un italiano all’estero, che era il titolo scelto da me sin dall’inizio e che mi sembra perfettamente calzante anche dopo la scelta a posteriori da parte degli organizzatori di mettere il tema dell’emigrazione al centro dell’edizione del Premio di quest’anno. Mi sta tutto benissimo. Solo non vorrei che, per colpa della campionatura del testo proposta, mi si prendesse per un alcolizzato, potenziale ladro e puttaniere, ma mi rassegno anche a questo. Vedo, però, che dagli estratti scelti degli altri finalisti emergono sempre pruriti sociali, terzomondisti, antifascisti, socialisti, postcoloniali, comunisti, massonici e artistici. Di sicuro, più in linea con il tema e il geist del Premio. Ciò che intendo dire è che ho come la sensazione di essere o di essere stato mandato fuori traccia, anche se sono anch’io -unico tra i finalisti- un emigrante e parlo, con un punto di vista non in linea con quello corrente, delle nuove emigrazioni. Vedo le vite “contro” degli altri finalisti (ex partigiani, ex tossici finiti a spacciare eroina in India, ex stalinisti di Paese Sera, ex deputati del PCI) e mi assale il dubbio dell’inadeguatezza “politica” della mia vita e della mia memoria, che può solo sbandierare la tragedia di una felice e “reazionaria” normalità.
Mi lascio alle spalle tutti questi tarli, e partiamo. Chi viaggia sa quanto sia diventato difficile e scomodo volare, a causa delle misure di sicurezza. Pur potendo stampare le carte d’imbarco a casa, con conseguente risparmio di tempo e di code, si è tornati a vent’anni fa, quando ti consigliavano di presentarti in aeroporto almeno due ore prima della partenza. I controlli dei bagagli e le vere e proprie perquisizioni sono estenuanti, anche perché si parte da una presunzione di colpevolezza. Tu sei un terrorista e porti bombe, armi e liquidi pericolosi a bordo, a meno che tu non riesca a dimostrare il contrario. Siamo felicemente atterrati a Praga in serata. In taxi, mia moglie non ha detto neanche una parola, tanto arcigno, ostico e taciturno era il tassista, che a me sembrava Anton Panenka, quello del rigore liftato e centrale che scavalcò Sepp Maier nella finale degli Europei di calcio del ’76, giocata e vinta dalla Cecoslovacchia contro la Germania.

Nei giorni trascorsi a Praga ho visto moltissimi uomini con i baffoni biondi brizzolati, sulla sessantina inoltrata e che somigliavano a Panenka. Si vede che Panenka ha avuto un impatto enorme su tutta una generazione. È l’unica nota di allegria –forzata da una mia suggestione- che ho ritrovato nella fisionomia delle persone di Praga, la cui tristezza, quantomeno apparente, è la costante nel tempo. Per tutto il resto, la città è profondamente cambiata dalle mie visite precedenti. Soprattutto dalla prima, che avvenne nell’agosto del 1990. Era appena crollato il muro di Berlino. Arrivammo a Praga in treno, da Vienna. Eravamo un gruppo di ragazzi di Foggia. C’era anche R. In stazione ci rivolgemmo all’Ufficio del Turismo per trovare un albergo, e ci diedero l’indirizzo di un domicilio privato. Ricordo che iniziammo a camminare per trovare un posto dove mangiare un boccone. Non c’era niente. Finimmo in una specie di mensa popolare, con piatti coperti dalle mosche e gente in tuta da meccanico che faceva la coda per ritirare una brodaglia che costava pochi centesimi, in silenzio. L’appartamento sul quale ci dirottarono era di un tassista che abitava sullo stesso pianerottolo, in un altro appartamento uguale, moquettato. I tassisti, gente coi peli sullo stomaco, sono stati i veri pionieri del capitalismo neoliberale nell’est Europa. Il nostro padrone di casa si chiamava Piotr ed era terrorizzato dai furti degli zingari. Abitava in un quartiere orrendo, Vlkova, a Praga 3. Ce ne erano moltissimi, di zingari e di furti, da quelle parti e, in qualche modo, fummo anche noi vittime di questa circostanza. Giravamo con enormi pacchi di soldi in tasca. Oltre al cambio ufficiale delle corone, che ti obbligavano a fare o che facemmo per paura di chissà quali possibili multe e seccature, Piotr e i camerieri di un albergo ci cambiarono in nero tre o quattrocento dollari a testa, in una città in cui non si poteva comprare nulla, tranne delle ottime pizze rustiche in piazza Venceslao. E la birra, che costava l’equivalente di cinquanta lire italiane di allora a boccale. La sera andavamo al Mosca, che era il ristorante frequentato dai diplomatici, dalle spie e dai quadri del partito comunista o di ciò che ne era rimasto e che si contendeva il potere con le nuove élites. Pasteggiavamo a spumante georgiano, lasciavamo mance principescamente irrisorie. La gente del posto ci guardava male. Era come essere truppe di occupazione o nababbi su Plutone. Riuscimmo a rimorchiare solo delle tedesche dell’est, in una taverna popolare, offrendogli da bere a dismisura. Le portammo in casa, nell’appartamento di Piotr. Sul più bello, Piotr fece irruzione. La cazziata fu tremenda. Gridava qualcosa come “Polizia” e “arresto”. Le ragazze, terrorizzate, fecero fagotto, e noi andammo a dormire preoccupati e col cazzo in tiro, interrogandoci sul nostro presente e futuro penale.
L’indomani Piotr si ripresentò di buon mattino e riattaccò con la storia della polizia e dell’arresto, in cecoslovacco stretto. Intuimmo la parola “zingare” e capimmo l’equivoco. Spiegammo a Piotr che le ragazze erano tedesche, non zingare. Piotr si limito a dire, in italiano, queste testuali parole, che ancora ricordo: “Madonna santa, scusa!” Questo è quanto mi resta di quel primo viaggio, assieme alle immagini della città, che mi parve meravigliosa e icastica come l’”amen” che le dedicò Rilke nella sua Offerta ai Lari. E lì è rimasta, vista dall’alto e dal basso, in una bellezza definitiva, tombale.
La seconda visita a Praga avvenne cinque anni fa. La città era già stata completamente stravolta dal consumismo ed era più o meno come l’ho rivista oggi. Le uniche differenze sono che nel 2011 si poteva fumare nei bar e che il Wi-Fi era meno onnipresente. Mi domando anch’io cosa ci facessi a Praga nel 2011. Fu un viaggio assurdo. Arrivai da solo, per andare a far visita a mio cugino G. L’idea ufficiale era quella di trascorrere qualche giorno di vacanza, ma il vero scopo era quello di controllare che mio cugino G. non facesse una cazzata irrimediabile. Dopo la separazione dalla moglie praghese, infatti, si era messo con una ragazza italiana, che faceva la cameriera in un albergo vicino a Malá Strana. La ragazza si chiamava C., era siciliana, analfabeta e aveva due figli. Il marito e padre dei due ragazzini -bimbo undicenne e bimba di sette anni- era di Cerignola e aveva abbandonato il tetto coniugale per mettersi con una troia moldava. Mio cugino G. si fece carico di tutta la situazione. Sia di quella legale, rivolgendosi al mio amico avvocato R. per un consiglio circa il divorzio da fare ottenere a C., sia di quella pratica, affittando un appartamento per tutta la sua nuova famigliola nella bella zona di Praga 2 e portandosi finanche C. e i bambini in Italia, al mare. C. era una brava ragazza ma, in quel periodo, mio cugino non poteva accollarsi preoccupazioni. Ne aveva già tantissime di suo. Venne a prendermi in aeroporto. Si era cotonato i capelli. Capii che qualcosa non andava. Giravamo per Praga, io e lui, con ‘sti due bambini, capricciosissimi e traumatizzati dalla situazione, attendendo che la madre uscisse dal turno delle pulizie in albergo, per poi andare a cena in posti moderni e costosi che mi facevano quasi rimpiangere la mensa popolare del ’90. La ragazza, C., parlava solo di vestiti e di progetti di trasferimento in Italia con mio cugino e prole a carico. Tutto questo a me sembrava normale e legittimo, non ci vedevo niente di strano. C. aveva sofferto, cercava sicurezza in tutti i sensi. Una incrinatura della mia fiducia in un rapporto sereno e stabile tra lei e mio cugino la ebbi solo una mattina. C. aveva la giornata libera, di riposo infrasettimanale. Lasciò i figli in casa da soli per fare un giro con me e mio cugino. Mio cugino chiese perché non avesse portato anche i bambini, e lei bofonchiò che non voleva rotture di scatole nel suo giro. Mio cugino, già tragicamente calato in un ruolo paterno che gli stava bene come i capelli cotonati, ci rimase male. Per giro C. intendeva razzie nei negozi di abbigliamento. A un certo punto esclamò, al mio indirizzo: “a tuo cugggino ci devo cambiare il look!”, ma detto con il tono di una che grida “A tuo cugino ci devo spaccare la faccia”. Guardai mio cugino e i suoi capelli. Ci scambiammo un cenno di intesa ed ebbi la certezza che anche lui aveva capito che era una storia senza senso, senza futuro.
Questa lunga digressione della memoria è la stessa che ho seguito in taxi la sera del 19, quella del nostro arrivo, dato il silenzio del tassista e la lontananza dell’aeroporto dal nostro albergo, il Don Giovanni, che si trova a quattro fermate di metropolitana dal centro della città. Appena scesi dal taxi, siamo saliti in camera per cambiarci e andare a cena con mio cugino e la sua amica D., che ci attendevano nella hall. Nel ridiscendere in ascensore, una famiglia toscana -marito, moglie e bimbo sugli otto anni- ci ha sentito parlare in italiano. “Anche voi con il gruppo della Reno de Medici? mi ha fatto lui, il papà, cordialissimo. “Sì”, ho risposto spudoratamente, in modo meccanico. I miei figli sono abituati a questi miei siparietti. Ridacchiavano. Mia moglie mi ha sibilato un rimprovero in spagnolo. “Sono il Country Manager per la Spagna”, ho sorriso trionfalmente. Ho fatto anche finta di cercare il biglietto da visita. L’ascensore si è aperto. “Non resta per lo speech del Vice President e la cena?”, mi ha chiesto il mio nuovo collega, apprensivo e con un tono che lasciava trasparire mezza sorpresa e mezza delusione. “No. Il Vice Presidente mi sta sui coglioni. Lo ascolto ogni anno, almeno due volte: nel viaggio estivo di incentivazione, di persona, e per gli auguri di Natale, in videoconferenza. Vi dirà che siamo una famiglia”, mi sono giustificato. Il collega ghignava, senza sbilanciarsi. L’ho visto avviarsi mestamente verso il salone Teatro per il cenone aziendale, mentre noi andavamo a Piazza dell’Orologio, dove abbiamo passeggiato e ammirato le stradine e le torri. E poi abbiamo passeggiato sul Ponte Carlo, trasportati e travolti dall’hooliganizzazione del turismo di massa recente. Verso mezzanotte, una volta diradatosi lo sciame umano, abbiamo visitato il Molino del Diavolo e l’anfratto di calma e pastello delle piazzette, scendendo le scalinate che partono dalle rive della Moldava. Ai ragazzi è piaciuto moltissimo tutto questo. Mia moglie già conosceva la città. Ci era stata addirittura nel 1989. Le considerazioni che ha fatto, in questo ritorno, sono state simili a quelle mie: tutto è cambiato per quanto riguarda il contesto economico e politico. Nulla, per quanto riguarda lo spleen.
La mattina del 20, a colazione, ho rivisto il toscano della Reno de Medici. Mi ha abbordato lui: “Ha fatto bene a non venire. Ieri c’eravamo solo noi della centrale italiana, quelli della filiale ceca e i tedeschi. E poi aveva ragione: tutta una menata sul team spirit. Il Vice President l’è un coglione. L’ha detto pure la mi’ moglie. Ma dimmi (tu tra colleghi, che mi raggela) in Spagna c’è solo l’ufficio vendite o anche la produzione delle etichette, imballaggi ecc.? Sai, io mi occupo di marketing…”. Ne sono venuto fuori brillantemente: “Solo io. È un ufficio di rappresentanza”. Però non l’ho visto troppo convinto. Stavo per chiedergli di affiancarmi. Il mercato spagnolo offre grosse potenzialità di crescita ecc… Mi ha trascinato via mia moglie. Dovevamo andare al Castello. Quello di Kafka. Siamo una famiglia. In realtà, al Castello non ci siamo andati, il 20. Abbiamo preferito passeggiare di nuovo per il centro e rivedere di giorno le cose della sera prima, in una mattinata da flaneurs. Tutti i centri storici delle grandi città artistiche centroeuropee sono uniti da una koinè olfattiva, basata sulla frittura di salsicce e ciambelle. Il vialone praghese di piazza Venceslao non sfugge a questa caratteristica, sulla quale si innesta una globalizzazione feroce, demenziale ed esotica, come, ad esempio, quella dei negozi dei thailandesi che offrono massaggi esfolianti per i piedi, da sommergere in un acquario pieno di pesciolini che divorano la pelle morta. Per invogliare la gente a entrare, esponevano in vetrina delle signore a piedi nudi, circondati dai famelici pesciolini. Insomma, era come essere state immerse in un doppio acquario. Mia moglie, con raccapriccio, si è fermata e mi ha fatto notare che le cavie umane avevano tutte piedi sporchissimi. A me sembrava poco delicato curiosare tra le dita dei piedi altrui ed additare quelle povere mannequins pedestri. Per età, circostanza e peso ricordavano moltissimo le puttane del quartiere rosso di Amsterdam o quelle amburghesi di Sankt Pauli e della zona del porto. La fiumana dei turisti passava indifferente e ignorante davanti al monumento dedicato a Jan Palach, seminascosto da un’aiuola striminzita e sporca. Accanto a Jan Palach c’è anche la foto dell’altro martire dell’invasione sovietica, Jan Zajíc, che si bruciò vivo proprio per onorare la memoria di Palach. Ma lui, Zajic, è passato nel dimenticatoio collettivo ancora di più di Palach. Si è fermata una vecchia. Ha acceso un lumino, l’ha messo in mezzo alla foto dei due ragazzi e se ne è andata senza guardarmi, ma mi ha commosso lo stesso. In Piazza dell’Orologio erano le 12 e abbiamo atteso che iniziasse il movimento del carrillon del meccanismo. Mio cugino ci ha spiegato tutto il simbolismo della scena, nella quale solo l’artista volge le spalle alla morte. Pablo era impressionato. Italo, invece, se ne è fregato ed è corso a giocare a bucare le bolle di sapone che faceva un ragazzo punk, circondato da altri bambini. I miei pensieri riandavano a Rilke, che nei Quaderni di Malte Laurids Brigge scriveva che l’unica patria felice, senza territorio, è quella formata dai bambini. E il pensiero mi è ritornato anche la sera, quando siamo andati a cena in un bel ristorante vicino al Monastero benedettino di Břevnov, circondato da un immenso frutteto e da un parco, nel quale Italo ha giocato a calcio con altri bambini. Tutti del posto, dato che i turisti non si spingono fin laggiù. È il luogo che a mia moglie è piaciuto di più, perché le ricordava la campagna in cui ha vissuto da ragazzina. Raccoglieva le mele da terra e le mangiava. A me sono sembrate un po’ acerbe, ma ero felice di vederla felice.
La mattina del 21 agosto sono sceso, come al solito, a fare colazione da solo, mentre il resto della famiglia ancora dormiva. Ho gli stessi orari dei pensionati tedeschi, ma non lo stesso stomaco. Alle sette e un quarto, almeno, no. Si è prodotta una curiosa dissonanza melogastrica. Mentre l’orda teutonica si strafogava di uova strapazzate e salsicce, annacquate dal succedaneo di caffè che servono a litri all’Hotel Don Giovanni, un giovane suonava dal vivo il Concerto per piano num. 21 di Mozart. Si vede che l’aveva contrattato il gruppo dei pensionati tedeschi, che si ingozzavano indifferenti a tutto, come il Re Sole quando qualcuno assisteva alla sua defecazione. A me è venuto da ridere e mi sono buttato sullo yogurt e la macedonia di frutta fresca, allegro maestoso. Il resto della mattinata è trascorso a spasso. Quando uno passeggia per le vie del centro storico di Praga e si sofferma sui massacri architettonici degli ultimi settant’anni, capisce che sia il socialismo reale sia gli edificatori più recenti sono stati libertycidi. Ghetto ebraico, antica dogana, di nuovo Ponte Carlo, e poi a pranzo vicino al Molino del Diavolo. È stato l’unico passo falso di tutta la vacanza. Il locale era un biergarten. Già il fatto che fosse poco frequentato, in piena zona turistica, avrebbe dovuto preallertarci. Su suggerimento di mio cugino abbiamo ordinato, assieme alla birra, salsicce e topinky. I topinky sono fette di pane fritte sulle quali si strofina l’aglio. Mio cugino ne parlava con entusiasmo. Ce le hanno portate. Erano nere. Io credevo che il colore si dovesse al tipo di pane usato, cioè quello di segale. Invece, era per il tipo di olio nel quale le fette di pane, originariamente bianco, erano state fritte. A settembre, quando le avrò digerite, ve lo comunicherò. Mia moglie, furba, non ha toccato cibo, ma non le andava giù la strafottenza e la sciatteria del personale. La seconda, seppure ammantata di cortesia formale ed esterna, è una cosa che abbiamo notato un po’ dappertutto. Da ex Direttrice delle Risorse Umane, a mia moglie dà fastidio questa assenza di entusiasmo proattivo. Lo so, perché anche in casa me la rinfaccia. Invece, io provo comprensione per lo svaccamento professionale dei cechi, che secondo me è una conseguenza della doppia disincentivazione vissuta negli ultimi decenni, malgrado l’avvenuta apertura a Praga di una filiale della Reno dei Medici. La prima disincentivazione in ordine cronologico è stata quella della tappa comunista. In quel periodo, l’appiattimento produttivo era la norma. Senza transizione, è arrivata negli anni ’90 del Novecento la disincentivazione neoliberale, nella quale si viene sfruttati per poche centinaia di euro al mese. Secondo me, quella neoliberale è più grave della disincentivazione statolatrica comunista perché, oltre alla sodomizzazione dello sfruttamento omologato, ti viene anche chiesto di mugolare di piacere. Per tutto ciò, a me i cechi sfaticati sono simpatici. Dopo pranzo, propulsati dai topinky, siano saliti a piedi al Castello e, nel tardo pomeriggio, con la pia illusione di digerire, abbiamo anche visitato il cimitero ebraico, che era proprio di fronte al nostro albergo, per cui abbiamo potuto lasciare i ragazzi in camera. Il nostro è stato una specie di sacrilegio, dato che gli ebrei sono soliti visitare i cimiteri nei giorni dedicati al digiuno, e non ruttando topinky. Segnalo alcune stranezze. La prima è che non si paga per entrare. E nemmeno per uscire, come mi avrebbe fatto notare in albergo un simpaticissimo ebreo di Buenos Aires con il quale ho attaccato bottone. Un’altra cosa strana è che c’è la tomba di Kafka, ma non la visita quasi nessuno. Di fatto, poca gente è a conoscenza di questo dato. Tutti pensano che lo scrittore sia sepolto nel cimitero del ghetto, in centro, vicino alla sinagoga. Ovviamente, all’interno del cimitero ebraico vicino al nostro albergo, la tomba di Kafka è quella più visitata, ma non è di certo come quella parigina di Jim Morrison, a Père Lachaise. Solo qualche lumino e una manciata di pietre della tradizione ebraica posate sulla pietra tombale. Oltre a me e a mia moglie, c’era un ragazzo, un altro mitomane letterario. Girava un video selfie. Il cimitero ebraico si vedeva dalla nostra camera, situata giusto all’altezza della tomba di Kafka, secondo i miei calcoli da agrimensore in linea d’aria. Lungi dall’inquietarmi, la cosa mi è sembrata un privilegio, per quanto un po’ tetro. Non abbiamo nemmeno pagato un plus per la suite “kafkiana”. Insomma, è tutto un regalo, in questo immenso parco tematico che è diventata questa città.

Il 22 agosto abbiamo effettuato il nostro raid incruento su Dresda. Il granturismo che ci
portava offriva Wi-Fi e presa elettrica ogni due posti a sedere per la ricarica
degli smartphone. A bordo si vendevano snacks
e bevande calde e fredde. Ma il grado di civiltà di un qualunque sistema si
deve misurare sulla base della dislocazione, pulizia ed agibilità dei cessi. Il
nostro pullman disponeva di un wc lindissimo. Il nostro pullman era un modello
Flixbus, che è una compagnia tedesca. E così abbiamo attraversato questa
campagna d’Europa piatta, rassicurante, irrigatissima e concimata, interrotta
da un bosco fittissimo una cinquantina di chilometri prima di arrivare a
Dresda. Praticamente una frontiera naturale, diffusa tra il Land della Sassonia
e la Repubblica Ceca. È la regione dei Sudeti: paesini da cartolina, che sanno
già di Germania, con le casette piene di gerani. Anche Hitler, nel ‘38, vedeva
qui gerani dappertutto e credeva che fossero tutti suoi.
Per visitare Dresda abbiamo seguito la mia solita strategia, che consiste nel
camminare in modo estenuante e disordinato la città di turno. In tal modo,
paradossalmente, ma non troppo, aumentano le possibilità di vedere quasi tutto
rispetto a quelle offerte da un tour pianificato. E abbiamo visto quasi tutto
quello che c’era da vedere, con il trait
d’union del Ponte di Augusto tra la città nuova e quella vecchia,
ricostruita dopo i bombardamenti del ‘45. Mi hanno detto che i lavori di
riedificazione -che ancora continuano, come testimonia la presenza di alcune
enormi gru- sono cominciati solo dopo la riunificazione tedesca. L’aspetto
della città durante il periodo della DDR doveva essere spettrale. Quello che
non sa di ricostruito, nella città vecchia, è proprio la vita. Infatti,
contrariamente a Praga o Venezia, nel centro storico di Dresda la gente ci
vive. Forse non ci abita in massa, ma lo frequenta perché lo sente proprio, e i
turisti non sono tantissimi. E mi sono parsi anche molto meno hooliganizzati, i
turisti o gitanti mordi e fuggi come noi, di quelli di Praga (per non parlare
di quelli di Venezia). Forse questa sensazione si deve proprio al fatto che i
forestieri sono diluiti tra i cittadini di Dresda. Questo fa sì che noi
visitatori, se non ingentiliti, risultiamo meno invasivi.
Il problema è che si trattava di visitare tutto in sette ore, col mio sistema.
Credo che ci siamo riusciti, ma dalla gita siamo tornati molto stanchi. E
confusi da tanto barocco. E accecati dall’oro di quelle statue, guglie e chiese
che sembrano teatri. Bisognerà far decantare i fotogrammi della memoria prima
che ci si rivelino e prima di rivelarli. Posso solo dire che la mia impressione
è che Dresda sia bellissima, seppur ricostruita. Io ammiro anche quello, lo
sforzo dell’uomo che ricostruisce, pietra su pietra. Il vero ponte tra la città
vecchia e quella nuova, tra la morte e la distruzione e la nuova vita, resta
l’uomo che raccoglie i cocci. Anche a Francoforte, due anni fa, pensai la
stessa cosa. A Dresda l’ho pensata con maggiore convinzione e chiarezza, perché
maggiore è stata la distruzione e, quindi, più commovente la risurrezione delle
cose. Su tutto, una luce che è una fata turchina.
Il 23 agosto era la nostra ultima giornata praghese. Ci siamo concessi un giro in battello sulla Moldava, prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio mio cugino ci ha fatto visitare Praga 6, il quartiere in cui ha abitato per un periodo assieme alla ex moglie. Per lui è stata una specie di manovra di riavvicinamento al suo passato. Il quartiere è bellissimo, con case sparse sulle pendici della Bílá Hora, cioè la Montagna Bianca, quella della famosa battaglia combattuta all’inizio della Guerra dei Trent’anni. La zona è stata assorbita da Praga, ma fino agli anni ’30 del secolo scorso era un’area di villeggiatura per la ricca borghesia praghese. Lo testimoniano i palazzotti, molti dei quali sono abbandonati, disseminati dappertutto e circondati dai soliti orrori ubiqui: i palazzoni di grigio cemento armato dell’epoca comunista e le orrende villette moderne dei nuovi ricchi, disegnate da architetti senza scrupoli. Tornando su questi luoghi, mio cugino –che abitava in un condominio sobrio, anodino- ha voluto combattere la sua personale battaglia contro i ricordi. E spero che l’abbia vinta. Due anni fa, a Magonza, JA mi costrinse a seguirlo in un altro itinerario di recuperatio loci et memoriae, trascinandomi in una sfiancante passeggiata pomeridiana tra un’autostrada e una collinetta sulla cui sommità c’era lo studentato in cui aveva soggiornato per tre anni una sua ex fidanzata. Rispetto a mio cugino G., JA è più maniacale e ossessivo nelle malinconie e il suo, il nostro, fu un vero pellegrinaggio, comprensivo di visita a un vivaio nel quale la ex ragazza di JA comprava le piante nonché di inchino rispettosissimo e quasi commosso di fronte a un cassonetto dell’immondizia in cui lei andava a buttare la spazzatura. A parte queste differenze, tra la riappropriazione sentimentale di mio cugino e quella di JA ci ho visto la similitudine dell’ascesa su una collina, come a voler significare che è un’operazione che richiede distacco, quella di fare i conti con i ricordi dolorosi. Forse anch’io, un giorno, dovrei risalire qualche K2, solo con l’ossigeno di una presenza amica. La Montagna Bianca di Praga è circondata da uno splendido parco, con un bosco fittissimo, che ho omaggiato di una mia deposizione fecale. Mi sono sentito di nuovo bambino. È stato un grande momento. Mio cugino mi ha invidiato. A lui piacciono queste cose. Certo è che tutta questa poesia bucolica è stata resa possibile solo dalla preveggenza di mia moglie, che aveva due pacchetti di fazzolettini di carta nella borsa. Dopo, siamo scesi di nuovo verso il ristorante del monastero benedettino, dove ci attendevano D. che è un’altra ex fidanzata ceca di mio cugino, e V., sorella della sua ex moglie. Mia moglie e i bambini erano sorpresi da questa facilità che ha mio cugino di convocare ex fidanzate ed ex cognate. Si tratta di donnone robuste, tracannatrici di birra e di ginocchietti di maiale. Siamo stati benissimo in loro compagnia. Lo stomaco, un po’ meno.
Ieri, 24 agosto, ritorno a Madrid. Abbandonare la camera d’albergo,
consegnando le schede magnetiche, pagando gli extra e chiedendo un taxi, è un
gesto sempre maestoso, un bruciare le navi. Soprattutto se sai che tra dieci
minuti esatti avrai voglia di riandare al casso. Invece, non è successo niente,
e il viaggio è trascorso senza intoppi. In aeroporto abbiamo speso le ultime
corone rimasteci, acquistando birra e cioccolata. Nel 1990, quando tornai in
Italia e cercai di cambiare in banca le corone del cambio in nero di Piotr e
dei camerieri d’albergo, il cassiere della Banca del Salento mi rise in faccia.
Anche da questo si misura il cambiamento in meglio o in peggio di un paese. La
Banca del Salento è stata ingloriosamente assorbita dal Monte dei Paschi. La
corona ceca resiste, rafforzata. L’aereo del ritorno era stracolmo. Si è seduto
a fianco a me un obeso, dal forte accento madrileno. Ho pensato che fosse uno
di quelli che vogliono chiacchierare per esorcizzare la paura del volo. “Sei
spagnolo?”, mi ha domandato immediatamente. “Sì”, ho risposto. E lui: “Allora
ci capiremo benissimo”. Subito dopo aver detto queste parole, si è addormentato
di sasso e si è risvegliato a Madrid. Aveva ragione lui: ci siamo capiti
benissimo. Appena arrivati a destinazione, la prima persona conosciuta che
abbiamo incrociato è stata Faustino, il portinaio. Si godeva il fresco e fumava
nell’androne, malgrado sia proibitissimo. Noi non lo rimproveriamo mai. Anzi,
io ho sempre pensato che sia utile tenerselo buono. Prima di partire, oltre
alle chiavi di casa, gli avevo lasciato anche l’abbonamento per la prima
partita in casa dell’Atlético Madrid, visto che si è giocata domenica scorsa
(uno striminzito 1-1 contro il neopromosso Alavés)
e che tutti gli altri miei amici tifosi sono ancora in vacanza.
Mia moglie e i ragazzi sono saliti per primi in
ascensore. Io mi sono attardato per farmi riconsegnare le chiavi e
l’abbonamento da Faustino, che ha esclamato: “Allora non eravate in Italia!!!”
E io: “No, eravamo a Praga…”.
Faustino mi ha ridato le chiavi e ha aggiunto:
”Credevo foste in Italia e mi ero anche domandato
se non vi trovaste nella zona del terremoto…”.
”No, per fortuna…”, gli ho risposto.
Mi ha restituito anche l’abbonamento, e gli ho
letto un lampo di delusione negli occhietti brilli.
Stamattina l’ho incontrato di nuovo, sul portone. Io andavo in palestra. Io e Faustino, lo avrete capito, siamo uniti da una comune, insana passione. Non mi riferisco all’alcol, ma all’Atlético de Madrid. Abbiamo iniziato a parlare della squadra e di Jackson Martínez, il centravanti bidone che abbiamo venduto al Ghuanzou la scorsa stagione. Nel campionato cinese ha fatto due gol in trenta partite. “Io ne avrei fatti almeno venti”, ho gigioneggiato con Faustino. E lui, realista e malinconico: “Lei, forse, sì. Io, sei o sette al massimo…”.Avrei voluto e dovuto abbracciarlo. Mi sono contenuto a stento. Mi sento a casa.