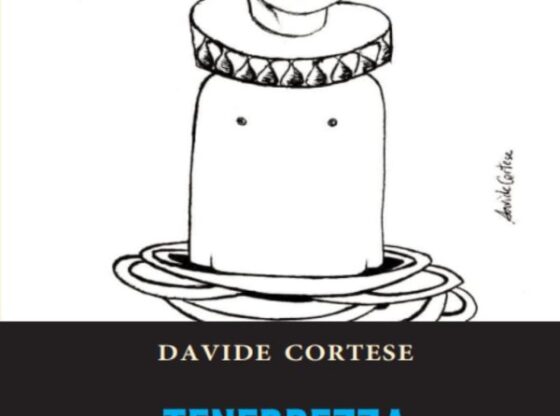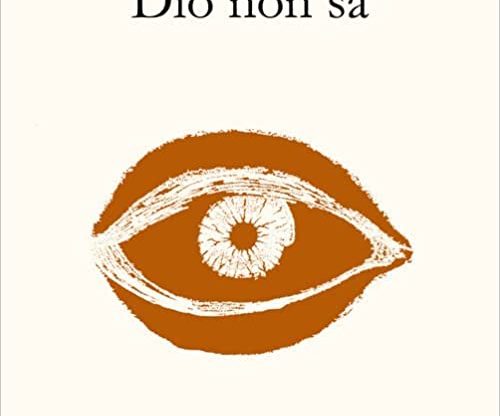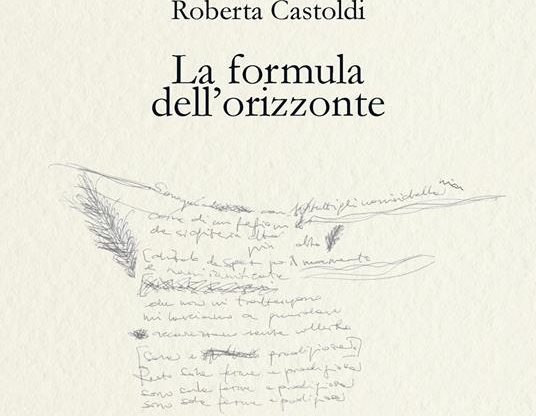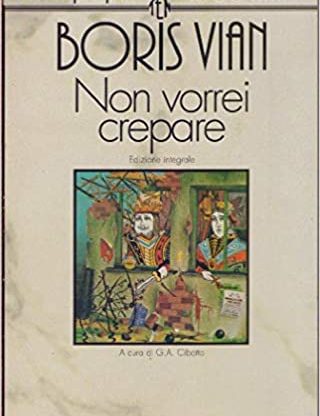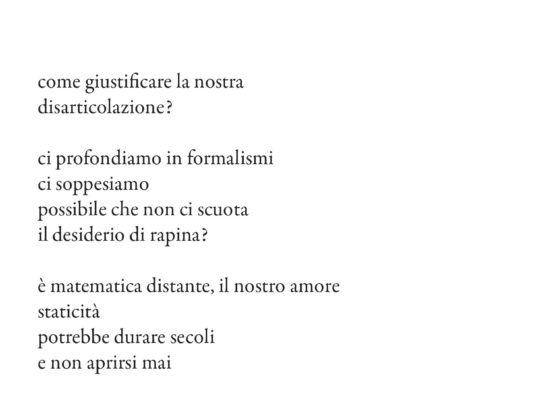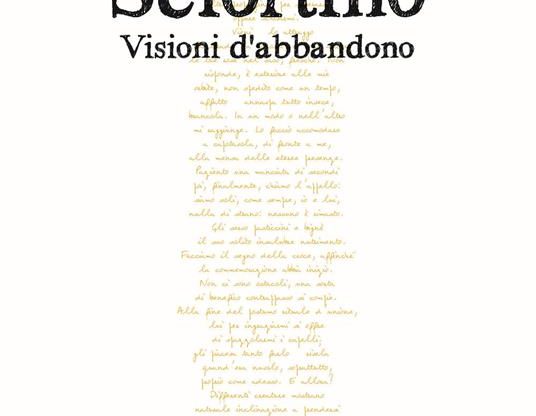Chi dice guerra umanitaria cerca solo di ingannarti. Matteo Moder e le sue Lettere dall’ultimo Novecento.
Di Alessandro Vergari
Nota bene. Questa recensione di Lettere da un qualsiasi esilio, ultima fatica letteraria di Matteo Moder, scrittore triestino che mai si separa da Nina e la sua band, sarà attraversata, ma si potrebbe ben dire disturbata, da un rumore di fondo che non riusciamo a cavarci via dalle orecchie, da stralci del discorso tenuto alla Camera dei Deputati, in data 26 Marzo 1999, dall’allora Presidente del Consiglio, onorevole compagno Massimo D’Alema.
“Signor Presidente, onorevoli colleghi, non infliggerò al Parlamento una lunga replica, dato che – spero che mi scuserete – ho dovuto trattenermi a lungo nella introduzione di questo dibattito per esporre, con la necessaria ricostruzione dei fatti, le ragioni che hanno portato alle scelte difficili e dolorose di questi giorni”. Di quali scelte parla Massimo D’Alema, in uno dei suoi discorsi (post)comunisti più celebri e controversi? L’Italia sta entrando in guerra contro la Serbia governata con nazionalistico pugno di ferro da Slobodan Milošević, definito ‘Il Macellaio’ da tutte le cancellerie d’Europa. Oggetto dello sdegno dell’opinione pubblica internazionale è la repressione in corso in Kosovo, una parte d’Europa e di Balcani che fino ad allora non conosceva quasi nessuno.
Breve excursus. La questione viene da lontano. Nel 1989 la Serbia revoca unilateralmente l’autonomia della provincia a maggioranza albanese, uno status accordatole dal Maresciallo Tito nella convinzione che una Jugoslavia equilibrata avesse come presupposto indispensabile l’indebolimento politico della sua entità territoriale più grande, la Serbia appunto. Milošević, all’apice della gloria, in quel convulso anno segnato dal crollo del muro di Berlino e dai carri armati di Tienanmen, inizia ad agitare la parola d’ordine: riunificazione. Assemblee di popolo sono radunate sotto l’egida di una memoria di sangue, un ricordo intessuto di epica, la battaglia di Kosovo Polje, ovvero la Piana dei Merli, combattuta seicento anni prima dal Regno di Serbia contro le armate ottomane. Una sconfitta cocente divenuta, strumentalmente, la leva dei peggiori sogni di rivalsa patriottici. La Jugoslavia nell’ultimo decennio del Novecento si sfascia e del Kosovo, sempre più sedotto dalle rivendicazioni dei guerriglieri dell’UçK, si perdono le tracce. Finché…
“Siamo divisi tra chi pensa che la forza sia un mezzo estremo ma legittimo nella politica e chi, invece, esclude per ragioni di principio, etiche, politiche o religiose il ricorso alla forza con un atteggiamento che rispetto profondamente e nei confronti del quale mi pongo in una posizione di ascolto e di riflessione”, dice D’Alema davanti a una Camera gremita, “Ma”, in questo MA c’è tutta la convinzione, diciamo, di incarnare le ragioni socialdemocratiche migliori, di essere avanguardia di ragionamenti e pensieri, di essere padre, figlio e spirito hegelianamente collimante con l’unica realtà razionale possibile, di incarnare un principio-responsabilità superiore, “ma questo Parlamento è unanime nella condanna di Milošević… Questo Parlamento è unanime nella solidarietà verso le popolazioni civile colpite”. Si vis pacem, para bellum. La NATO (senza autorizzazione dell’ONU, attenzione!) inizia a sganciare decine e decine di bombe su Belgrado. È la nostra guerra umanitaria.

Ora, però, veniamo al nostro Moder. “L’esilio si piega / a una tazza di caffè / se a proteggerlo / è un addio alla stazione”. Inizia così la prima lettera, poiché di lettere si tratta, scritte tra il marzo e il giugno del 1999 e poi rivisitate in forma di poesia, di canto lirico, di urlo ginsbergiano contro l’ineluttabile stupidità del potere. “Rotaie penso / al di là delle bombe / che illuminano a giorno / la paura / al di là dei dimenticati”. Possiamo immaginare l’autore mentre riscopre, chissà dove, i fogli spiegazzati, solcati da antiche lacrime. Possiamo spiarlo nel momento in cui ride amaramente e provare a stare al suo fianco, discreti, mentre rileva l’improvviso spalancarsi di una vertigine d’insensatezza. Nel 2003 Moder ripensa a quelle righe, incise in dolenti missive. Chi è il destinatario? Un amico? Un nemico? Se stesso? I politici? Quella gran puttana della Storia umana? Ne scaturisce una metamorfosi creativa in versi. La poesia di Moder fotografa i punti di transito tra un prima e un dopo, indaga il fumo acre delle stazioni di frontiera, interroga le sale d’aspetto colme di profughi sbattuti fuori dalle proprie case, raccoglie i sospiri dei sommersi e accarezza le guance dei salvati, balla con la polvere e con il piombo, si specchia nell’incavo di vetri infranti.

L’autore sollecita la risalita della parola, soffocata da un tenebroso oblio, depositata sul fondo della memoria. Moder consegna a frammenti di meditazione la sua presa di (auto)coscienza. A piè di ogni componimento ricama accurate divagazioni, tanto simili a pagine di diari strappati. Sono considerazioni riportate spesso in terza persona, partorite di notte, la stessa notte, o una identica a tante altre, che “annuncia l’impossibilità delle stazioni”, scabre, ironiche righe figlie dell’insonnia, note consecutive, settembrine, frutto della quinta stagione, che per la medicina tradizionale cinese è il momento della maturazione e della rigenerazione.
All’ultimo scampolo di secolo, alla primavera di bellezza socialdemocratica è necessario ritornare. “Ogni guerra è una sconfitta! Il ricorso alla forza è il segno che è stato sconfitto il tentativo di risolvere questo conflitto con la politica, con il dialogo, con lo sforzo paziente e intelligente. Abbiamo fatto abbastanza? È stato chiesto questo ed è stato detto; è un interrogativo legittimo. Noi abbiamo fatto molto”. L’Europa che fa molto è a guida prevalentemente socialista e socialdemocratica. Non solo il redento D’Alema, ansioso di ottenere il perdono dal consesso internazionale per essere stato, vergogna tra le vergogne, comunista, ma anche Lionel Jospin, Gerhard Schröder e Tony Blair. Il motore immobile della terza via del progressismo mondiale è l’ineffabile inquilino seduto alla Casa Bianca, Bill Clinton. Nessuno di loro ha mai letto Il concetto discriminatorio di guerra di Carl Schmitt, nessuno sa che “la distinzione tra guerre giuste e ingiuste porta alla distinzione sempre più profonda e netta, sempre più totale, tra amici e nemici”. O forse sì? “Il mese dei lillà è esploso / in un ospedale della Serbia / l’afa notturna si è unita e affratellata / con gli agnelli / e la Nato ha sudato sangue incompatibile / avvelenando un’altra notte d’Europa”.
Da laggiù, dal cantone ideologico di chi pretende di assumere un punto di vista imparziale, neutrale, in definitiva buono per tutti, proviene la sventura del credo umanitario, l’altare innalzato alla religione dei diritti umani che giustifica l’intervento armato (meglio se aereo, per evitare di far correre rischi inutili al proprio esercito), principio teorizzato da illustri filosofi liberal come Michael Walzer in nome e per conto della ‘supreme emergency’, il pericolo che scaturisce da chi ‘incarna il male nel mondo’ e pertanto deve essere neutralizzato. Kosovo, Afghanistan, Iraq, le esportazioni di democrazia… “Ogni soldato si lascerà alle spalle / un esploso sparato bombardato / fucilato sciroppato saponificato / scannato violentato intombato / deportato fornicato polverizzato”. Il provvidenzialismo democratico scocca la freccia insanguinata, innesca il missile e scarica la bomba che sventra ignari palazzi (compresa, nel caso della guerra contro il boia Milošević, l’ambasciata di un paese terzo nel cuore di Belgrado!). Un augusto Tribunale condanna l’intera popolazione nemica, civili inclusi, a subire una punizione senza appello, comminata da un giudice senza volto.Lamorte discende da sublimi altezze e impatta contro altri esseri umani, non troppo umani, implicati, dolce eufemismo, negli ‘effetti collaterali’. E ne ridesti con geniale ironia, dice in epigrafe Matteo a Francesca, la sua compagna di una vita, che del bombardamento di Belgrado scrisse, dopo averne pianto. Chi dice umanità, non cerca sempre di ingannarti?
“Gli italiani vanno a Pec / Perché è cosa buona e giusta / dovere di D’Alema e fonte di salvezza / per le industrie del Nordest gonfie / di porci maiali negri / che rubano pane e lavoro ai padani”. Amen. E ancora. “Nemmeno i bambini / scrivono più ai bambini. Gli assassini di parole / lavorano al riparo del torto e dell’Ulivo”. E così sia.
La scrittura di Matteo Moder odora di frontiera e di uomini rintanati “al confine della nostalgia”, simili al suo amico Edoardo Giammarughi, giornalista de Il Manifesto inviato a Sarajevo durante l’assedio. “Edoardo / è una traccia di nube / sulla casa devastata / è il guaire del buio / accecato dalle stellette / è il rumore di passi lenti / che cercano il perché che manca / all’abbraccio / sulla soglia della notte”. Il confine è una linea orgogliosamente tracciata su una cartina, cippo divisorio tra Stati asserragliati attorno a un mito fondatore, a un inno, a un despota e nel peggiore dei casi l’un contro armati. Il confine nella nostra epoca è in grado di trasformarsi, di farsi mobile, pervasivo, liquido, attagliato a profili sociali e antropologici indesiderati, così “ti coglie di sorpresa, ti umilia, ti ferisce. Ti trafigge l’anima. Ti costringe a spingere il macigno in cima alla salita, e poi lo fa di nuovo rotolare giù”, scrive il sociologo di origini iraniane Sharham Khosravi. La piccola Rom, scrive Moder, “A Kukes non è stata registrata: / troppo poco albanese / impossibilmente serba / è finita così tra le greggi militari / socialdemocratiche in vacanza in Kosovo”. Se accostiamo “confine” a “frontiera”, la semantica si ingentilisce, il concetto permette aperture. La frontiera è porosa, tessuta da relazioni, incontri, mediazioni e il suo scandalo sta nella possibilità del valico, dell’incursione, eventi iscritti nel suo statuto ontologico. “La notte si sbatte i coglioni / con le carte topografiche”. La post-Jugoslavia inaugurava il festival dei recinti e dei fili spinati, oggi in gran voga. I serbi desideravano serbizzare l’inserbizzabile, espellere, sterilizzare l’impuro. Gli albanesi del Kosovo volevano autodeterminarsi all’interno di un confine-baluardo, sognavano di poter parlare liberamente nell’idioma dei padri, dei nonni, dei fratelli di Tirana. Quando un popolo ha ragione? Quando diventa mostro? Slavoj Žižek condannava il timore irrazionale dei governi europei di fronte ai nascenti stati-nazione balcanici. Necessariamente si dovevano tramutare in regimi incapaci di reggere la democrazia? Slavo uguale europeo inferiore? “Gli esperti internazionali localizzano le fosse / gli inesperti le abitano / i carnefici le metabolizzano chiedendo / pane e lavoro al padrone delle ciminiere / che non vuole più saperne / di Kosovo e di Grande Serbia”.
La Storia, nei versi di queste Lettere da un qualsiasi esilio, pare un infinito campo minato. Mani invisibili regolano i fili e le traiettorie delle vicende collettive e individuali. Milioni, tra profughi e sfollati. Milioni di esseri tarantolati dalla guerra. Il potere reclama il sacrificio dei poveri cristi e il tributo delle persone semplici, i più candidi, i bambini, gli indifesi, famiglie strette nella tenaglia dell’universalismo guerrafondaio e dei nazionalismi impazziti. “Tornano / notturni / i deportati. / Nell’attesa del treno / i topi squittiscono di gioia / per la tana ritrovata / col veleno dappertutto / subdolo, serbo esplosivo”. La Jugoslavia federale e federata, non idealizzata, riappare nelle vesti di fantasma, di spettro, nell’accezione posta da Derrida quando affrontava la virtualità motrice del marxismo, un precipitato della malinconia davanti a futuri non accaduti. “La vecchia Jugo di questa stazione / a corto d’aria per il tanto fumo / che si inanella tra resti di liquori / e mozziconi di vecchie parole / gridata tra lo sferragliar della partenze”. Ancora la frontiera, ancora uno sconfinato amore per l’altrove. Cosa sarebbe stato se… “Lontano è il giorno / quando le mani si stringevano/ qualcuno indugiava sul pianerottolo del vicino / a parlare di calcio / con i bambini in cortile a giocare alla guerra”. Chi scrive questa recensione rimase molto impressionato da un ragazzo di Sarajevo che, nel corso di un’occupazione liceale, anno di grazia 1994 (ah che tempi, il Partito di Plastica, Occhetto, le manette facili facili, Kurt Cobain, che sparava in faccia ad un’intera generazione), venne a raccontare, a noi timidi diciottenni italiani, di stadi appestati d’odio, del nazionalismo convogliato in tifoserie presto mutate, alchimia infernale, nelle squadracce tagliagole.
Non scordiamoci del compagno D’Alema, dov’era rimasto? “Noi dunque opereremo nell’Alleanza Atlantica, nell’Unione Europea, nei rapporti con i nostri alleati”. Moder invoca a tal proposito “Zanzare Nato / pappataci pelosi / mosquitos filoserbi / vespe minate / calabroni cluster-sting / vipere alla puttana Adamo / e vermi / vermi grossi / di un bianco Dio / che ciò l’ha voluto e permesso”. Quanta autentica, sincera esecrazione nei versi di Moder, quanta vitale indignazione e rabdomantica emozione davanti al dolore degli ultimi, quanta devozione ai sacri valori dell’eguaglianza e della fraternità, quante immagini oscillanti tra la gioia e la rassegnazione, tra il diletto e lo sconforto. Che orrore il fascismo, che orrore le piccole patrie! E poi memorie, memorie di teste tagliate, poesie che evocano i demoni della letteratura mitteleuropea, poesie come infiammati breviari mediterranei… “Questa notte / è di Bela Crvka / quattro case kosovare e sette bambini / con un colpo alla nuca / prima di poter immaginare / una sola rondine / di una qualunque primavera”. È una crudezza che squarcia il cuore. “A Belgrado non c’è un nemico che vogliamo distruggere, c’è un Governo che sicuramente ha pesantissime responsabilità e noi vogliamo costringerlo alla pace”, sibila D’Alema. Già, intanto a Trieste e nei porti e lungo le linee dei camminamenti della speranza… “Altri bambini / impauriti e ricciolini / scendono / le banchine italiche della speranza / in fuga dal Kosovo / perché non kosovari / perché non patrioti / perché non e basta / come il treno / al quale nessun ferroviere / attacca i vagoni dell’Orient Express / con il loro carico / di fanciulle dal profumo notturno / innamorato dell’esilio della notte”, scrive Moder nella ventottesima e penultima lettera.
Matteo Moder sigilla la sua raccolta con una postilla. In essa vi è una promessa di speranza. Come interpretare altrimenti la constatazione dell’esule-bambino, che riapre gli occhi sul mondo, colto nel bere “un sorso d’acqua stagnante senza tracce d’assedi” in bar di stazione odorante di cesso? Marinella Salvi, nell’introduzione, scrive “fuori è buio, anche oggi, ma dobbiamo continuare a sapere da che parte stare”. Dal fango, dalla melma occorre ripartire. Perché dal fango, dalla melma anche un fiore di loto può sbocciare.
(Matteo Moder, Lettere da un qualsiasi esilio, Battello Stampatore, 2019)
 Lettere da un qualsiasi esilio
Lettere da un qualsiasi esilio
Poesie
Battello Stampatore
2019