Nel 1966 John Steinbeck accetta l’invito del Newsday a recarsi nel Vietnam del Sud e nell’Asia Sud-Orientale, come corrispondente di guerra. Da almeno un anno il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, suo amico personale, lo pressa in tal senso. Johnson vuole una testimonianza dal fronte, ma Steinbeck è esitante. Ha un timore: essere percepito dal pubblico dei lettori (circa 400.000 al giorno) come un puro strumento di propaganda nelle mani di un’Amministrazione in difficoltà, incapace di rispondere alle crescenti proteste nei confronti di un intervento militare che, da misura di supporto e assistenza all’esercito regolare locale, si è trasformato in una missione ad ampio raggio, con impiego massiccio di truppe di terra, una guerra frontale contro il comunismo, estesa al Vietnam del Nord e da più parti definita “imperialista”. Alla fine lo scrittore premio Nobel viene convinto a partire da Harry F. Guggenheim, direttore del giornale. A dicembre, con la moglie Elaine, prende un aereo alla volta di Saigon. Il figlio John IV, primogenito, richiamato di leva, li attende laggiù. In totale, Steinbeck scrive cinquantotto articoli, sotto la forma fittizia di lettere destinate ad Alicia, la defunta moglie di Harry F. Guggenheim. La casa editrice goriziana LEG ce le presenta, a cura di Thomas E. Barden, nella traduzione di Rossana Macuz Varrocchi.
John Steinbeck si schiera senza se e senza ma a favore della guerra, un atteggiamento quasi acritico che può sorprendere se pensiamo, innanzitutto, alla cornice politico-culturale di quel particolare momento storico. Un vasto fronte di scrittori e di poeti, da Allen Ginsberg a Robert Lowell, da Grace Paley a Norman Mailer, si associa alla protesta, ai contestatori par excellence, Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger, John Lennon, per citare i maggiori protagonisti di un antibellicismo radicale. Certo, non mancano altre voci in controtendenza, oltre a quella di Steinbeck, soprattutto a conflitto iniziato, prima che gli errori, e gli orrori, commessi (anche) dagli americani comincino a filtrare sulle colonne dei giornali di tutto il mondo. John Updike, Jack Kerouac, John Dos Passos, Ralph Ellison sono alcune delle personalità letterarie di spicco che si pronunciano pro-intervento. Per capire le ragioni di una scelta così netta, a tratti perfino condita da entusiasmo battagliero e da autentico disprezzo verso “capelloni”, figli dei fiori et similia, è necessario tenere a mente il background mitico dei meravigliosi romanzi steinbeckiani degli anni Trenta, l’adesione a un orizzonte epico impastato di sudore e di battaglie, di sacrificio e di combattività proletaria.
Ammiratore di Franklin D. Roosevelt negli anni della Grande Depressione, vicino a Harry Truman al termine del secondo conflitto mondiale, elettore di JFK e, come ricordato, fedelissimo di Lyndon Johnson, John Steinbeck non fu mai un marxista o un seguace del collettivismo, anzi, proprio in questi dispacci dal fronte emerge, senza ambiguità, il suo anticomunismo, declinazione del suo ribrezzo verso qualsivoglia sistema totalitario. Dove si regge, quindi, il filo di continuità tra le sue opere e le sue convinzioni politiche? Pensiamo agli okies di Furore, i disgraziati migranti sfrattati da speculatori senza scrupoli, che si battono per lavorare, e per avere un pezzo di terra da coltivare in autonomia, ma (attenzione!) dentro, e non contro, il grande sogno americano. Il nemico sono le banche, gli sfruttatori, i capitalisti disumani, coloro che violentano la dignità umana in nome del profitto. Lo schema, per Steinbeck, è replicabile laddove vi siano oppressi e oppressori. In Vietnam, lo scrittore non ha dubbi, sono i comunisti a schiacciare il popolo, a derubare i propri compatrioti, a impoverire i contadini, a spingere una nazione, che desidera restare libera, verso una situazione di schiavitù ideologica ed economica. In questa ottica, parziale e romantica, i soldati americani, in azione contro i Vietcong, vengono presentati, sottilmente, come gli eredi naturali di quegli eroici uomini in marcia degli anni Trenta. Il sentimento democratico e progressista di Steinbeck è preservato, in queste lettere, ultima curva della sua carriera letteraria, prima della morte sopravvenuta nel 1968, ma, tocca dirlo, ad un costo intellettuale altissimo. Salta agli occhi l’onestà di Steinbeck, un’onestà che va di pari passo con la sua ingenuità. Una narrazione così benevola verso la guerra, simile a uno spot, a un resoconto di giornalisti embedded, potrebbe essere considerato, al pari dell’omicidio di JFK, il canto del cigno dell’innocenza americana, un inno agli ideali di un tempo, destinato a svanire miseramente, nobilissimo perché ricamato da una penna aulica e concreta, uno stile che sa essere elevato nel fango delle descrizioni più crude.
Durante le settimane trascorse a Saigon, al premio Nobel è concesso di salire a bordo delle macchine da guerra dell’esercito americano, elicotteri, ricognitori aerei, e, amaro privilegio, perfino su un aereo da trasporto militare adibito a cannoniera, il famigerato Puff the Magic Dragon, per il quale Steinbeck spende parole di lode, quasi stia assistendo a uno spettacolo pirotecnico o a una manifestazione del sublime kantiano, entusiasmi che provocano le ire furibonde dei pacifisti in patria, e confermano la conclamata familiarità esibita dallo scrittore verso i fucili e le armi in generale, un leitmotiv di queste lettere. “Mi hanno passato dei tappi per le orecchie. Mi avevano detto che il rumore che fanno queste mitragliatrici è qualcosa di unico… La strada principale e quelle secondarie si vedevano bene giù in fondo, e si vedeva una massa curiosamente irreale che si muoveva con un moto ondulatorio simile ad un’ameba sotto un microscopio… Il Puff ha ripreso quota stando su un lato. Avevo imparato a tenere ben aperta la bocca. Il rumore di quelle mitragliatrici è incredibile. È come un immenso macinacaffè, grande come l’Everest, abbinato al trapano del dentista… Dal portellone vedevo un fiume. Un largo fiume di fuoco che sembrava scendere a curve e onde verso terra. Abbiamo sparato e scaricato altri razzi, e poi altri ancora”. È una missiva del 25 febbraio 1967. Una volta sceso dall’aereo, ancora tremante e gonfio di adrenalina, conclusa una missione di cui si sente parte integrante, raggiunge la moglie a cena. Non è Apocalypse Now, ma poco ci manca…
Durante la sua permanenza nel Sudest asiatico, Steinbeck si convince di documentare una guerra di liberazione, in linea con le sue corrispondenze del 1943 dal fronte europeo per conto del New York Herald Tribune. Non si accorge che, agli occhi della popolazione locale, i comunisti non sono paragonabili agli occupanti nazisti e che la stragrande maggioranza dei vietnamiti del sud vive la presenza americana alla stregua di un’occupazione indebita del suolo patrio. Deboli, se non scarse, sono le analisi del colonialismo francese, della corruzione dilagante nell’amministrazione di governo “amica” sudvietnamita, dei contrasti religiosi tra cristiani e buddisti, capitoli che avrebbero meritato ampia considerazione, così come ci saremmo aspettati una valutazione più equa degli effetti della guerra aerea e una riprovazione etica dei side effects, ovvero dei danni “collaterali” dei bombardamenti (leggi: perdita di civili). Il suo giudizio sul nemico è lapidario: “Charley è un figlio di puttana. Il suo obiettivo è dominare la terra e la mente della gente povera, e userà qualsiasi orrore, qualsiasi menzogna o inganno pur di ottenere quello che vuole” (7 gennaio 1967). A parziale discolpa di Steinbeck, è giusto ricordare che il lato peggiore del conflitto sarebbe emerso solo più tardi, dal 1968 in avanti, con il massacro di My Lai, i documenti segreti pubblicati dal The New York Times, la verità sull’incidente nel Golfo del Tonchino, la rivolta plateale dei reduci… La posizione dello scrittore è comunque interessante, perché in essa risuona l’illusione universalistica democratica, il sogno, in nuce, prima che se ne impossessi l’altra cordata, guidata da Bush&Co, di esportazione dei valori occidentali quale unica soluzione per stabilizzare nel nome della libertà popoli e nazioni. Idea che quarant’anni più tardi sarebbe deflagrata in tragedia dopo l’attentato alle Torri Gemelle e la conseguente, insensata invasione dell’Iraq.
Steinbeck crede di assistere a una guerra giusta, vista dalla parte giusta, e invita, non senza punte polemiche, i suoi colleghi contrari alla guerra ad affiancarlo. “Vorrei anche che quegli scrittori andassero nelle zone di combattimento, si sedessero a ridosso dei sacchi di sabbia con i ragazzi che loro chiamano assassini, partissero con gli avieri o, in caso di particolare voglia di avventura, partecipassero a un attacco con il Primo Cavalleria, dove si tocca terra e si corre a cercare riparo. Se poi vorranno davvero sapere qualcosa della paura e del coraggio, auspicherei un pattugliamento notturno del Delta, dove da ogni ciuffo d’erba può partire uno sparo improvviso come un singhiozzo… Se faranno almeno una parte di tutto questo, ti assicuro che dovranno rivedere l’ordine dei loro pensieri e forse correggere alcune loro percezioni della realtà” (Lettera scritta a Bali, il 22 aprile 1967). Steinbeck, cronista di razza, crede, e auspica, di rieducare la platea degli scettici con iniezioni di sano realismo, come se vedere fosse un atto sufficiente per capire. Nelle settimane passate a Saigon, contribuisce attivamente alla risoluzione di problemi operativi, riscontrati dai battaglioni durante le missioni o in fase di ricostruzione dei villaggi, dal dragaggio dei fiumi per scovare mine al trattamento dei liquami, dalla difesa di strutture di comunicazione alla costruzione di scuole in sostituzione di quelle spazzate via dai feroci Vietcong, rilasciando sempre attestati di ammirazione per i militari, bravi ragazzi lontani da casa, capaci anche di ironia, lamentandosi, viceversa, dell’inerzia antipatriottica e pantofolaia dei contestatari. “Devo credere che coloro che marciano per protesta e passano giorni davanti al palazzo dell’ONU o intorno alla Casa Bianca odiano la guerra. Penso di avere più motivi di loro per odiare la guerra. Ma loro si arruolerebbero nel servizio medico? L’addestramento sarebbe veloce e non dovrebbero uccidere nessuno. Se amano tanto la gente, perché non vogliono aiutare a salvarla?” (21 gennaio 1967).
Che John Steinbeck abbia bisogno di rinsaldare i suoi assi cognitivi per inquadrare la situazione, lo dimostrano le maestose descrizioni dell’ambiente naturale del Vietnam meridionale, quasi un paradiso arcadico, scrigno di bellezze potenzialmente redditizie, ma devastato dalla violenza dei Vietcong. “Davanti all’alternarsi del paesaggi qualsiasi agente di viaggio si fregherebbe le mani: chilometri e chilometri di spiagge dorate, mare verde e blu, fiumi sinuosi affollati di barche d’ogni tipo…”, l’altopiano di Pleiku, poi, rivela somiglianza inaspettate, “ha l’aspetto, il profumo e le sensazioni della parte del Panhandle del Texas, o del New Mexico sudorientale”. Steinbeck pesta l’acqua nel mortaio delle analogie. La sua visione manichea, occorre ribadirlo, sconta un desiderio di fedeltà ad antichi miti letterari, è un umanesimo inattuale, puro, sbadato, nobile e infelice. Questo impianto narrativo comincia a incrinarsi solo a mesi di distanza. Il 31 agosto 1967, in una lettera a Elizabeth Otis, amica ed editor, scrive: “Capisco i tuoi sentimenti su questa guerra. Sembra che sprofondiamo sempre più nella melma. È vero, è così. Ormai sono quasi sicuro che quelli che dirigono questa guerra non abbiano né un’idea né il controllo… So che non possiamo vincere questa guerra… Siamo sconfitti da tante direzioni diverse, da tecniche, comportamenti più efficaci dei nostri” (31 luglio 1967). Sono parole gonfie di disincanto. Grazie ai Pentagon Papers sappiamo che gli stessi vertici militari sul campo hanno contezza del fallimento delle operazioni in corso.
Perfino McGeorge Bundy, un generale moderato, equidistante da falchi e colombe, si pronuncia così in un memorandum: “è vero che da inchieste accurate la maggioranza risulta favorevole ai bombardamenti, ma ritengo che questo favore derivi dall’errata convinzione che i bombardamenti siano un mezzo efficace per porre fine alla guerra. Non solo, ma ritengo che chi si esprime contro l’estensione dei bombardamenti sia, tutto sommato, animato da una passione più sincera di chi li vorrebbe” (maggio 1967). Non ci sono altri termini per descrivere il Vietnam: clamoroso errore.
Nel 2002, in piena emergenza terroristica post 11 settembre, il filosofo liberal Michael Walzer torna sull’argomento Vietnam per illustrare il suo concetto (peraltro controverso) di guerra giusta e per ripristinare il valore dello jus in bello, dei confini dell’esercizio bellico e della protezione dei civili: “ora ci sono ragioni di Stato per combattere con giustizia. Si potrebbe quasi dire che la giustizia sia divenuta una necessità militare… non dovremmo combattere guerre sulla cui giustizia nutriamo dubbi, e che, se vi siamo coinvolti, dobbiamo combattere con giustizia, in modo da non renderci ostile la popolazione civile”. Vietnam come spartiacque, sostiene Walzer tra un prima e un dopo, tra il decisionismo acefalo e il ritorno di una ragione politica, inclusiva, nell’esecuzione e gestione dei conflitti armati. Le Lettere ad Alicia di Steinbeck, proprio perché redatte da un uomo sensibile al tema della giustizia, mandano in cortocircuito le ipotesi ragionevoli di un Walzer, o di tanti ultras del pensiero democratico-progressista. L’ideale di una stampa libera, che con limpida onestà e magnanimità comunichi all’opinione pubblica i motivi di fondo di una guerra, i suoi effetti, le possibili strategie da utilizzare, è una bella utopia, destinata a rimanere tale.
Sono le fake news, massima distorsione comunicativa per dirla con Habermas, a veicolare oggi sentimenti di odio verso altri popoli. Non c’è alcuna giustizia nella guerra. C’è interesse, forza, esercizio totale di potere, gusto per la rapina, nei casi peggiori bestialità. L’intelligenza è sempre strategica, mai etica. “Ciò che ho celebrato non è la guerra, ma sono degli uomini coraggiosi”, scrive Steinbeck nella sua ultima missiva da Tokio. No, lo scrittore di Uomini e topi non è un guerrafondaio, semmai un patriota accecato da false illusioni. Oggi forse celebrerebbe gli sforzi di altri uomini coraggiosi, salvatori di vite umane attorno ai nostri mari, e dei novelli okies africani, martoriati da terribili calamità, schiacciati dalla ruota sempre in movimento della Storia, uno scandalo che dura da migliaia di anni.
Alessandro Vergari
(John Steinbeck, Vietnam in guerra. Dispacci dal fronte, LEG Edizioni, 2017)
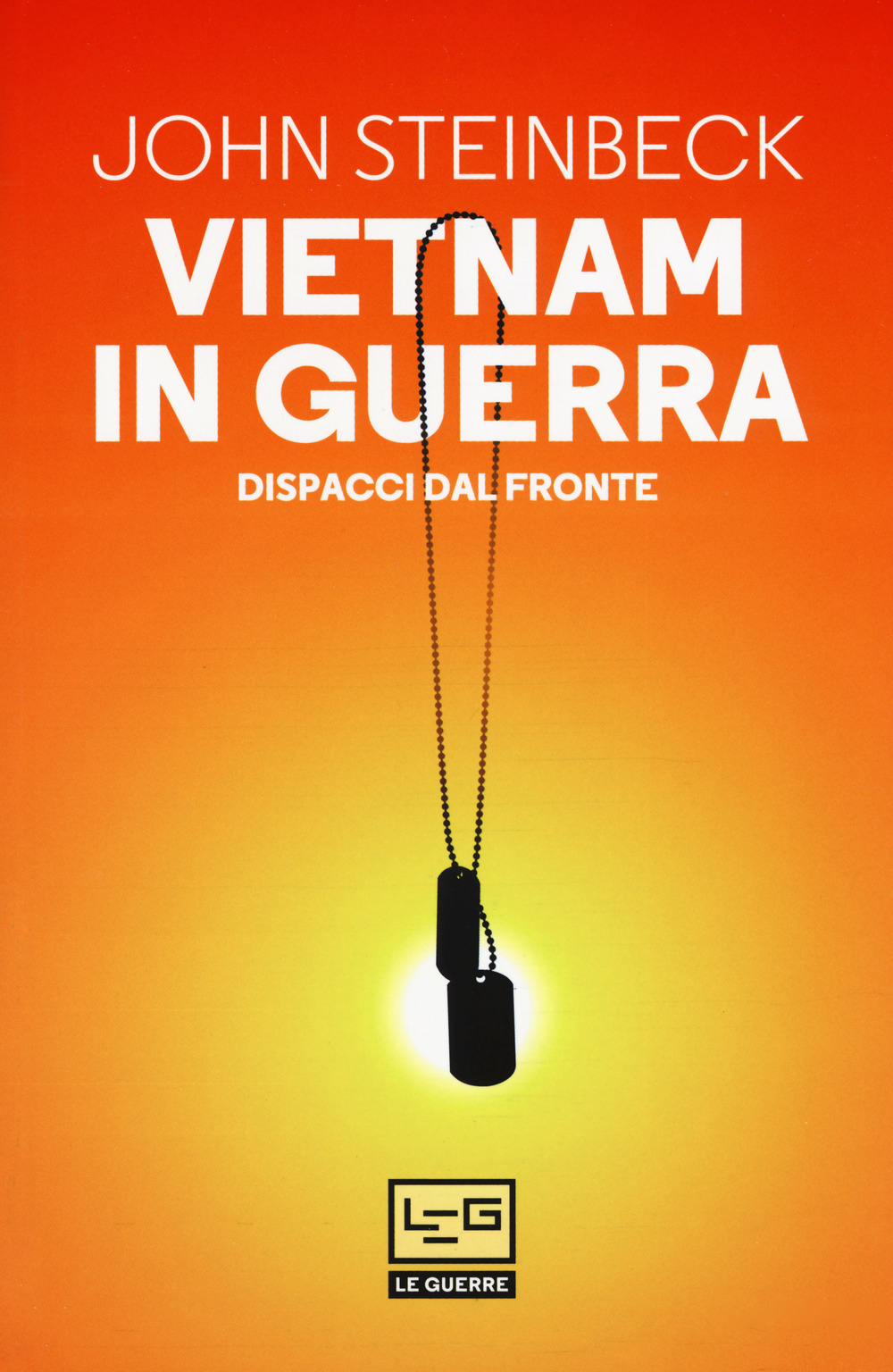 Vietnam in guerra. Dispacci dal fronte
Vietnam in guerra. Dispacci dal fronte
Giornalismo di guerra
Libreria Editrice Goriziana
2017

